 |
ARTICOLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
NEWSLETTER |
|
|
|
|
|
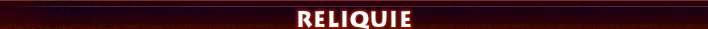 |
|
PREFAZIONE DI SEZIONE CURATA DA
LAURA QUATTRINI |
 La parola reliquia ha
origine dal latino reliquiae - arum
"avanzi, resti" anche di
un morto (der. da
reliquus, "restante",
affine a reliquiere
"lasciare").
Letteralmente significa
ciò che rimane di
qualche cosa, in
particolare i resti di
persona morta. Più
comunemente, si dice, in
senso religioso, dei
resti corporali, oggetti
d'uso, prodotti o tracce
di personaggi
d'importanza religiosa,
o attribuiti ad essi,
custoditi in luoghi
sacri e venerati nel
culto; in particolare,
nella tradizione
cristiana, i resti
mortali del corpo o il
sangue dei martiri della
fede, gli strumenti del
martirio, ecc. Il "culto
delle reliquie" è
presente, in certe
forme, anche presso
diversi popoli
cosiddetti "primitivi".
Fa parte di tali forme
il particolare
trattamento delle ossa o
del cranio sia del
nemico ucciso o
sacrificato (specie
presso i popoli
antropofagi cacciatori
di teste), sia di un
congiunto (ossa del
marito legate al corpo
della vedova; resti del
corpo conservati in
casa, ecc.). In queste
sue forme il culto delle
reliquie è soltanto in
elemento di varie e
complesse ideologie
religiose. Esso acquista
una maggiore autonomia
in quelle civiltà in cui
personaggi di
particolare qualifica
religiosa, soprattutto
il re e lo stregone,
sono oggetto di
venerazione già nella
vita e i loro resti
anche dopo la morte.
Diversi popoli, per
esempio nell'America
Meridionale, nelle isole
Andamane, ecc, hanno la
convinzione che lo
stregone morto continui
a esercitare i suoi
poteri eccezionali e
perciò i suoi resti sono
conservati, portati
dalle tribù nelle
migrazioni o venerati
nelle tombe. Ma, sempre
nelle civiltà primitive,
si riscontrano anche
reliquie di personaggi
mitici, come per esempio
degli antenati totemici
degli Aranda
centro-australiani con
cui si sono messi in
rapporto i "churinga",
oggetti di pietra
sacrosanti, custoditi in
luoghi sacri,
Indubbiamente vi è,
seppure inestricabile,
una chiara confluenza
tra le forme del culto
degli antenati e il mito
delle origini da una
parte e, dall'altra, il
concretarsi di questi
nel culto delle
reliquie, e ciò appare
anche nella religione
greca, e precisamente
nel culto greco degli
eroi. Tra le
innumerevoli reliquie di
eroi greci, realmente
esistiti o mitici,
troviamo, oltre che
resti corporali (tra cui
ossa gigantesche: per es
di Teseo), ogget La parola reliquia ha
origine dal latino reliquiae - arum
"avanzi, resti" anche di
un morto (der. da
reliquus, "restante",
affine a reliquiere
"lasciare").
Letteralmente significa
ciò che rimane di
qualche cosa, in
particolare i resti di
persona morta. Più
comunemente, si dice, in
senso religioso, dei
resti corporali, oggetti
d'uso, prodotti o tracce
di personaggi
d'importanza religiosa,
o attribuiti ad essi,
custoditi in luoghi
sacri e venerati nel
culto; in particolare,
nella tradizione
cristiana, i resti
mortali del corpo o il
sangue dei martiri della
fede, gli strumenti del
martirio, ecc. Il "culto
delle reliquie" è
presente, in certe
forme, anche presso
diversi popoli
cosiddetti "primitivi".
Fa parte di tali forme
il particolare
trattamento delle ossa o
del cranio sia del
nemico ucciso o
sacrificato (specie
presso i popoli
antropofagi cacciatori
di teste), sia di un
congiunto (ossa del
marito legate al corpo
della vedova; resti del
corpo conservati in
casa, ecc.). In queste
sue forme il culto delle
reliquie è soltanto in
elemento di varie e
complesse ideologie
religiose. Esso acquista
una maggiore autonomia
in quelle civiltà in cui
personaggi di
particolare qualifica
religiosa, soprattutto
il re e lo stregone,
sono oggetto di
venerazione già nella
vita e i loro resti
anche dopo la morte.
Diversi popoli, per
esempio nell'America
Meridionale, nelle isole
Andamane, ecc, hanno la
convinzione che lo
stregone morto continui
a esercitare i suoi
poteri eccezionali e
perciò i suoi resti sono
conservati, portati
dalle tribù nelle
migrazioni o venerati
nelle tombe. Ma, sempre
nelle civiltà primitive,
si riscontrano anche
reliquie di personaggi
mitici, come per esempio
degli antenati totemici
degli Aranda
centro-australiani con
cui si sono messi in
rapporto i "churinga",
oggetti di pietra
sacrosanti, custoditi in
luoghi sacri,
Indubbiamente vi è,
seppure inestricabile,
una chiara confluenza
tra le forme del culto
degli antenati e il mito
delle origini da una
parte e, dall'altra, il
concretarsi di questi
nel culto delle
reliquie, e ciò appare
anche nella religione
greca, e precisamente
nel culto greco degli
eroi. Tra le
innumerevoli reliquie di
eroi greci, realmente
esistiti o mitici,
troviamo, oltre che
resti corporali (tra cui
ossa gigantesche: per es
di Teseo), ogget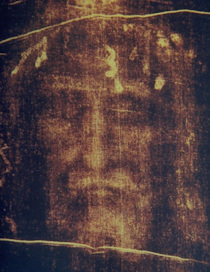 ti d'uso
(armi strumenti
musicali, ornamenti),
case d'abitazione ecc. ;
esistono anche reliquie
di animali, ma solo in
quanto connessi con gli
eroi. Anche divinità
vere e proprie possono
avere reliquie: a Delfi
si mostrava la tomba di
Dioniso e la pietra che
Crono avrebbe
inghiottito in luogo del
proprio figlio, Zeus.
Già nell'antico Egitto
alle parti del corpo di
Osiride si attribuivano
tombe diverse; un altro
culto di reliquie
egiziano era quello dei
tori Apis che avevano un
cimitero particolare. Il
culto delle reliquie
assume un nuovo
significato nelle
religioni fondate in
tempi storici qual'è,
per es. (a parte il
cristianesimo), il
buddismo: le reliquie
del fondatore o dei
grandi discepoli sono
oggetto di venerazione.
Il corpo del Buddha
sarebbe stato diviso in
otto parti distribuite a
otto re che le avrebbero
custodite in edifici
appositamente costruiti
("stupa"); uno di questi
("Pipravo-stupa") sembra
effettivamente di poco
posteriore all'epoca
della morte del Buddha.
Già un'incarnazione
precedente del Buddha
avrebbe lasciato
reliquie cui il re Asoka
fece erigere, molti
secoli dopo, uno stupa.
Il culto buddistico
delle reliquie si è
diffuso a Ceylon, nella
Cina, nel Tibet; in
quest'ultimo luogo le
reliquie dei singoli
Grandi Lama sono oggetto
di venerazione. Molto
meno intenso è il culto
delle reliquie
nell'islamismo, dove
tutta via l'"asar" (la
barba di Maometto), che
nessuno doveva vedere,
era oggetto di culto:
ogni sultano lo
venerava, a
Costantinopoli,
all'inizio del proprio
regno. La complessità
dei fatti sconsiglia
un'interpretazione
unilaterale del culto
delle reliquie, qual'era
quella preanimistica,
secondo cui la forza
particolare dei
personaggi eccezionali
sarebbe ritenuta
efficiente anche nei
loro resti corporali, o
quella manistica,
secondo cui il culto
generale dei morti si
sarebbe, col tempo,
limitato ai morti di
particolare importanza.
In nessun caso si può
prescindere
nell'interpretazione
della tendenza
caratteristica della
religione a legare ora a
un periodo di tempo, ora
a un luogo, a formule o
a oggetti, determinati
significati in modo da
rendere possibile la
loro rievocazione. Nel
cristianesimo, dal sec.
4° in poi, la voce
reliquia venne usata non
soltanto per i resti
mortali del corpo o per
il sangue dei martiri
della fede, ma anche per
parti degli strumenti
del martirio o
considerati come tali
(le catene di S. Pietro,
di S. Paolo, la
graticola di S. Lorenzo,
ecc.), per pezzi de ti d'uso
(armi strumenti
musicali, ornamenti),
case d'abitazione ecc. ;
esistono anche reliquie
di animali, ma solo in
quanto connessi con gli
eroi. Anche divinità
vere e proprie possono
avere reliquie: a Delfi
si mostrava la tomba di
Dioniso e la pietra che
Crono avrebbe
inghiottito in luogo del
proprio figlio, Zeus.
Già nell'antico Egitto
alle parti del corpo di
Osiride si attribuivano
tombe diverse; un altro
culto di reliquie
egiziano era quello dei
tori Apis che avevano un
cimitero particolare. Il
culto delle reliquie
assume un nuovo
significato nelle
religioni fondate in
tempi storici qual'è,
per es. (a parte il
cristianesimo), il
buddismo: le reliquie
del fondatore o dei
grandi discepoli sono
oggetto di venerazione.
Il corpo del Buddha
sarebbe stato diviso in
otto parti distribuite a
otto re che le avrebbero
custodite in edifici
appositamente costruiti
("stupa"); uno di questi
("Pipravo-stupa") sembra
effettivamente di poco
posteriore all'epoca
della morte del Buddha.
Già un'incarnazione
precedente del Buddha
avrebbe lasciato
reliquie cui il re Asoka
fece erigere, molti
secoli dopo, uno stupa.
Il culto buddistico
delle reliquie si è
diffuso a Ceylon, nella
Cina, nel Tibet; in
quest'ultimo luogo le
reliquie dei singoli
Grandi Lama sono oggetto
di venerazione. Molto
meno intenso è il culto
delle reliquie
nell'islamismo, dove
tutta via l'"asar" (la
barba di Maometto), che
nessuno doveva vedere,
era oggetto di culto:
ogni sultano lo
venerava, a
Costantinopoli,
all'inizio del proprio
regno. La complessità
dei fatti sconsiglia
un'interpretazione
unilaterale del culto
delle reliquie, qual'era
quella preanimistica,
secondo cui la forza
particolare dei
personaggi eccezionali
sarebbe ritenuta
efficiente anche nei
loro resti corporali, o
quella manistica,
secondo cui il culto
generale dei morti si
sarebbe, col tempo,
limitato ai morti di
particolare importanza.
In nessun caso si può
prescindere
nell'interpretazione
della tendenza
caratteristica della
religione a legare ora a
un periodo di tempo, ora
a un luogo, a formule o
a oggetti, determinati
significati in modo da
rendere possibile la
loro rievocazione. Nel
cristianesimo, dal sec.
4° in poi, la voce
reliquia venne usata non
soltanto per i resti
mortali del corpo o per
il sangue dei martiri
della fede, ma anche per
parti degli strumenti
del martirio o
considerati come tali
(le catene di S. Pietro,
di S. Paolo, la
graticola di S. Lorenzo,
ecc.), per pezzi de gli
abiti portati dai santi,
per oggetti che avessero
toccato la tomba di un
martire o usati per
onorarne la tomba. Un
altro genere di
reliquie, quelle
relative alla vita
terrena di Gesù, furono
importate dai luoghi
santi di Palestina. Il
culto delle reliquie
prese origine e si
sviluppò in modo
parallelo al culto dei
martiri nell'antichità e
fu in uso in tutta la
Chiesa. In Oriente la
traslazione di reliquie
e l'uso molto diffuso di
usare i resti dei corpi
dei martiri come
reliquie non
incontrarono difficoltà;
in Roma, invece, e in
Occidente, si conservava
la disciplina primitiva
per la quale, il
sepolcro di un marte non
poteva essere aperto nè
si potevano separare
particelle del suo
corpo; però nel sec. 8°
si cominciò ad
asportarne anche nella
Chiesa latina. Il
cambiamento è in
relazione con la
traslazione dentro la
città di Roma delle
reliquie dei morti dalle
loro sepolture primitive
nei cimiteri fuori le
mura. In tale occasione
si cominciò a staccare
parte delle ossa per
deporle in cappelle o
chiuderle dentro altari.
Roma era la città santa
per il gran numero di
celebri martiri che vi
avevano le loro tombe.
Un certo numero di essi
vennero trasportati in
Francia e in Germania,
dove sontuose chiese
furono fondate per le
loro reliquie. Nel sec.
9° cominciò l'uso di
mettere le reliquie non
più dentro altari, ma in
reliquiari per poterle
esporre alla venerazione
dei fedeli. All'epoca
della crociate venne in
Occidente una ricca
messe di reliquie dalla
Terrasanta, ma non
possono essere ritenuta
nella loro maggioranza
come autentiche. Nel
1204 molte reliquie
conservate in
Costantinopoli vennero
portate in Europa e
varie città italiane,
come Venezia, Amalfi,
Bari, ecc., ebbero parte
a queste traslazioni. Un
nuovo impulso alla
venerazione delle
reliquie fu dato dalla
scoperta delle catacombe
di Roma nella seconda
metà del sec. 16°. Il
protestantesimo nelle
sue varie forme rigettò
sia il culto dei santi e
delle loro reliquie. Più
tardi (1669) la
direzione e la
sorveglianza di esse fu
affidata alla S.
Congregazione delle
indulgenze e delle
reliquie, la quale
nell'anno 1904 fu
riunita con la S.
Congregazione dei riti.
Attualmente il culto
delle reliquie è
disciplinato dagli
articoli 1276-1289 del "Codex
iuris canonici": possono
onorarsi con culto
pubblico solo quelle
reliquie la cui
genuinità consti da un
documento rilasciato da
un cardinale,
dall'ordinario del luogo
o da altro ecclesiastico
cui, per indulto
apostolico, sia stata
concessa facoltà di
autenticare la reliquia;
la compra e la vendita
di reliquie sono
severamente proibite. gli
abiti portati dai santi,
per oggetti che avessero
toccato la tomba di un
martire o usati per
onorarne la tomba. Un
altro genere di
reliquie, quelle
relative alla vita
terrena di Gesù, furono
importate dai luoghi
santi di Palestina. Il
culto delle reliquie
prese origine e si
sviluppò in modo
parallelo al culto dei
martiri nell'antichità e
fu in uso in tutta la
Chiesa. In Oriente la
traslazione di reliquie
e l'uso molto diffuso di
usare i resti dei corpi
dei martiri come
reliquie non
incontrarono difficoltà;
in Roma, invece, e in
Occidente, si conservava
la disciplina primitiva
per la quale, il
sepolcro di un marte non
poteva essere aperto nè
si potevano separare
particelle del suo
corpo; però nel sec. 8°
si cominciò ad
asportarne anche nella
Chiesa latina. Il
cambiamento è in
relazione con la
traslazione dentro la
città di Roma delle
reliquie dei morti dalle
loro sepolture primitive
nei cimiteri fuori le
mura. In tale occasione
si cominciò a staccare
parte delle ossa per
deporle in cappelle o
chiuderle dentro altari.
Roma era la città santa
per il gran numero di
celebri martiri che vi
avevano le loro tombe.
Un certo numero di essi
vennero trasportati in
Francia e in Germania,
dove sontuose chiese
furono fondate per le
loro reliquie. Nel sec.
9° cominciò l'uso di
mettere le reliquie non
più dentro altari, ma in
reliquiari per poterle
esporre alla venerazione
dei fedeli. All'epoca
della crociate venne in
Occidente una ricca
messe di reliquie dalla
Terrasanta, ma non
possono essere ritenuta
nella loro maggioranza
come autentiche. Nel
1204 molte reliquie
conservate in
Costantinopoli vennero
portate in Europa e
varie città italiane,
come Venezia, Amalfi,
Bari, ecc., ebbero parte
a queste traslazioni. Un
nuovo impulso alla
venerazione delle
reliquie fu dato dalla
scoperta delle catacombe
di Roma nella seconda
metà del sec. 16°. Il
protestantesimo nelle
sue varie forme rigettò
sia il culto dei santi e
delle loro reliquie. Più
tardi (1669) la
direzione e la
sorveglianza di esse fu
affidata alla S.
Congregazione delle
indulgenze e delle
reliquie, la quale
nell'anno 1904 fu
riunita con la S.
Congregazione dei riti.
Attualmente il culto
delle reliquie è
disciplinato dagli
articoli 1276-1289 del "Codex
iuris canonici": possono
onorarsi con culto
pubblico solo quelle
reliquie la cui
genuinità consti da un
documento rilasciato da
un cardinale,
dall'ordinario del luogo
o da altro ecclesiastico
cui, per indulto
apostolico, sia stata
concessa facoltà di
autenticare la reliquia;
la compra e la vendita
di reliquie sono
severamente proibite. |
|
|