|
La Sindone è un lenzuolo
in lino cucito a “spina
di pesce” di 442
centimetri di lunghezza
per 113 di larghezza
conservato nella
cappella del Guarini,
vicino al Duomo di
Torino. Presenta,
stampata come se fosse
il negativo di una
fotografia, l’immagine
di un uomo con barba e
capelli lunghi: in
questa immagine, molti
hanno visto impresso,
per qualche misterioso e
divino motivo, il volto
di Gesù Cristo. Insomma,
la Sindone sarebbe il
sudario di Cristo, il
lenzuolo nel quale
sarebbe stato avvolto
dopo la Crocifissione ed
abbandonato nel sepolcro
dopo l’Ascensione. Prima
di vedere quali siano i
motivi che fanno a
supporto di questa
“teoria”, è opportuno
tracciare una breve
storia di questo telo,
ripercorrendo le tappe
che l’hanno o
l’avrebbero portato
dalla Palestino a
Torino. Non abbiamo
testimonianze, nelle
Scritture, di ciò che
accadde al sudario di
Cristo dopo
l’ascensione. Ciò è
dovuto al fatto che, in
abiente giudaico, ogni
indumento o oggetto
venuto a contatto con un
cadavere era considerato
impuro. E' quindi
plausibile che, per
salvare il telo, i
discepoli abbiano
nascosto la reliquia.
Una ricerca che sembra
avvalorare questa
ipotesi è stata condotta
dal prof. Michele
Salcito, secondo il
quale le macchie d'acqua
più vistose, causate
dall'acqua utilizzata
per spegnere l'incendio
di Chambery, non
corrisponderebbero al
sistema di piegatura del
telo in quell'occasione,
ma ad una piegatura
"grossolana" e
frettolosa fatta per
inserire il lenzuolo in
una giara di terracotta
del I secolo. Da un
Vangelo Apocrifo, però,
sappiamo che Gesù,
resuscitato, consegnò la
Sindone ad un servo del
sacerdote del Tempio.
Nel 33 d.C., a
Gerusalemme, il lenzuolo
diventa subito oggetto
dell’adorazione dei
fedeli, che lo
custodiscono per più di
500 anni. Nel 544,
infatti, il telo si
sposta a Edessa, in
Turchia meridionale,
dove, le cronache
riportano, si ha la
prima apparizione di
un’immagine “non fatta
da mano d’uomo”: la sua
esposizione è ancora
parziale, viene mostrata
solo la parte frontale,
quella recante
l’immagine del volto.
L’identità della Sindone
si confonde, qui, con
quella di un altro
oggetto simile, recante
l’immagine del volto di
Cristo: il Mandylion,
che, vuole la leggenda,
sarebbe un fazzoletto (mandylion
in greco) sul quale Gesù
impresse il suo volto.
L’ipotesi che un
“fazzoletto” sarebbe la
Sindone è spiegabile con
l’ipotesi che il
lenzuolo fosse piegato
in maniera tale da
mostrare solo il volto.
Da Edessa, i bizantini
la portano a
Costantinopoli, dove
viene esposta
integralmente. Nel corso
del XIII secolo
nell’arte bizantina la
raffigurazione della
morte di Cristo e della
sua deposizione nel
sepolcro si modifica:
vengono raffigurate
caratteristiche che
sembrano sottintendere
la conoscenza di
particolari della Sacra
Sindone. Qui rimane fino
al 1204, quando i
crociati entrano in
città e la saccheggiano.
Il soldato crociato
Robert De Clari riportò,
nella sua cronaca, di
aver visto “la Sindone
del Signore”, “la figura
di nostro Signore”,
conservata nella chiesa
di Santa Maria delle
Blacherme. Cosa succeda
alla Sindone tra il XIII
secolo ed il XIV rimane
un mistero. Un documento
del 1204, conosciuto
soltanto in una copia
ottocentesca tratta da
una copia antica andata
dispersa durante la II
Guerra Mondiale, ci fa
ipotizzare che la
Sindone, nel suo lungo
peregrinare per il
Mediterraneo, abbia
compiuto anche tappa ad
Atene: si tratta di una
lettera indirizzata di
Teodoro Angelo, parente
dei deposti imperatori
bizantini, a Papa
Innocenzo III
all’indomani del sacco
di Costantinopoli. Nella
missiva, Teodoro Angelo
si scaglia contro il
comportamento dei
crociati, conquistatori
e razziatori senza
scrupoli e senza
rispetto per gli oggetti
sacri, tra cui la
Sindone, che egli sapeva
essere conservata ad
Atene. Il nuovo signore
feudale di Atene, nel
1204, è Ottone de La
Roche, uno dei capi
della crociata, che
durante la presa di
Costantinopoli ebbe il
quartiere dove sorgeva
la chiesa delle
Blacherne, dove era
custodita la Sindone. Il
telo ricompare poi nel
1353 in Francia, a Lirey,
donata a Geoffrey de
Cherny, grande generale
francese, dopo un
successo conseguito in
battaglia. Il nuovo
“padrone” della Sindone
era parente, si diceva
all’epoca, di un
Cavaliere Templare e
proprio i Templari,
vuole la tradizione,
adoravano il viso di un
uomo con la barba. E’
dello stesso periodo
storico un dipinto,
presente a Templecomb,
raffigurante un volto
molto somigliante a
quello della Sindone,
posto su un pannello di
legno: sarebbe stato il
coperchio, si dice, del
contenitore della
Sindone. Alla sua morte,
avvenuta nella battaglia
di Poitiers, il 19
settembre 1356, si
scatenò una disputa sul
possesso della reliquia
tra il figlio di
Geoffrey de Charny ed i
canonici di Lirey ed il
vescovo di Troyes, nella
quale disputa venne
coinvolto anche
l’antipapa avignonese
Clemente VIII. A metà
del XV secolo,
Marguerite de Charny
ritirò la Sindone dalla
chiesa di Lirey, dove
era custodita, e la
portò con sé attraverso
l’Europa. Nel 1452 il
lenzuolo viene ceduto a
Ludovico di Savoia, alla
famiglia del quale erano
stati legati sia il
padre della nobildonna,
sia il suo secondo
marito, Umbert de La
Roche. La famiglia
Savoia stabilisce che la
si conservi a Chambéry,
capitale dell’allora
ducato di Savoia. A
partire dal 1471, Amedeo
IX detto “il Beato”,
figlio di Ludovico,
decise di collocare
Sindone nella chiesa
francescana di Chambery.
In seguito, la Sindone
venne definitivamente
riposta in un’urna
d’argento in una nicchia
della sagrestia della
Sainte Chapelle du
Saint-Suaire. I Savoia,
nel 1502, chiesero ed
ottennero dal Papa il
riconoscimento di una
festa liturgica
apposita, per la quale
fu scelto il 4 maggio.
Nel 1532, precisamente
il 4 dicembre, il
sudario rischia di
venire distrutto da un
incendio sviluppatosi
all’interno della Sainte
Chapelle: saranno le
suore clarisse, nel
1534, a ripararla con
toppe triangolari.
L’inizio della guerra
tra Francesco I e Carlo
V, nel 1536, costringe
il duca di Savoia a
fuggire portando con sé
la Sindone: la Sindone
passa per Torino,
Milano, Nizza, Vercelli,
per fare poi ritorno
ufficialmente nella
Sainte-Chapelle di
Chambéry il 4 giugno
1561, in seguito alla
pace di Caveau-Cambrésis,
che permetteva al nuovo
duca Emanuele Filiberto
di riottenere i suoi
Stati. Nel 1578 i Savoia
la fanno trasportare a
Torino, nuova capitale
del ducato, e la fanno
porre nella cappella del
Guarini, sua attuale
sede. Questo, si dice,
più che altro per
abbreviare il viaggio
dell’arcivescovo Carlo
Borromeo, che da Milano
voleva recarsi ad
adorare la Sacra Sindone
a piedi, in base ad un
voto fatto in occasione
della peste del 1576.
Inizialmente, la Sindone
fu collocata nella
chiesa di San Francesco
d’Assisi; in seguito fu
spostata nella cappella
ducale dedicata a San
Lorenzo. Nel 1583 fu
trasferita in una
cappella rotonda
dell’antico palazzo
ducale e, nel 1587,
venne collocata in
un’edicola del duomo. II
1 giugno 1694 la Sindone
fu collocata nella
cappella della Sindone
nell’altare-reliquiario
ideato da Antonio
Bertola. Sarà quella la
sua sede fino al 1996,
quando, in occasione dei
lavori di restauro della
cappella, fu collocata
nel coro del duomo. Fu,
questo, un fatto
provvidenziale, in
quanto le permise di
scampare all’incendio
scoppiato tra l’11 e il
12 aprile 1997. Nel 1706
la Sindone fu spostata
momentaneamente a
Genova, a causa
dell’avvicinarsi dei
francesi, che si
accingevano ad assediare
la città. Ancora, tra il
1939 ed il 1946, in
previsione dei fatti
della Seconda Guerra
Mondiale, fu trasportata
nel santuario di
Montevergine, presso
Avellino. Nel 1983, su
volere testamentario di
Umberto II, viene donata
al Vaticano. A questo
punto, è opportuno
analizzare da vicino
questo lenzuolo, per
comprendere quali siano
i dettagli che lo fanno
ritenere il sudario di
Cristo. Questa è
l’immagine totale della
Sindone.
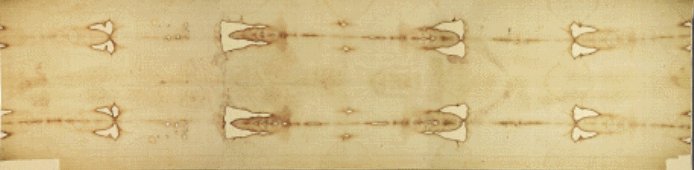
Un’analisi condotta più
da vicino aiuta a
riconoscere particolare
importanti. Partiamo dal
busto, anteriore e
posteriore:
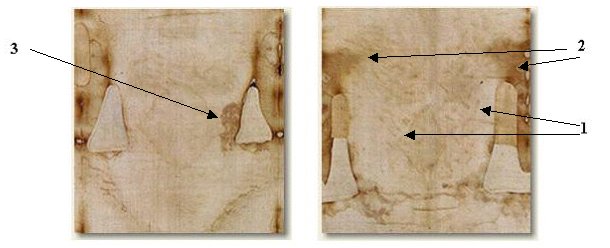
Tronco dorso presentano
moltissime ecchimosi
escoriate di forma
tondeggiante
(1):
potrebbero essere
lesioni provocate dal
flagrum taxillatum,
strumento di tortura
costituito da un manico
corde al termine delle
quali sono fissati dei
piccoli piombi a forma
di manubrio affiancati a
due a due. Su entrambe
le zone scapolari si
possono osservare
ecchimosi a forma
quadrangolare
(2),
provocate da un oggetto
che può essere
identificato con il
patibulum, l’asse
orizzontale della croce
che il condannato
portava su di sé sino al
luogo dell’esecuzione.
Sul fianco destro del
petto si nota una grande
chiazza di sangue
(3)
che fuoriesce da una
ferita di forma ovoidale
all’altezza del quinto
spazio intercostale. Le
caratteristiche di
questa ferita (che
presenta, sul tessuto,
un alone sieroso
costellato da macchie
rossastre, come avviene
per il sangue uscito da
un cadavere in cui la
parte sierosa si è già
separata da quella corpuscolata) mostrano
che essa fu provocata
dopo la morte dell’uomo.
Continuiamo con gli arti
superiori.
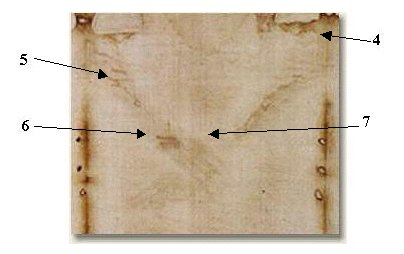
L’immagine delle braccia
non è più visibile a
causa della strinatura
del tessuto dovuta
all’incendio di Chambéry.
Gli arti, comunque, sono
distesi, con una leggera
flessione
(4) verso
l’interno per la
contrazione
dell’articolazione del
gomito. Sono visibili
lunghe macchie di sangue
(5), colato
probabilmente dalle
ferite presenti sul
dorso. La mano sinistra
è sovrapposta alla
destra: sul polso è ben
visibile una
caratteristica chiazza
di sangue
(6), formata
da due colature
divergenti, il cui
angolo è riferibile alle
due diverse posizioni
del condannato sulla
croce: accasciata e
sollevata. Il sangue
fuoriesce dal polso da
una ferita di forma
ovale, riconducibile
alla lesione da uno
strumento da punta, come
può essere un chiodo. La
ferita provocata dal
chiodo, dunque, non è
collocata sul palmo, ma
sul polso, esattamente
in uno spazio libero tra
le ossa del carpo,
chiamato “spazio di Destot"; il chiodo,
penetrando nel polso, ha
anche reciso il nervo
mediano. La scelta di
inchiodare le braccia in
quel punto è dettata da
motivi di stabilità e
fissaggio sulla croce: i
tessuti del palmo della
mano non possono reggere
il peso del corpo senza
lacerarsi. Tale pratica
è stata anche confermata
dal ritrovamento, vicino
Gerusalemme, dello
scheletro di un
crocifisso del I secolo.
Concludiamo la nostra
analisi con gli arti
inferiori, visti da
davanti e da tergo.
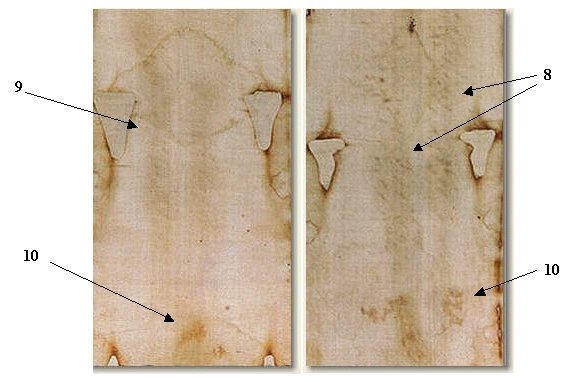
Sono evidenti i
caratteristici segni del
flagello
(8), la forma
dei quali è già stata
descritta in precedenza.
Entrambe le ginocchia
presentano delle
escoriazioni
(9), molto
probabilmente dovute a
cadute: in
corrispondenza di questi
punti e sulle piante dei
piedi sono state
individuate tracce di
terriccio. Il ginocchio
sinistro è stato fissato
dal rigor mortis in
posizione più flessa
rispetto al destro, e
perciò l’arto sinistro
risulta nell’immagine
più corto del destro.
Nell’immagine
posteriore, i piedi sono
ben visibili, mentre su
quella anteriore risulta
evidente una macchia di
sangue, ma non
l’impronta dell’arto.
Tutto questo è dovuto al
fatto che il piede
sinistro, al momento di
piantare il chiodo,
sovrastava il destro,
che era a contatto con
la croce. Sulla pianta
del piede destro si nota
il foro di uscita del
chiodo
(10),
dal quale partono rivoli
di sangue verso le dita,
mentre altri scendono
verso il calcagno: è
probabile che siano
fuoriusciti al momento
della deposizione,
quando il corpo si
trovava in posizione
supina. Veniamo ora al
viso. Questa è la
visione che ne abbiamo
direttamente come appare
sul tessuto.
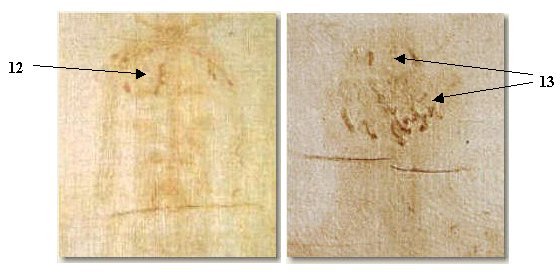
Queste, invece, sono le
immagini “trattate”,
“positivo” e “negativo”.
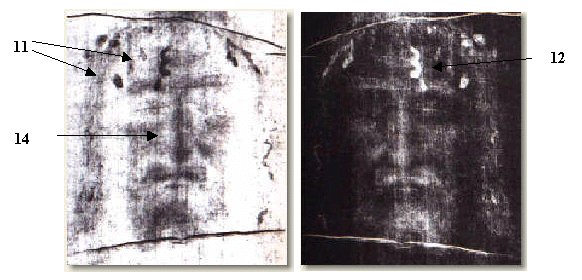
E’ evidentemente il
volto di un uomo
picchiato: si possono
notare tumefazioni,
lividi, macchie di
sangue
(11) (famosa è la
macchia a forma di 3
rovesciato
(12), la cui
forma dipende dalla
rughe d’espressione
della fronte); sulla
fronte, sulla nuca e
lungo i capelli,
disposte a raggiera
intorno al capo, sono
evidenti numerose
macchie di sangue ad
andamento sinuoso
(13),
sangue fuoriuscito da
ferite da punta di
piccolo diametro. Il
naso è leggermente
storto
(14), a causa,
forse, di una frattura.
La Sindone, da sempre,
lascia stupiti e
perplessi tutti coloro
che vi si avvicinano. E’
davvero il volto di
Cristo? O si tratta di
una delle tante
mistificazioni di
oggetti sacri realizzate
nel Medio Evo? I pareri
divergono. E le analisi
che vengono condotte ad
intervalli irregolari da
studiosi o pseudo-tali
non aiutano di certo,
visto che, puntualmente,
emergono fatti nuovi a
suffragare l’una o
l’altra ipotesi. Vediamo
i fatti. Una prima
“scoperta” che pare
avvallare l’autenticità
del lenzuolo viene
fatta, per caso, nel
maggio del 1898 da un
avvocato con la passione
per la fotografia, tale
Secondo Pia. Una
fotografia del telo,
fatta dell’uomo durante
la sua ostensione,
mostrava il volto
“positivo” di un uomo e
non, come logica
suggerirebbe, il
“negativo”. Questo
voleva dire che era la
figura sul telo ad
essere in “negativo”, il
che significava, ancora,
un eventuale falsario
medioevale aveva
volontariamente dipinto
i lenzuolo in
“negativo”. Cosa poco
probabile, visto che
l’invenzione della
camera oscura era
parecchio successiva.
Questo, però, non fu
sufficiente a far
desistere i sostenitori
della teoria del
“dipinto”. Nel 1939 il
professor Romanese, per
esempio, dimostrò che un
corpo trattato con aloe
e mirra è in grado di
lasciare sul tessuto di
lino un’impronta simile
a quella della Sindone.
L’esperimento pratico
condotto dal professore,
in effetti, portò a
questo risultato,
tuttavia senza la
perfezione di
impressione che si nota
sulla Sindone. Nel 1969,
ancora, Noemi Gabrielli,
soprintendente delle
Gallerie ed opere d’arte
medioevali in Piemonte,
affermò che il corpo di
Gesù era stato disegnato
da un artista su una
stoffa bagnata e poi
trasferita sulla tela
con una procedura assai
comune nel Medio Evo.
Nello stesso periodo, lo
studioso Walter McCrone
affermò che si trattava
di un doppio dipinto: la
prima immagine era stata
realizzata con colori
ricavati dalla terra e
le macchie di sangue
ricavate da spruzzi di
vermiglio. Prove
pratiche iniziarono a
compiersi nel 1975,
quando due ricercatori
della NASA, J. Jackson e
E. Jumper, utilizzando
un analizzatore spaziale
denominato VP8, crearono
un modello
tridimensionale del
corpo avvolto nella
sindone, realizzato,
poi, materialmente con
leggeri strati di
cartoni di vetro. Cosa
simile fu fatta tre anni
più tardi dal prof.
Giovanni Tamburelli, il
quale, analizzando vari
punti del tessuto nei
quali, a suo dire, erano
contenute informazioni
che davano la distanza
fra il tessuto e la
pelle, dimostrò che il
lenzuolo aveva davvero
avvolto un corpo umano.
Tamburelli, poi, fece di
più, ricavando al
computer l’immagine
tridimensionale del
volto stampato sulla
Sindone. Volto che ha
impressionanti
somiglianze con quello
descritto da tutti i
Vangeli, con tumefazioni
causate dai colpi di
bastone, con profondi
segni causati dai
flagelli, con tracce
delle tre cadute fatte
da Gesù nel tragitto
fino al colle del
Golgota, con gocce di
sangue rappreso. Oltre a
questo, una cosa nuova:
una fossetta lasciata
sull’occhio sinistro da
una moneta. Questa
pratica, secondo gli
esperti, era cosa comune
nei primi anni dell’era
cristiana, non in
seguito. Inoltre, la
tradizione delle
scritture ci tramanda un
Gesù morto vestito solo
da una specie di
pannolino: l’uomo della
Sindone, invece, è nudo.
Un artista medioevale
non avrebbe mai
rappresentato Cristo in
maniera diversa da
quella tramandata.
Dunque, l’ipotesi della
falsificazione
medioevale diventava
sempre più flebile.
Questa ipotesi veniva
demolita, anche, da
altri fatti, più
propriamente anatomici
ed appartenenti ad una
cultura “medica”
solamente moderna.
Vediamo quali sono.
Sulla fronte del volto
della Sindone compare
una macchia di sangue a
forma di 3, cosa che
corrisponde
perfettamente con
l’incisione sulla fronte
causata dalla corona di
spine. Le mani, inoltre,
non presentano
l’immagine dei pollici
(7): Baima Bollone,
esperto di fama mondiale
nella medicina legale,
dedicatosi per anni allo
studio della Sindone,
spiega che, durante la
crocifissione, i chiodi
vanno ad incidere un
tendine adibito proprio
al movimento del
pollice, che rimane,
così, bloccato
all’interno della mano.
Nel 1981, il già citato
Baima Bollone esaminò
alcuni frammenti di fili
estratti dal telo. Ciò
che scoprì fu molti
interessante: sui
frammenti c’erano tracce
di sangue, del gruppo
AB. Oltre a questo,
l’”esame autoptico”
condotto da Bollone
stabilì che il viso era
asimmetrico, tumefatto
da numerose percosse,
che un occhio era gonfio
e le labbra erano gonfie
a causa di un colpo.
Insomma, l’immagine
stampata sulla Sindone
rappresentava senza
dubbio un uomo morto per
crocifissione mediante
chiodi, pratica di morte
presente soprattutto
nell’Impero Romano
(altri popoli
preferivano
l’impalamento o la
crocifissione mediante
anelli a bloccare le
braccia).
Recentemente, il
botanico Max Frei ha
avviato una nuova
ricerca, basata su un
metodo diverso: la
botanica, appunto.
Alcune fibre di tessuto,
notò l’uomo, sembravano
contenere granuli o
spore di polline. La
loro analisi rivelò che
si trattava di polline
di faggio e tasso tipici
dell’Europa
settentrionale e
centrale. Questo provava
che la sindone era stata
esposta (all’aperto) in
Francia ed in Italia.
Altri pollini erano,
invece, di altre piante,
tipiche della Turchia
meridionale, di una
particolare verità dell’Assueta
che cresce solo in
Palestina, del Paganum
Hamala, tipico del
deserto tra il Mar Morto
e Gerico, e di altri sei
arbusti endemici di
quella zona. Insomma, il
telo era stato nelle
terre del Vangelo. Nel
1988 la Chiesa autorizzò
tre laboratori (in
Arizona, ad Oxford ed a
Zurigo) a compiere
analisi al Carbonio 14
sulla Sindone. Il
Carbonio 14 è una
sostanza che viene
assorbita da tutti gli
esseri viventi (piante
ed animali) che
respirano, fin quando
questi sono in vita, e
che si deposita sulle
ossa; è una sostanza che
decade ad intervalli
regolari di tempo,
dunque, con alcuni
semplici calcoli, è
possibile risalire al
periodo in cui l’animale
o la pianta ha cessato
di assorbire carbonio,
in cui, cioè, è morta.
L’analisi di alcuni
piccoli frammenti del
tessuto della Sindone
rivelò che il sudario di
Gesù era ben più recente
dei 2000 anni che le si
attribuivano, risalendo
ad un periodo compreso
tra il 1260 ed il 1390.
E’ probabile, però, che
il frammento di tessuto
utilizzato per l’analisi
sia quello utilizzato
dalle clarisse per il
restauro in seguito
all’incendio del ‘500.
Recentemente,
l’interesse degli
studiosi si è
concentrato
sull’immagine della
moneta stampata in
corrispondenza di un
occhio, di cui abbiamo
già parlato. L’analisi
della moneta ha rivelato
che si tratta di una
moneta presente in
Palestina tra il 29 ed
il 30 d.C., come il
profilo di una coppa e
le lettere TIB, iniziali
di Tiberius, Tiberio,
l’imperatore sotto quale
Cristo morì,
testimoniano. La verità
riguardo alla Sindone, è
probabile, non la
sapremo mai. Ma in
fondo, è davvero la
verità che ci interessa
scoprire? O è forse
meglio lasciare la
risposta a certi quesiti
solamente alla nostra
anima ed alla nostra
fede? Ognuno, in base
alla propria
personalità, cerchi la
risposta come meglio
crede. |