|
Nel campo della ricerca
parapsicologica la
fotografia
all’infrarosso riveste
un ruolo molto
importante, anche se
secondario rispetto a
quella
all’ultravioletto, che
avremo modo di
approfondire in futuro.
Ma cominciamo a definire
questo tipo di mondo a
noi “invisibile”. Le
radiazioni
elettromagnetiche (onde
elettromagnetiche)
vengono classificate in
base alla frequenza o
all'energia dei fotoni.
All'aumentare della
frequenza queste onde
prendono il nome di:
radioonde - microonde -
infrarosso - luce
visibile - ultravioletto
- raggi x e raggi gamma.
A seconda della loro
energia, queste
radiazioni provocano
fenomeni di ionizzazione
della materia che
attraversano,
ionizzazione variabile a
seconda del tipo di
materia attraversata,
dal tipo di radiazione,
ovviamente e
dell'energia, come già
detto. Le radiazioni
ionizzanti si estendono
al di sotto della banda
dell'ultravioletto.
Il nostro occhio è in
grado di percepire una
piccolissima parte dello
spettro
elettromagnetico,
definito quello della
luce visibile (detta
anche luce bianca). La
luce bianca, irradiata
appunto dai raggi solari
è in grado di farci
percepire il mondo come
lo conosciamo grazie
alle frequenze dei
colori che il nostro
occhio cattura:

Per comprendere
meglio questo pensate
all'arcobaleno: esso non
è altro che la
suddivisione di ogni
singolo componente della
luce bianca. In termini
di lunghezza d'onda in
nanometri (ricordo che
la lunghezza d'onda
delle radiazioni e.m è
inversamente
proporzionale alla
frequenza delle stesse)
noi riusciamo a vedere
dai 400 nm ai 700 nm.
Alle estremità di queste
lunghezze d'onda abbiamo
l'ultravioletto (dai 100
nm a 400 nm) e
l'infrarosso (700 nm -
1000 microm). Parti di
queste frequenze possono
essere catturate in
termini fotografici
mediante varie tecniche.
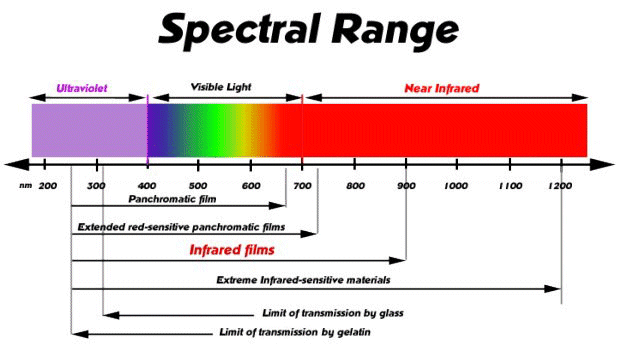
Ma torniamo
all’infrarosso. Per la
fotografia digitale
occorrono sensori di
acquisizione aventi una
banda estesa al rosso
(molte fotocamere
classiche sono in grado
di "percepire" solo lo
spettro della luce
visibile). La zona
dell'infrarosso è molto
ampia ma si riesce ad
acquisire
fotograficamente
solamente in un range
spettrale definito, che
va dai 700 nm ai 900 nm,
anche se, avendo un
portafoglio molto
appesantito e comperando
apparecchiature molto
costose, si arriva anche
nei pressi
dell'infrarosso definito
“alto", pari a 1350 nm;
oltre a sensori CCD
aperti a questa
frequenza è
indispensabile
utilizzare dei filtri
passa-banda che lascino
passare solamente il
range di frequenze
prestabilito, tagliando
completamente le altre,
luce bianca compresa. La
ripresa ambientale
all’infrarosso è
fattibile anche con
fotocamere analogiche,
ma il tutto risulta
molto più laborioso.
Innanzitutto dobbiamo
procurarci emulsioni
fotografiche (pellicole)
che possano essere
impressionate delle
frequenze in questione,
poi è necessario far
sviluppare questi
rullini in laboratori
specializzati, cosa che
aumenta l’onere
economico per questo
tipo di sperimentazioni.
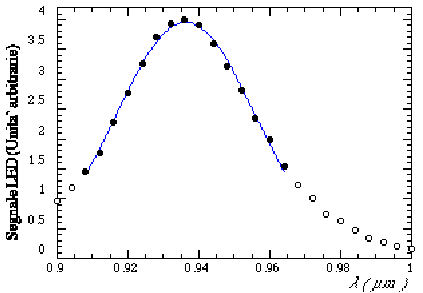 La
fotografia
all’infrarosso viene
sperimentata tramite due
tipi di tecniche, la
fotografia ambientale e
quelle dell’infrarosso
riflessa, che sono
simili nel loro concetto
base. Nella fotografia
ambientale è il sole che
fornisce alla scena da
fotografare
l’indispensabile
illuminazione IR, nella
fotografia riflessa, ad
ovvia causa della
mancanza di sufficiente
illuminazione IR
naturale, siamo noi che
la apportiamo mediante
l’utilizzo di fotodiodi
(L.E.D.) capaci di
generare tali emissioni
spettrali. Questi
fotodiodi emettono fasci
di fotoni aventi una
lunghezza d’onda che
interessano proprio il
nostro campo
applicativo. Nel grafico
sopra riportato vediamo
lo spettro emissivo di
un L.E.D. infrarosso,
che ha una curva
emissiva di picco da 910
nm a 970 nm. Per farvi
comprendere meglio,
questi fotodiodi sono
utilizzati come
illuminatori infrarossi
per le telecamere
notturne o di video
sorveglianza, oppure,
sono molto più comuni da
riscontrare nei
telecomandi delle
normalissime
televisioni, che
permettono di gestire da
distanza i comandi
remoti della
televisione. Questi sono
solo alcuni esempi
esplicativi, i fotodiodi
sono impiegatissimi nel
mondo dell’High Tech.
Che sia infrarosso
ambientale o riflesso,
noi non facciamo altro
che riprendere i
differenti comportamenti
della materia irradiata
con l’infarosso, che può
assorbire o riflettere
questa frequenza. Una
nota molto importante:
la fotografia
all’infrarosso non
consente di registrare
le radiazioni termiche
spontanee emesse dai
corpi a temperatura
ambiente. L’emissione
spontanea dei corpi più
caldi, come gli
scappamenti delle
automobili o i gas di
scarico egli aeroplani,
delle ciminiere
industriali ed i corpi
soggetti ad attrito, può
essere registrata solo
se la temperatura
raggiunge i 250°-300° C,
perché solo in tali casi
le radiazioni da essi
emesse raggiungono il
limite di sensibilità
delle acquisizioni CCD,
e, ovviamente, in questo
caso la ripresa deve
essere effettuata al
buio. La rilevazione di
sorgenti di calore e di
corpi a temperatura più
bassa di 250°C fino a
temperatura ambiente è
possibile, ma richiede
l’uso dei rilevatori non
fotografici e riguarda
il campo della
termografia (il costo di
una buona termocamera si
aggira intorno ai 10.000
– 15.000 euro). In
pratica si può affermare
che la fotografia
all’infrarosso consiste
nella registrazione
delle radiazioni
infrarosse emesse in
abbondanza dal sole o da
altre sorgenti di luce
artificiale e riflesse o
assorbite dai corpi che
le circondano. Le
radiazioni riflesse o
assorbite dai corpi non
dipendono dalla
temperatura dei corpi
stessi, che può essere
anche molto bassa, ma
dalla loro struttura e
composizione, cioè da
caratteristiche che non
sono rilevabili
all’occhio umano. La
fotografia
all’infrarosso viene
sperimentata tramite due
tipi di tecniche, la
fotografia ambientale e
quelle dell’infrarosso
riflessa, che sono
simili nel loro concetto
base. Nella fotografia
ambientale è il sole che
fornisce alla scena da
fotografare
l’indispensabile
illuminazione IR, nella
fotografia riflessa, ad
ovvia causa della
mancanza di sufficiente
illuminazione IR
naturale, siamo noi che
la apportiamo mediante
l’utilizzo di fotodiodi
(L.E.D.) capaci di
generare tali emissioni
spettrali. Questi
fotodiodi emettono fasci
di fotoni aventi una
lunghezza d’onda che
interessano proprio il
nostro campo
applicativo. Nel grafico
sopra riportato vediamo
lo spettro emissivo di
un L.E.D. infrarosso,
che ha una curva
emissiva di picco da 910
nm a 970 nm. Per farvi
comprendere meglio,
questi fotodiodi sono
utilizzati come
illuminatori infrarossi
per le telecamere
notturne o di video
sorveglianza, oppure,
sono molto più comuni da
riscontrare nei
telecomandi delle
normalissime
televisioni, che
permettono di gestire da
distanza i comandi
remoti della
televisione. Questi sono
solo alcuni esempi
esplicativi, i fotodiodi
sono impiegatissimi nel
mondo dell’High Tech.
Che sia infrarosso
ambientale o riflesso,
noi non facciamo altro
che riprendere i
differenti comportamenti
della materia irradiata
con l’infarosso, che può
assorbire o riflettere
questa frequenza. Una
nota molto importante:
la fotografia
all’infrarosso non
consente di registrare
le radiazioni termiche
spontanee emesse dai
corpi a temperatura
ambiente. L’emissione
spontanea dei corpi più
caldi, come gli
scappamenti delle
automobili o i gas di
scarico egli aeroplani,
delle ciminiere
industriali ed i corpi
soggetti ad attrito, può
essere registrata solo
se la temperatura
raggiunge i 250°-300° C,
perché solo in tali casi
le radiazioni da essi
emesse raggiungono il
limite di sensibilità
delle acquisizioni CCD,
e, ovviamente, in questo
caso la ripresa deve
essere effettuata al
buio. La rilevazione di
sorgenti di calore e di
corpi a temperatura più
bassa di 250°C fino a
temperatura ambiente è
possibile, ma richiede
l’uso dei rilevatori non
fotografici e riguarda
il campo della
termografia (il costo di
una buona termocamera si
aggira intorno ai 10.000
– 15.000 euro). In
pratica si può affermare
che la fotografia
all’infrarosso consiste
nella registrazione
delle radiazioni
infrarosse emesse in
abbondanza dal sole o da
altre sorgenti di luce
artificiale e riflesse o
assorbite dai corpi che
le circondano. Le
radiazioni riflesse o
assorbite dai corpi non
dipendono dalla
temperatura dei corpi
stessi, che può essere
anche molto bassa, ma
dalla loro struttura e
composizione, cioè da
caratteristiche che non
sono rilevabili
all’occhio umano.
LA SPERIMENTAZIONE
SUL CAMPO
Dopo questa breve
introduzione al mondo
della fotografia
all’infrarosso,
occupiamoci di come
poter realizzare
praticamente foto IR e
come potrebbe aiutarci
questa tecnica nel campo
della parapsicologia.
Gli studi
parapsicologici
effettuati da
validissimi ricercatori
esteri, o anche
italiani, ci insegnano
che è fondamentale
monitorare a livello
fotografico sia la banda
spettrale infrarossa che
ultravioletta (con
maggiore attenzione),
oltre a quella del
visibile chiaramente,
poiché in molti casi si
sono potute rilevare
immagini anomale o vere
e proprie riprese di
immagini extra.
Sembrerebbe quindi
possibile documentare a
livello fotografico le
manifestazioni
energetiche psi di
sensitivi e medium, o
anche fenomeni
energetici spontanei.
Oltre alla chiara
applicazione nella
fotografia paranormale,
è possibile utilizzare
questa tecnica di
ripresa per acquisire
ulteriori informazioni
sull’ambiente o luogo
che andremo ad
analizzare durante una
possibile indagine sul
campo. Vediamo ora
praticamente come poter
realizzare una foto
all’infrarosso,
riprendendo un campo
visivo irradiato da luce
solare. Questa è la
strumentazione che ho
utilizzato per
realizzare foto
esplicative per questa
breve guida:
•
Fotocamera digitale
Fuji FinePix S5600
UV/VIS/N-IR (Range
spettrale= 300 nm - 1100
nm)
•
Filtro HOYA passa IR
(R72)
Filtro che lascia
passare tutte le
radiazioni a partire
dalla gamma
dell’infrarosso vicino
(720nm), eliminando
completamente tutto lo
spettro della luce
visibile e
dell’ultravioletto.
•
Cavalletto fotografico
Indispensabile per la
fotografia IR con tempi
di esposizione
medio-lunghi, senza di
esso le foto
risulterebbero mosse e
fuori fuoco.
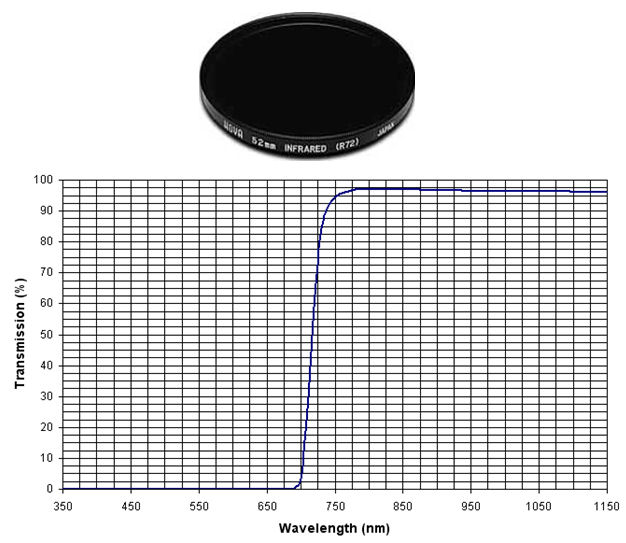
Come inquadratura di
base ho scelto di
fotografare il corso del
fiume Esino (che
attraversa
trasversalmente parte
della provincia di
Ancona fino a sfociare
nell’Adriatico. Questo
scatto è stato
fotografato da Serra San
Quirico - Ancona),
poiché in questa ripresa
abbiamo molti elementi
naturali che la
fotografia
all’infrarosso permette
di analizzare. In primo
piano abbiamo il fiume,
a destra in secondo
piano abbiamo il Monte
Murano, e in profondità
di campo, molto
lievemente, si può
scorgere il Monte della
Castelletta. Ho scelto
appositamente questo
tipo di paesaggio, in
questa giornata un
pochino fosca, per
mostrare gli utili
aspetti della fotografia
all’infrarosso e le
notevoli informazioni
che tramite essa
possiamo acquisire.
Sotto ogni foto mostrerò
lo schema di
acquisizione spettrale,
per far comprendere
meglio quali frequenze
ogni singolo scatto ha
interessato.
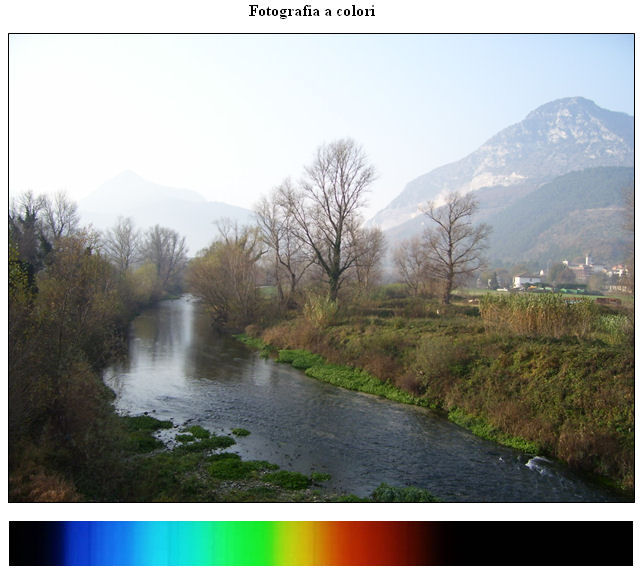
Come prima cosa
dovremo posizionare il
nostro cavalletto in
maniera stabile e
fissare la fotocamera
nell’apposito alloggio;
ora dovremo selezionare
la ripresa fotografica
in bianco e nero
(chiaramente la macchina
fotografica che
utilizzeremo deve essere
predisposta a questo
tipo di scatti), questo
perché, fotografando a
colori, la foto
risulterà con una
gradazione di rosso
davvero sgradevole.
Nella fotografia
all’infrarosso i tempi
di esposizione sono
molto differenti (più
lunghi) da quelli che si
utilizzano nella
fotografia tradizionale,
il modo più efficace per
esporre correttamente
una foto è fare diversi
scatti con tempi di
esposizione variabili
(la prima foto di
riferimento a colori è
stata scattata con un
tempo di esposizione
pari a 1/1500 di
secondo, un tempo
rapido). Anche la messa
a fuoco risulta un
problema; solitamente il
sistema AF (autofocus)
risolve bene la
questione, ma
ricordiamoci che
l’infrarosso va in fuoco
su un piano differente
del normale, quindi
anche in questo dobbiamo
affidarci alla pazienza
e fare diverse prove per
mettere a fuoco bene
l’inquadratura (nel mio
caso, il sistema AF
della fotocamera ha
lavorato discretamente).
Prima di iniziare a
fotografare con il
filtro posizionato
davanti l’obiettivo è
utile effettuare una
foto in bianco e nero
classico, per poter
confutare in sede di
elaborazione del
materiale i vari scatti.
Ecco come si presenta il
paesaggio fotografato
con questa tecnica:
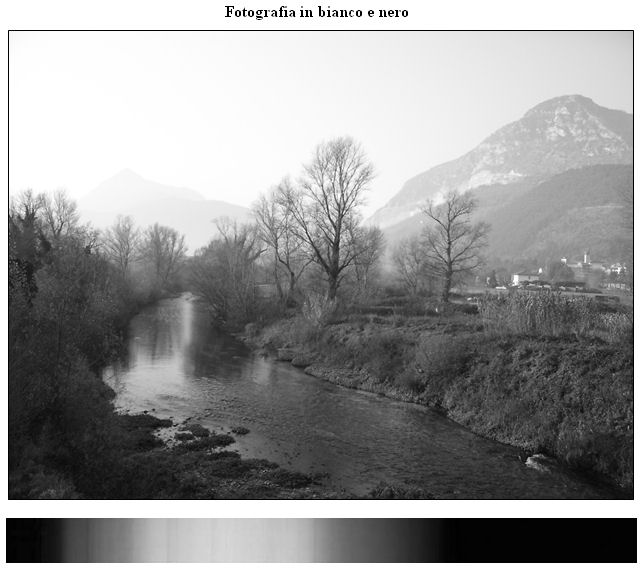
Bene. Presi questi
due riferimenti
fotografici,
selezioniamo dal menù
della nostra fotocamera
l’opzione per la
modifica del tempo di
esposizione. Ma che cosè
il tempo di esposizione?
Per comprendere meglio
questo concetto,
ragioniamo in termini di
fotografia analogica.
Una macchina fotografica
è un congegno che,
attraverso un sistema di
lenti e specchi
contenuti all’interno di
un obiettivo, riesce a
riflettere una
determinata immagine e
trasferirla su di una
pellicola chimicamente
impressionabile. Fin qui
nulla di complicato. La
macchina fotografica
oltre che essere
provvista di un
diaframma, che regola
l’intensità di luce che
può penetrare
all’interno dell’obietto
(e quindi sulla
pellicola), ha un
otturatore, una specie
di finestra che si apre
e si chiude secondo
tempi variabili
preimpostabili. In
condizioni di luminosità
elevata questa
finestrella dovrà
aprirsi e richiudersi
molto rapidamente,
poiché la grande
quantità di luce che
penetra nell’obiettivo e
che va ad impressionare
l’emulsione fotografica
rischia di sovresporre
lo scatto (ovvero si
ottiene uno scatto
troppo luminoso o
totalmente bianco); al
contrario, in condizioni
di scarsa luminosità,
questa finestrella dovrà
rimanere aperta molto di
più, per non incorrere
nel rischio di una
sottoesposizione (uno
scatto poco luminoso o
totalmente nero).
Iniziate con una
esposizione di un
secondo (in condizioni
di luminosità elevate) e
andate avanti finchè non
avrete trovato la giusta
esposizione. Una volta
selezionata
l’esposizione, applicate
il filtro all’obiettivo
e iniziate a scattare.
Di seguito vi mostro le
prove di esposizione che
ho fatto:



Dopo vari tentativi,
ecco una bella
fotografia
all’infrarosso
correttamente esposta.
L’immagine che otteniamo
è sorprendente, quasi
spettrale. La prima cosa
che notiamo è l’assoluta
assenza di foschia e la
precisa determinazione
dei contorni delle
montagne in secondo
piano e lungo campo, la
fotografia
all’infrarosso ha la
particolarità di
riuscire a penetrare
moltissimo la foschia,
oltre che fornire ottimi
contrasti. Possiamo
anche notare nel bordo
destro del fiume la
riflessione infrarossa
che produce la
vegetazione, riflessione
causata dalla clorofilla
presente nelle piante
stesse. Purtroppo la
foto non rivela
particolari extra, ma
comunque fornisce più
informazioni di un
tradizionale scatto. In
conclusione possiamo
dire che la fotografia
all’infrarosso
ambientale può:
•
Rilevare fenomeni
energetici di natura
paranormale
•
Ottenere riprese molto
dettagliate con alti
contrasti
•
Penetrare nella foschia
anche in lungo campo
•
Fornire informazioni
sulla composizione
chimica dei particolari
ripresi (effetto
clorofilla)
Anche se di importanza
minore rispetto alla
fotografia
all’ultravioletto, la
fotografia IR è uno
strumento utile a
monitorare quella
porzione di mondo
“invisibile” che
altrimenti non
riusciremmo a vedere, è
da considerarsi quindi
uno strumento molto
utile nel campo della
ricerca parapsicologica.
BIBLIOGRAFIA
·
La fotografia
all’infrarosso – Cesare
Romeo
·
Fotografia
all’infrarosso bianco e
nero all’ultravioletto e
alla fluorescenza –
Associazione italiana
fotografia
all’infrarosso
·
Photography in
archaeolog and art –
Charles C. Thomas
·
La termografia ed il suo
impiego nell’analisi del
manufatto architettonico
– Cesare Romeo
·
Filtri Kodak per uso
scientifico e tecnico –
Easteman Kodak Company
·
Appunti personali
dell’autore |