|
 La
rosa selvatica può
crescere spontaneamente
nei boschi e nei dirupi
ed è stata dunque
distinta fin
dall’antichità dalla
rosa a cento petali o
millefoglie (per quanto
nessun botanico ne abbia
mai contati tanti!), che
la tradizione vuole
originaria del monte
Bermios, nel Caucaso
orientale e gelosamente
custodita nei giardini
sacri e nei palazzi
reali. Erodoto tuttavia
già nel V secolo a.C. ne
parla come di un fiore
comune e racconta come
fosse coltivata con
successo dal mitico re
Mida, in Macedonia e di
qui penetrata in Grecia
da una parte, in
Mesopotamia, Siria e
Palestina dall'altra. Le
"Georgiche" di Nicandro
raccontano che le
famiglie greche, in
primavera ed in autunno,
facevano scampagnate sui
monti per procurarsi le
talee, che poi
attecchivano
felicemente. In effetti,
ancora oggi nel
Khourdistan questa rosa
cresce assolutamente
spontanea. La rosa
selvatica rappresenta
dunque la versione
originaria del più
comune fiore europeo,
presente con circa 150
specie, varietà ed
ibridi, in tutto il c La
rosa selvatica può
crescere spontaneamente
nei boschi e nei dirupi
ed è stata dunque
distinta fin
dall’antichità dalla
rosa a cento petali o
millefoglie (per quanto
nessun botanico ne abbia
mai contati tanti!), che
la tradizione vuole
originaria del monte
Bermios, nel Caucaso
orientale e gelosamente
custodita nei giardini
sacri e nei palazzi
reali. Erodoto tuttavia
già nel V secolo a.C. ne
parla come di un fiore
comune e racconta come
fosse coltivata con
successo dal mitico re
Mida, in Macedonia e di
qui penetrata in Grecia
da una parte, in
Mesopotamia, Siria e
Palestina dall'altra. Le
"Georgiche" di Nicandro
raccontano che le
famiglie greche, in
primavera ed in autunno,
facevano scampagnate sui
monti per procurarsi le
talee, che poi
attecchivano
felicemente. In effetti,
ancora oggi nel
Khourdistan questa rosa
cresce assolutamente
spontanea. La rosa
selvatica rappresenta
dunque la versione
originaria del più
comune fiore europeo,
presente con circa 150
specie, varietà ed
ibridi, in tutto il c ontinente,
di cui rappresenta un
po’ il vessillo. Non a
caso il termine "rosa" è
forse uno dei più
semplici della lingua
latina: prima
declinazione, femminile,
riferito ad un "nome
comune di cosa"
universalmente noto, uno
dei pochi termini usati
in tutte le lingue
indoeuropee, che ha
fatto pensare ad un
sostrato comune
risalente addirittura al
IV millennio a. C. E non
basta: nella lingua
originaria iranica "vareda",
da cui l'armeno "vard",
significa semplicemente
fiore, vale a dire
appunto "il fiore" per
eccellenza. E ci sono
due assonanze poetiche:
ros, roris in latino è
la rugiada, mentre ros
nell'antico idioma
celtico che il dialetto
piemontese ha fedelmente
conservato, significa
ghiacciaio. Il monte
Rosa, infatti, non
s'arrossa al tramonto
più di qualsiasi altra
cima innev ontinente,
di cui rappresenta un
po’ il vessillo. Non a
caso il termine "rosa" è
forse uno dei più
semplici della lingua
latina: prima
declinazione, femminile,
riferito ad un "nome
comune di cosa"
universalmente noto, uno
dei pochi termini usati
in tutte le lingue
indoeuropee, che ha
fatto pensare ad un
sostrato comune
risalente addirittura al
IV millennio a. C. E non
basta: nella lingua
originaria iranica "vareda",
da cui l'armeno "vard",
significa semplicemente
fiore, vale a dire
appunto "il fiore" per
eccellenza. E ci sono
due assonanze poetiche:
ros, roris in latino è
la rugiada, mentre ros
nell'antico idioma
celtico che il dialetto
piemontese ha fedelmente
conservato, significa
ghiacciaio. Il monte
Rosa, infatti, non
s'arrossa al tramonto
più di qualsiasi altra
cima innev ata,
ma ha conservato la
memoria di quest'antico
modo di definire i
picchi di ghiaccio. La
rosa dunque nasce e
cresce in associazione
con l'elemento acqua in
tutta la sua pienezza,
dalla rugiada del
mattino ai ghiacciai
delle alte vette. Quasi
in armonia col proprio
nome è una pianta
colonizzatrice, cioè
vive anche nella roccia,
le bastano il sole e
l'acqua, sono le sue
radici stesse a creare a
poco a poco la terra
fertile, che giova anche
alle altre specie.
Passando dalla rosa
selvatica a quella
coltivata le cure
necessarie ad una buona
fioritura aumentano, ma
questo solo perché ap ata,
ma ha conservato la
memoria di quest'antico
modo di definire i
picchi di ghiaccio. La
rosa dunque nasce e
cresce in associazione
con l'elemento acqua in
tutta la sua pienezza,
dalla rugiada del
mattino ai ghiacciai
delle alte vette. Quasi
in armonia col proprio
nome è una pianta
colonizzatrice, cioè
vive anche nella roccia,
le bastano il sole e
l'acqua, sono le sue
radici stesse a creare a
poco a poco la terra
fertile, che giova anche
alle altre specie.
Passando dalla rosa
selvatica a quella
coltivata le cure
necessarie ad una buona
fioritura aumentano, ma
questo solo perché ap punto
si desidera un fiore
artefatto, di colore,
dimensioni, profumo
diversi da quelli
originari...il roseto in
se', con le sue
caratteristiche
foglioline tondeggianti
e le spine, resta una
pianta rustica, che non
teme i rigori
dell'inverno ed affonda
coraggiosamente le
radici in cerca d'acqua
nella calura estiva. La
Rosa Canina è una delle
più rustiche varietà di
rosa selvatica, che deve
il suo nome all’antica
credenza che la sua
radice servisse a
guarire dalla rabbia. La
farmacopea moderna non
ha potuto confermare
questa virtù, d’altra
parte la rosa ne ha
tante altre che ne
giustificano
abbondantemente l’uso.
Forse l’idea deriva dal
legame della rosa con la
dea Venere, che è la dea
della distensione e
dell’amore.
Nell’antichità il primo
a parlare con tutta
naturalezza della rosa,
anzi, d'olio di rose per
massaggi, è infatti
Omero nell'Iliade, canto
XXIII, verso 186: è il
culmine delle tragedia,
Achille ha ucciso Ettore
e minaccia di gettarlo
in pasto ai cani, ma non
avviene perché: punto
si desidera un fiore
artefatto, di colore,
dimensioni, profumo
diversi da quelli
originari...il roseto in
se', con le sue
caratteristiche
foglioline tondeggianti
e le spine, resta una
pianta rustica, che non
teme i rigori
dell'inverno ed affonda
coraggiosamente le
radici in cerca d'acqua
nella calura estiva. La
Rosa Canina è una delle
più rustiche varietà di
rosa selvatica, che deve
il suo nome all’antica
credenza che la sua
radice servisse a
guarire dalla rabbia. La
farmacopea moderna non
ha potuto confermare
questa virtù, d’altra
parte la rosa ne ha
tante altre che ne
giustificano
abbondantemente l’uso.
Forse l’idea deriva dal
legame della rosa con la
dea Venere, che è la dea
della distensione e
dell’amore.
Nell’antichità il primo
a parlare con tutta
naturalezza della rosa,
anzi, d'olio di rose per
massaggi, è infatti
Omero nell'Iliade, canto
XXIII, verso 186: è il
culmine delle tragedia,
Achille ha ucciso Ettore
e minaccia di gettarlo
in pasto ai cani, ma non
avviene perché:
"... i cani li teneva
lontani la figlia di
Zeus, Afrodite
di giorno e di notte,
l'ungeva con olio di
rose,
ambrosio, perché Achille
non lo scorticasse
tirandolo..."
Nell'antichità l'olio di
rose era usato sia per
imbalsamare i morti
(come appunto narra
Omero nell'Iliade) che
per lucidare il legno
pregiato con cui erano
costruiti molti idoli.
Per ottenerlo si faceva
bollire del giunco
aromatico in olio
d'oliva, si agitava bene
e si versava sui petali
di rosa opportunamente
seccati. Si lasciava in
infusione un giorno ed
una notte e si filtrava
il tutto, conservandolo
in vasi prevalentemente
unti di miele. In modo
analogo si otteneva il
vino ed il miele alle
rose; Ippocrate però
preferisce spremere il
succo di petali freschi
direttamente nel miele
ed esporlo poi per una
quarantina di giorni al
sole. Dai petali
opportunamente seccati
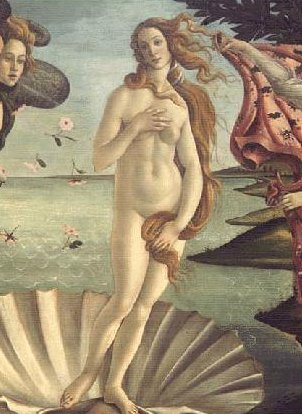 si
ricavava inoltre una
polvere deodorante
chiamata "diapasma", che
era usata come talco
dopo il bagno caldo e
prima di quello freddo.
Plinio ci parla di un
profumo ottenuto
mescolando, sempre in
olio d'oliva, fiori di
rosa, zafferano cinabro
e giunco deodorante...
in realtà non era un
profumo, ma un unguento
profumato, infatti, non
si sapevano ancora
distillare le essenze.
Saranno gli arabi a
compiere passi da
giganti in questo campo,
inventando lo sciroppo,
lo zucchero
aromatizzato, portando a
perfezionamento il
processo di
distillazione
dell'essenza necessario
per la fabbricazione
dell'acqua di rose, che
è più facile da
conservare ed ha un uso
più esteso dei vini e
degli unguenti d'un
tempo. Si applicano
cataplasmi di petali di
rosa sulle punture
d'insetti, sulle
escoriazioni e per
riattivare la
circolazione esterna,
mentre si usa l'acqua di
rose come disinfettante
interno ed esterno. Ma
fin dalla più remota
antichità in cucina si
faceva grande uso
d'insalate di rose,
soprattutto come
"intermezzo" fra una
portata e l'altra quando
si beveva troppo; molto
quotato era anche il
paté alla rosa. Plinio
per primo ci descrive
con vivezza di dettagli
la coltivazione della
rosa, consigliando di
ricorrere alle talee
perché seminando in modo
tradizionale bisogna
attendere troppo; ormai
si conoscono diverse
specie: Campania,
Prenesto, Mileto,
Trachinia Alabanda
producono fiori di
tonalità e profumi
leggermente diversi e
c'è solo l'imbarazzo
della scelta. Sempre
Plinio riferisce anche
l'abitudine d'ergere a
divisione della
proprietà curiose
palizzate di rose
selvatiche piantate in
due solchi affiancati,
al centro dei quali si
sistema una rete di
vimini bene intrecciato
per far arrampicare le
giovani piante, Plinio
ne raccomanda caldamente
l'uso, affermando che
neppure il fuoco può
distruggerle!?
Affermazione di per se'
un po' esagerata, ma in
qualche modo supportata
da un uso analogo del
biancospino da parte
dei giardinieri d'ol si
ricavava inoltre una
polvere deodorante
chiamata "diapasma", che
era usata come talco
dopo il bagno caldo e
prima di quello freddo.
Plinio ci parla di un
profumo ottenuto
mescolando, sempre in
olio d'oliva, fiori di
rosa, zafferano cinabro
e giunco deodorante...
in realtà non era un
profumo, ma un unguento
profumato, infatti, non
si sapevano ancora
distillare le essenze.
Saranno gli arabi a
compiere passi da
giganti in questo campo,
inventando lo sciroppo,
lo zucchero
aromatizzato, portando a
perfezionamento il
processo di
distillazione
dell'essenza necessario
per la fabbricazione
dell'acqua di rose, che
è più facile da
conservare ed ha un uso
più esteso dei vini e
degli unguenti d'un
tempo. Si applicano
cataplasmi di petali di
rosa sulle punture
d'insetti, sulle
escoriazioni e per
riattivare la
circolazione esterna,
mentre si usa l'acqua di
rose come disinfettante
interno ed esterno. Ma
fin dalla più remota
antichità in cucina si
faceva grande uso
d'insalate di rose,
soprattutto come
"intermezzo" fra una
portata e l'altra quando
si beveva troppo; molto
quotato era anche il
paté alla rosa. Plinio
per primo ci descrive
con vivezza di dettagli
la coltivazione della
rosa, consigliando di
ricorrere alle talee
perché seminando in modo
tradizionale bisogna
attendere troppo; ormai
si conoscono diverse
specie: Campania,
Prenesto, Mileto,
Trachinia Alabanda
producono fiori di
tonalità e profumi
leggermente diversi e
c'è solo l'imbarazzo
della scelta. Sempre
Plinio riferisce anche
l'abitudine d'ergere a
divisione della
proprietà curiose
palizzate di rose
selvatiche piantate in
due solchi affiancati,
al centro dei quali si
sistema una rete di
vimini bene intrecciato
per far arrampicare le
giovani piante, Plinio
ne raccomanda caldamente
l'uso, affermando che
neppure il fuoco può
distruggerle!?
Affermazione di per se'
un po' esagerata, ma in
qualche modo supportata
da un uso analogo del
biancospino da parte
dei giardinieri d'ol tralpe
e dalla credenza
medioevale che tali
barriere naturali
tenessero lontani gli
spiriti
cattivi...probabilmente
alla resistenza naturale
della palizzata spinosa
era unito il "potere" di
cui si riteneva dotata
la pianta. A
quest’usanza ed alla
persistente credenza del
bo tralpe
e dalla credenza
medioevale che tali
barriere naturali
tenessero lontani gli
spiriti
cattivi...probabilmente
alla resistenza naturale
della palizzata spinosa
era unito il "potere" di
cui si riteneva dotata
la pianta. A
quest’usanza ed alla
persistente credenza del
bo sco
come confine naturale
tra la civiltà ed il
mondo esterno dobbiamo
forse la nascita della
suggestiva leggenda
della “bella
addormentata nel bosco”
tenacemente custodita
per cento anni da
un’invalicabile barriera
di rose selvatiche
(secondo altre versioni
da rovi, che
appartengono egualmente
alla famiglia delle
rosacee) che impediscono
a chiunque
d’avvicinarsi,
mantenendola sospesa tra
la vita e la morte.
Nell’ottocentesca favola
dei fratelli Grimm la
principessa si chiama
Rosa Spina, ma nel 1600
il racconto del francese
Perrault, curiosamente
diffuso ancora nella
Calabria del nostro
dopoguerra, raccontava i
fatti diversamente e
compare il nome d’Aurora.
Nella versione
originaria la bella
partorisce due gemelli
(certo il principe non
si limita al bacio
tradizionale) maschio e
femmina, la bimba si
chiama Aurora ed è
proprio il pianto
disperato dei figli a
risvegliarla. Ben presto
tutta via il racconto
comincia a circolare in
versione più casta ed il
nome passa alla
principessa
addormentata. Piotr
Ilich Chaikovskij
sceglie il racconto di
Perrault e col balletto
la favola comincia a
girare il mondo. Disney
la chiama senz’altro
Aurora, fissando
senz’altro il
personaggio
nell’immaginario
collettivo. Ma se la
rosa è da sempre legata
a Venere, la dea
dell’amore che sorge
nuda dal mare e porta la
fecondità e la gioia al
mondo, Aurora non è da
meno… nel mondo vedico è
Ushas, la figlia del
cielo e sorella della
notte; veste
splendidamente; viaggia
ogni m sco
come confine naturale
tra la civiltà ed il
mondo esterno dobbiamo
forse la nascita della
suggestiva leggenda
della “bella
addormentata nel bosco”
tenacemente custodita
per cento anni da
un’invalicabile barriera
di rose selvatiche
(secondo altre versioni
da rovi, che
appartengono egualmente
alla famiglia delle
rosacee) che impediscono
a chiunque
d’avvicinarsi,
mantenendola sospesa tra
la vita e la morte.
Nell’ottocentesca favola
dei fratelli Grimm la
principessa si chiama
Rosa Spina, ma nel 1600
il racconto del francese
Perrault, curiosamente
diffuso ancora nella
Calabria del nostro
dopoguerra, raccontava i
fatti diversamente e
compare il nome d’Aurora.
Nella versione
originaria la bella
partorisce due gemelli
(certo il principe non
si limita al bacio
tradizionale) maschio e
femmina, la bimba si
chiama Aurora ed è
proprio il pianto
disperato dei figli a
risvegliarla. Ben presto
tutta via il racconto
comincia a circolare in
versione più casta ed il
nome passa alla
principessa
addormentata. Piotr
Ilich Chaikovskij
sceglie il racconto di
Perrault e col balletto
la favola comincia a
girare il mondo. Disney
la chiama senz’altro
Aurora, fissando
senz’altro il
personaggio
nell’immaginario
collettivo. Ma se la
rosa è da sempre legata
a Venere, la dea
dell’amore che sorge
nuda dal mare e porta la
fecondità e la gioia al
mondo, Aurora non è da
meno… nel mondo vedico è
Ushas, la figlia del
cielo e sorella della
notte; veste
splendidamente; viaggia
ogni m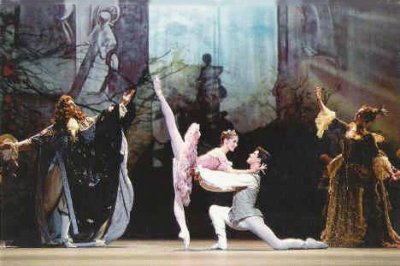 attino
su di un carro trainato
da due cavalli rossi e
da due vacche rosee ed è
sempre inseguita invano
dal sole (Surya), che
non riesce mai a
raggiungerla, inutile
dire che nella favola di
Perrault il maschietto
si chiamavano appunto
Sole. Ushas è l'amante,
la fidanzata o la figlia
di Surya (il sole) di
cui essa prepara la via,
ma in realtà è anche
fidanzata a Kandra (la
Luna, che è di sesso
maschile nella religione
vedica) e che è il suo
vero amore segreto.
Anche per gli antichi
Celti, come per i
tedeschi e gli ebrei di
oggi, il sole è
femminile e la luna
maschile e nella più
antica versione del
Tristano ed Isotta i due
amanti erano due
evidenti trasposizioni
del sole e della luna...
nonché del loro rapporto
fugace e clandestino. A
Ushas sono dedicati
venti inni meravigliosi,
pieni di impeto lirico,
privi di quegli accenni
sacrificali che
appesantiscono spesso la
poesia vedica. Nata dal
mare come Venere e prima
di lei Afrodite,
portatrice della prima
luce del giorno, Ushas
risveglia gli uomini,
incitandoli alla bontà,
alla giustizia e al
proficuo lavoro; gli
uomini, a loro volta, la
implorano perché conceda
loro un buon cibo,
prole, bestiame,
ricchezza e lunga vita…
ma non si tratta di
ricchezze facilmente
acquisite. Nascendo la
Dea porta al mondo la
passione ed il primo
effetto è lo scatenarsi
della rivalità e della
guerra, che
paradossalmente poi lei
sola può placare. Una
divinità doppia dunque,
come poche! Che il mondo
cristiano cerchi
d’addormentare la
vecchia dea, che la
immagini eternamente
nascosta nei boschi di
rose, laddove la natura
si fa più impenetrabile,
è dunque un concetto
nient’altro che banale,
ben custodito
dall’ingenua favola per
bambini. Possiamo dunque
vedere nella splendid attino
su di un carro trainato
da due cavalli rossi e
da due vacche rosee ed è
sempre inseguita invano
dal sole (Surya), che
non riesce mai a
raggiungerla, inutile
dire che nella favola di
Perrault il maschietto
si chiamavano appunto
Sole. Ushas è l'amante,
la fidanzata o la figlia
di Surya (il sole) di
cui essa prepara la via,
ma in realtà è anche
fidanzata a Kandra (la
Luna, che è di sesso
maschile nella religione
vedica) e che è il suo
vero amore segreto.
Anche per gli antichi
Celti, come per i
tedeschi e gli ebrei di
oggi, il sole è
femminile e la luna
maschile e nella più
antica versione del
Tristano ed Isotta i due
amanti erano due
evidenti trasposizioni
del sole e della luna...
nonché del loro rapporto
fugace e clandestino. A
Ushas sono dedicati
venti inni meravigliosi,
pieni di impeto lirico,
privi di quegli accenni
sacrificali che
appesantiscono spesso la
poesia vedica. Nata dal
mare come Venere e prima
di lei Afrodite,
portatrice della prima
luce del giorno, Ushas
risveglia gli uomini,
incitandoli alla bontà,
alla giustizia e al
proficuo lavoro; gli
uomini, a loro volta, la
implorano perché conceda
loro un buon cibo,
prole, bestiame,
ricchezza e lunga vita…
ma non si tratta di
ricchezze facilmente
acquisite. Nascendo la
Dea porta al mondo la
passione ed il primo
effetto è lo scatenarsi
della rivalità e della
guerra, che
paradossalmente poi lei
sola può placare. Una
divinità doppia dunque,
come poche! Che il mondo
cristiano cerchi
d’addormentare la
vecchia dea, che la
immagini eternamente
nascosta nei boschi di
rose, laddove la natura
si fa più impenetrabile,
è dunque un concetto
nient’altro che banale,
ben custodito
dall’ingenua favola per
bambini. Possiamo dunque
vedere nella splendid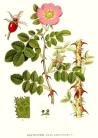 a
favola della Bella
Addormentata nel bosco
il simbolo d’una
divinità femminile che
dorme, ma non è morta ed
attende solo il bacio
del principe per
restituire al mondo
tutta la sua vitalità.
La rosa selvatica
condivide con la più
famosa rosa coltivata
tutte le proprietà
curative… ma è sempre
stata considerata, a
torto, la sorella
povera. Fin
dall'antichità la si
giudica un fiore dalla
doppia valenza; da un
lato, infatti, si
caratterizza per la
bellezza e soavità del
profumo dei propri
boccioli, dall'altro per
il tronco ed i rami
pieni di spine, piccole
e appuntite, che
rappresentano un
ostacolo per chiunque si
avvicini e desideri
cogliere una rosa. Per
questi motivi il
significato attribuito
al fiore è duplice:
delicatezza e piacere
ma la tempo stesso anche
sofferenza e dolore
fisico. Oggi
al contrario si
considera la rosa
selvatica, col suo fiore
di cinque petali, una
garanzia di genuinità
rispetto a quella
coltivata e dunque un
eccellente tonico ed
astringente, soprattutto
nella cura delle
emorragie, tisi e tumori
della pelle. Da non
dimenticare sono poi le
proprietà calmanti e
rilassanti associate
agli infusi ed estratti
ricavati con i petali
del fiore, ma anche
dalle sue bacche, che
nelle varietà selvatiche
sono abbondanti e facili
da conservare. a
favola della Bella
Addormentata nel bosco
il simbolo d’una
divinità femminile che
dorme, ma non è morta ed
attende solo il bacio
del principe per
restituire al mondo
tutta la sua vitalità.
La rosa selvatica
condivide con la più
famosa rosa coltivata
tutte le proprietà
curative… ma è sempre
stata considerata, a
torto, la sorella
povera. Fin
dall'antichità la si
giudica un fiore dalla
doppia valenza; da un
lato, infatti, si
caratterizza per la
bellezza e soavità del
profumo dei propri
boccioli, dall'altro per
il tronco ed i rami
pieni di spine, piccole
e appuntite, che
rappresentano un
ostacolo per chiunque si
avvicini e desideri
cogliere una rosa. Per
questi motivi il
significato attribuito
al fiore è duplice:
delicatezza e piacere
ma la tempo stesso anche
sofferenza e dolore
fisico. Oggi
al contrario si
considera la rosa
selvatica, col suo fiore
di cinque petali, una
garanzia di genuinità
rispetto a quella
coltivata e dunque un
eccellente tonico ed
astringente, soprattutto
nella cura delle
emorragie, tisi e tumori
della pelle. Da non
dimenticare sono poi le
proprietà calmanti e
rilassanti associate
agli infusi ed estratti
ricavati con i petali
del fiore, ma anche
dalle sue bacche, che
nelle varietà selvatiche
sono abbondanti e facili
da conservare.
Visita il sito personale
di
Mary Falco
|