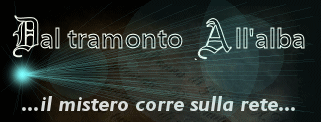|
|
 |
| |
|
Raffaello
Sanzio - Geometria della Trasfigurazione in Sposalizio della Vergine |
|
a cura di
Gaetano Barbella |
| |
|
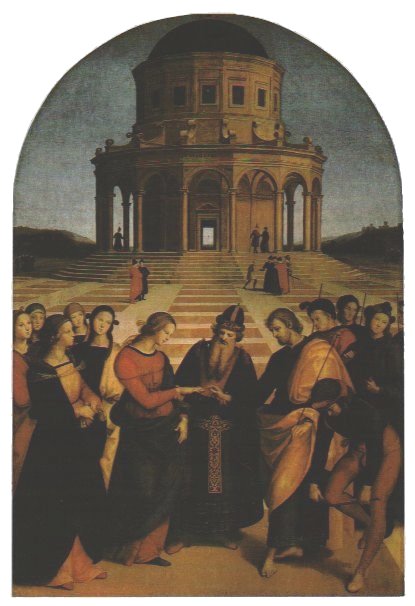 |
|
|
|
DENTRO L'OPERA |
|
Non sono in pochi
a domandarsi, "Ma perché mi piace Raffaello? Le sue Madonne sono una
più bella dell'altra". La risposta ce la dà Giorgio Vasari:
«Sicurissimamente può dirsi che i possessori della dote di Raffaello
non sono uomini semplicemente, ma dèi mortali». Dunque la piena comprensione dell'arte di Raffaello,
che piace da morire attraverso
 le
sue madonne, come La Madonna del Granduca dell'illustrazione 1
(conservato oggi presso la Galleria Palatina – Palazzo Pitti di
Firenze), risulta insufficiente se vista solo in modo esteriore.
Allora non resta che tentare di entrare "dentro l'opera", e
ravvisare, per cominciare, l'arte del dipingere col doppio senso dei
segni. Naturalmente questo genere di visione non può riscontrarsi
nella Madonna del Granduca, ma sembra di sì in opere, come lo
"Sposalizio della Vergine" (conservata oggi presso la pinacoteca di
Brera di Milano), per esempio, sulla quale si svilupperà il tema di
copertina, "la geometria della trasfigurazione". Vedremo il giusto
modo per entrare "dentro l'opera" attraverso una singolare geometria
strutturale, inconsueta fra gli artisti del Rinascimento cui
Raffaello apparteneva. le
sue madonne, come La Madonna del Granduca dell'illustrazione 1
(conservato oggi presso la Galleria Palatina – Palazzo Pitti di
Firenze), risulta insufficiente se vista solo in modo esteriore.
Allora non resta che tentare di entrare "dentro l'opera", e
ravvisare, per cominciare, l'arte del dipingere col doppio senso dei
segni. Naturalmente questo genere di visione non può riscontrarsi
nella Madonna del Granduca, ma sembra di sì in opere, come lo
"Sposalizio della Vergine" (conservata oggi presso la pinacoteca di
Brera di Milano), per esempio, sulla quale si svilupperà il tema di
copertina, "la geometria della trasfigurazione". Vedremo il giusto
modo per entrare "dentro l'opera" attraverso una singolare geometria
strutturale, inconsueta fra gli artisti del Rinascimento cui
Raffaello apparteneva.
L'illusione, spesso, non manca di adombrare le arti figurative e
perciò nel mondo della pittura capita di riscontrare esempi di
immagini ambigue, ingannatrici, nelle quali non tutto è solo come
appare. Nel senso che l'artista, pur non contravvenendo alla
corretta rappresentazione scenica del tema pittorico, si dispone in
modo velato a concepire immagini che si prestano a doppi
significati, abbastanza percepibili alcuni, altri meno. Naturalmente
qui si sta parlando dell'arte del Rinascimento che ha dato luogo ad
una fioritura di opere disposte a simili concezioni. L'artista del
Rinascimento sentiva fortemente in sé la necessità di velare ad arte
concezioni occulte ereditate dal passato Medio Evo, assai diffuse
nel suo tempo e che era "spinto" a far "transfugare" nel mistero.
Occorre dire che era un'epoca in cui la severa vigilanza del clero
del Vaticano non tollerava cose del genere, ragion per cui il
ricorso ai doppi sensi dei segni era inevitabile.
|
|
|
|
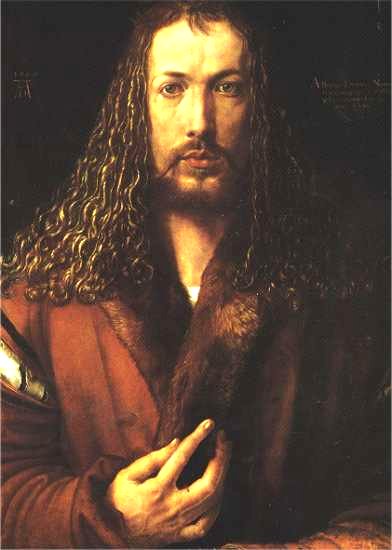 |
|
|
|
Albrecht Dürer
(1471-1528) è un esemplare artista di quelli dei quali si sta
parlando. Lo vediamo all'opera, per esempio, nel suo
autoritratto (illustrazione 2) che egli realizzò nel 1500
(conservato oggi presso l'Alte Pinakothek di Monaco). Egli
sembra rifarsi all'iconografia che tradizionalmente alludeva al
Cristo. Con questo lavoro, Dürer sembra voler sottolineare come
l'Artista "ricalchi", "imiti" il virtuoso cammino di Gesù,
l'uomo-divinizzato, la pietra filosofale. Notare che l'arte di
Albrecht Dürer era ben nota a Raffaello.
E poi, in materia delle artefazioni in questione, vale l'esempio
classico di Leonardo da Vinci. Egli si dimostra un acuto
conoscitore dei fenomeni ottici, tant'è che avrebbe inserito nei
suoi dipinti immagini nascoste negli sfondi o nei drappeggi. Ma
è una cosa che egli stesso ce lo fa intendere attraverso il suo
"Trattato della
pittura" [1].
Naturalmente Raffaello Sanzio, ha imparato tanto da questo genio
delle scienze oltre che quello delle arti figurative. E quindi
non meraviglierebbe, scoprire in lui un geniale cultore
dell'arte ermetica. |
|
|
|
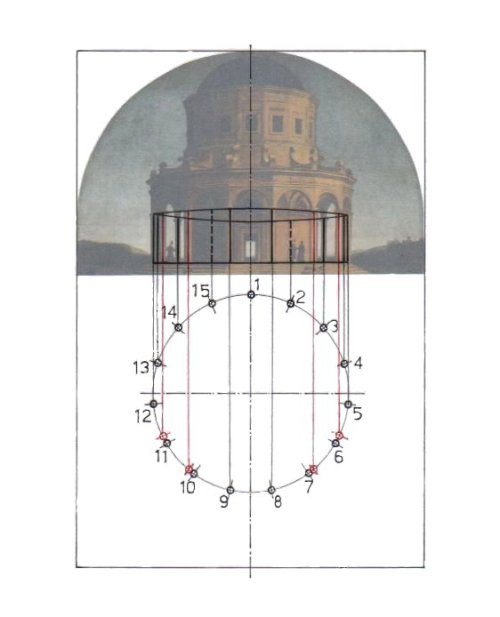 |
|
|
|
Stupirà
intravedere quest'arte, nella citata opera, "Sposalizio della
V.", che non manca di mostrare dettagli che disorientano.
Infatti nel mio saggio "La geometria astronomica in Sposalizio
della Vergine", vengono evidenziate chiare dissonanze sul
tempietto in relazione all'orditura delle colonne (illustrazione
3). Sembrerebbero 16 ma le colonne che si intravedono sul retro
fanno capire che dovrebbero essere 15. Però in tal caso si
dovrebbe vedere la colonna di centro del retro, invece non la si
vede attraverso la porta centrale che presuppone almeno un
finestrone sul retro. Ma poi nel saggio menzionato riesco a
spiegare questo arcano per far nascere, attraverso il dipinto
raffaellesco, un genere di geometria a sorpresa che pone sul
moggio, nientemeno, l'astronomia capace di benedire le nozze
celebrate in "Sposalizio della Vergine" con il tempo
equinoziale. Quanto basta per far partecipe il cosmo nel modo
consono.
Ancora più in garbugliata risulta la situazione del gruppo degli
sponsali, oggetto della trattazione di quest'altro saggio, che
poi si lega al primo per dar luogo a mie successive concezioni
geometriche perché si dimostrino divine attraverso una
meravigliosa rappresentazione simbolica di una convincente
"trasfigurazione". Giusto in relazione al dipinto che Raffaello
non riusci a completare a causa della sua dipartita. Ma non
voglio anticipare ciò che farò emergere attraverso meravigliose
linee che trovano riferimento alla "disposizione" a quelle del
quadro in osservazione. |
|
|
|
 |
|
|
|
Dunque
rivolgendo l'attenzione al gruppo degli sponsali (illustrazione
4) osserviamo, per cominciare, la raffigurazione di S. Giuseppe,
l'unico senza calzari. Occorre premettere che per un artista
della levatura di Raffaello, ogni opera è occasione
autobiografica e così può essere questo capolavoro.
Cosa vuol dire allora che S. Giuseppe è senza calzari? Che
Raffaello avrà inteso raffigurarsi in Mosè sul Monte Sinai al
cospetto di Dio che gli si manifesta sotto le sembianze del
«Roveto Ardente» (Esodo 3,2). E sappiamo che Dio, in forma di
fuoco, gli impose di togliersi i calzari, appunto perché la
terra del luogo era sacro. Ma dove, nel dipinto in osservazione,
la possibile intravisione del «roveto ardente» ?
"Dentro l'opera"! Ovvero cerca il «V.I.T.R.I.O.L.». supponendola
improntata all'esoterismo. Ma che vuol dire questo termine, che
è ermetico? «Visita Interiora Terrae Rectificandoque Invenies
Occultum Lapidem (Veram Medicinam)». Visita l'interno della
terra e depurando, troverai la pietra occulta, la vera medicina.
Si tratta del motto degli alchimisti filosofi.
Altro dettaglio che disorienta:
Osservando da vicino il punto centrale del dipinto, vediamo S.
Giuseppe che si appresta a infilare l'anello nuziale
nell'anulare della sposa Maria. Nulla di tanto strano, ma la
cosa che non va è che si tratta dell'anulare della mano destra
della Vergine Maria! L'unica possibile spiegazione è che il
dipinto sia un'immagine riflessa in uno specchio. Di qui tante
conseguenti concezioni da poter fare. Come quella connessa con
le cose della riflessione, per esempio, relative ad un processo
interiore disposto per la trasmutazione personale, di Raffaello
naturalmente. Infatti, come farò vedere con la geometria
strutturale, è la riflessione che dà luogo a delle meravigliose
concezioni grafiche che portano al concetto di deificazione
riferentesi al titolo di copertina, in piena assonanza alla
parola evangelica di Gesù quando afferma:
«Io ho detto: Voi siete
déi»
(Giov 10,34).
Ed ancora:
Si notino i piedi nudi di S. Giuseppe (ovvero di Raffaello
Sanzio stesso)? Ora si provi questa postura in pratica per
capire che è anomala al punto da considerarsi difficile da
assumere. La possibile spiegazione è che Raffaello, così
facendo, ha voluto creare ("forzatamente") attraverso sé stesso
una occulta "base" con lati ad angolo retto: di qui, essendo i
due lati retti fra loro uguali (i piedi lo sono) nulla da
obiettare che si tratti, occultamente, di un quadrato. Ed è come
immaginare il processo e lo scopo finale dell'opera in
Raffaello:
«La pietra scartata dai
costruttori
è diventata testata d'angolo;
ecco l'opera del Signore;
una meraviglia ai nostri occhi»
(Sal 117 [118], 22-23)
secondo il Cristianesimo,
appunto. Sensazionale no? Non sembra un interessantissimo
preambolo da Codice da Vinci? Come a rilevare in "Sposalizio
della V." un retroscena esoterico che non pochi studiosi d'arte
hanno tentato invano di scoprire. Perciò quest'opera singolare,
con tutta probabilità, adombra occultamente un reale "matrimonio
ermetico" sperimentato o intrapreso dall'iniziato ai lavori
ermetici in Raffaello.
Ma non finiscono qui le perplessità...
Per esempio sul giovanotto sulla destra, accanto a S. Giuseppe,
che sta spezzando la sua "verga": tutti i critici d'arte hanno
convenuto che si tratta di un rituale ripreso da una leggenda
medievale per far vedere, con questo gesto, la rinuncia di
pretese matrimoniali. Nulla da obiettare, ma è un evidente "meme",
si direbbe oggi, per "vestire" un certo virus ermetico
(nell'ermetismo si procede per "meme" a iosa). Come la postura
dei piedi nudi di S. Giuseppe, ovvero Raffaello, è un altro
evidente "meme" come ho dimostrato prima. Ma se si ha il fiuto
di segugio, si direbbe che quel tale non dimostra niente sulla
presunta rinuncia di pretese matrimoniali.
Non è una prova valida. Perché? Perché si tratta di un tentativo
di "piegare" e non di "spezzare" quel bastone. E c'è di più a
complicare le cose, il fatto quasi scontato che quel bastone,
piegato a quel modo, effettivamente si deve spezzare! L'angolo
di flessione è molto pronunciato per far rientrare la cosa in
un'accettabile freccia d'inflessione del piccolo travicello
legnoso, osserverebbe l'ingegnere addottorato nella scienza
delle costruzioni. Secondo questi la sollecitazione di flessione
che ne deriva è ben oltre quella di rottura.
Dunque nulla da obiettare se Raffaello insapora l'opera sua
dello "Sposalizio della V." in modo a lui congeniale,
raffigurandosi in quel bel giovane intento a piegare gli
"EVENTI" in quella verga. Ma tutte le altre cose sopra rilevate,
non sono tanti altri modi di "piegare gli eventi" ad opera di
Raffaello?
E l'arte delle madonne, come quella del "Granduca", dunque? Il
modo principe di Raffaello di tentare di "piegare" la Natura con
la sua stessa Natura nella sua sfolgorante bellezza terrena.
Niente travisamenti, artefazioni. La bellezza terrena come
antidoto alle manipolazioni occulte della Natura.
Scrive infatti Raffaello:
«il pittore ha l'obbligo di fare
le cose non come le fa la natura, ma come ella le dovrebbe
fare».
Ed ancora:
«Qualunque cosa la mente
umana si trovi a dover comprendere, l'ordine ne è una
indispensabile condizione. Disposizioni quali la planimetria di
una città o di un edificio, un insieme di utensili,
un'esposizione di mercanzia, la manifestazione verbale di fatti
o di idee, ovvero quali un dipinto o un brano musicale, sono
disposizioni dette tutte ordinate quando sia possibile a chi le
osservi o le ascolti per coglierne la struttura generale ed
anche il diramarsi di essa in una certa articolazione di
dettaglio. L'ordine consente di concentrar l'attenzione su
quanto si assomiglia e quanto è, invece, dissimile; su quanto
vicendevolmente si corrisponde o è, invece, segregato in sé.»
Ma le due
frasi si rivelano contraddittorie fra loro. Nella prima il
pittore si erge come "maestro" sulla natura, ma è vero anche che
se questa non si disponesse in modo "ordinato" in tutte le sue
concezioni, non avrebbe la possibilità di replicarsi senza
correre il rischio di catastrofiche conseguenze genetiche. Cosa
che non è, salvo eccezioni. Dunque le "disposizioni", cui si
riferisce Raffaello nella seconda frase, che egli raccomanda di
osservare – mettiamo in "Sposalizio della V." –, non può che
sottintendere il fatto che l'osservatore le ravvisi, altrimenti
non avrà modo di penetrare l'arcano ivi riposto in conformità al
suo "obbligo" di artista "maestro" della natura. |
|
IL ROVERETO
ARDENTE |
|
Poche parole sul
"roveto ardente" di biblica memoria che fa coppia ai discussi
piedi nudi di S. Giuseppe, alias Raffaello Sanzio, come ho
anticipato sopra. Quel tanto che basta per introdurre il lettore
"dentro l'opera" attraverso la geometria che in "Sposalizio
della V." si dimostrerà divina, giusto come riteneva l'opera di
Raffaello il Vasari e come anticipato dal titolo di questo
saggio. |
|
|
|
 |
|
|
|
Ma non è una mia
novità aver ravvisato questo "roveto" che Raffaello traduce in
concezione geometrica. Solo che pur intravedendo questa forma
geometrica nessuno vi ha dato una spiegazione esoterica. Tutti
hanno apprezzato il collegamento del tempietto sullo sfondo con
il folto gruppo dei convenuti al matrimonio della Vergine, con
l'armoniosa pavimentazione a raggiera che al centro confluisce
formando un preciso triangolo equilatero (illustrazione 5). Ho
posto per base di questo triangolo la linea che passa appena
sotto l'anello nuziale e precisamente per il polso di S.
Giuseppe, perché è attraverso di esso che confluisce tutta
l'energia del fuoco leonino dell'artista Raffaello una sola cosa
con l'Arte stessa. Ma poi vedremo che questa base in termini
esoterici trova sostegno inequivocabile attraverso la geometria.
Resta ora da porre in evidenza in che modo Raffaello abbia posto
in risalto la solarità di cui si è avvalso per ottenere il
successo che sappiamo. Il quadro è improntato al Cristianesimo
perciò vale la parabola evangelica del sale e del lucerniere sul
moggio da porre in stretta relazione al lucernino della cupola
del tempietto che è appena indicato invece di apparire per
intero come si conviene (dunque è una "disposizione" dissonante
che Raffaello raccomanda di osservare:
«...L'ordine consente di
concentrar l'attenzione su quanto si assomiglia e quanto è,
invece, dissimile; su quanto vicendevolmente si corrisponde o è,
invece, segregato in sé.»)
,si riesce a capire ogni cosa
sulla solarità da sapere. Il sole, perciò, è presumibilmente la
cupola stessa ed è nera perché allusiva alla prima operazione
alchemica, detta appunto Nigredo. Naturalmente, essendo
un'operazione occulta e al nero, la luce, quella del lucernino
del tempietto, non si può vedere ma solo immaginare. Però se si
"entra" nel tempietto (l'invito iniziale "Dentro l'opera") e ci
si dispone sotto la cupola in questione, ecco che guardando in
alto si ha modo di essere inondati dalla luce del lanternino.
Però, mi preme chiarire che la dissertazione esoterica sul conto
di "Sposalizio della V." sin qui esposta, che sembra portare
alla concezione della divinità che Raffaello si proponeva di
tradurre in opera d'arte, non è dell'esperto in me di simili
argomenti. Invece ciò che vale secondo me, ritenendomi
qualificato, è tutto l'itinerario relativo dello sviluppo del
tema della divinità, che come già detto, sarà tradotto in
concezioni della geometria che deve aver praticato il geniale
Raffaello Sanzio per strutturare "Sposalizio Della V.". Resta
pertanto solo la geometria della quale mi faccio garante,
essendo inoppugnabile, poiché in modo traslato, come farò
vedere, porta da sola all'idea della divinità che si attua quasi
in modo magico, poiché ad un tratto i tre personaggi chiave del
quadro in esame, i due sposi ed il sacerdote, da che compaiono
col busto appena chinato si portano in posizione eretta. Sono
posture decisamente anomale, che si aggiungono alle altre testé
rilevate, ma è proprio da qui che verso la fine si delinea la
mia geometria della "trasfigurazione" che doveva essere il fine
cruciale di Raffaello da tradurre in linee e colore, ma che non
riusci a fare. Così come gli allievi di Raffaello completarono
l'opera della "trasfigurazione" del loro maestro dopo la sua
morte, ora è toccato a me, un certo suo "allievo" del futuro,
nemmeno esperto nell'arte pittorica, di concepire in linee
geometriche questo evento dell'anima del mondo perché appaia sul
"monte" nella sua giusta luce sfolgorante.
Sull'idea della "trasfigurazione", che io ho supposto quale tema
principe cui si è accinto Raffaello a tradurre in linee e colori
con "Sposalizio della V.", conta rispondere a questa domanda:
com'era visto Raffaello Sanzio nel suo tempo?
«… era bello e raffinato –
scrive il Vasari – oltre che di grande abilità e colui che sa
creare opere simili non va chiamato uomo ma, se possibile, dio
mortale…».
E venne la morte di questo "dio
mortale", che coincidendo con la sua data di nascita, sembrò
cosa inutile perché fu come se rinascesse deificato, appunto.
Oppure viene da immaginare che la stessa morte non poté che
portarsi via le sole sue spoglie minate al suo petto là dove
egli, col suo cuore interiore, il Leone alchemico, aveva lottato
fino alla fine.
La morte giudica la vita secondo natura ma arrivando a quella di
Raffaello Sanzio, aveva trovato in lui un «ordine nuovo» in seno
alla natura sua, perché così si era prefisso sin dalla prima
giovinezza durata così poco. Ma era anche eccezionale,
smisurato, il fuoco leonino, il suo Zolfo alchemico, che aveva
agito in lui.
Michelangelo Buonarroti commentò:
«… un astro nel mondo si era
spento per sempre …»
,ma era da considerarsi veramente
così? A cominciare dalla "Trasfigurazione", l'opera che egli non
aveva potuto completare e che gli fu posta accanto in punto di
morte, immaginariamente seguita da tutte le sue opere eseguite
in precedenza, non erano altrettanti astri tutt'altro che
spenti, fuoco sotto cenere? Soli sfavillanti che attendevano
forse quel tragico momento per cominciare ad espandere la loro
luce nelle tenebre perché l'accogliessero.
E la fantasia dei contemporanei che sorse dopo la sua morte? Lui
che era diventato per il suo garbo, classe, eleganza, amabilità,
specie con le donne, un tutto per niente invadente e senza
vanagloria, un uomo ideale quasi a rapportarlo alla figura del
Cristo!
Racconta il Conte Pandolfo Pico della Mirandola, il sabato
santo, all'indomani, alla duchessa Elisabetta Gonzaga, sposa di
Guidobaldo da Montefeltro:
«… quando nostro Signore
Raffaello spirò, un grande nembo s'addensò sul Vaticano e
s'aprirono crepe nelle pareti e in cielo apparvero carri; gli
stessi segni della morte di Nostro Signore Gesù Cristo e il
Papa, urlando, scappò all'interno più oscuro dei palazzi
vaticani…»
e fu così che nacque subito una
leggenda: Raffaello morì all'età di 33 anni e non più 37 per
uguagliarlo ancora di più a Nostro Signore.
Manca però a tutt'oggi, al mondo intero dell'Arte, la giusta
visione degli astri che Raffaello rese splendenti, come
suddetto. Manca appunto la sua reale "Trasfigurazione" che lui
non poté completare e perciò furono i suoi allievi a farlo, ma
non tanto da vivificarla perché i veli del suo tempio si
potessero veramente squarciare. E qui si parla ora della sua
Grande Opera dell'Arte Regia, quella che è passata inosservata
fino ai nostri giorni, ma che sembrava profilarsi attraverso
"indizi" abilmente frammischiati negli stupenti e cromatici
scenari dei suoi dipinti. Senza contare su
«...l'obbligo di fare le
cose non come le fa la natura, ma come ella le dovrebbe fare»
, che egli, come pittore, diceva
e quindi doveva assolutamente adempiere per coerenza.
Raffaello assorbì dai diversi suoi maestri, con i quali venne a
contatto, quel che occorreva per celare ad arte i suoi intimi
segreti legati all'Opera edificatrice del suo Tempio di sé
stesso per "porlo", al tempo stabilito, nelle mani di chi
riusciva a raccogliere la sua personale "bottiglia del
naufrago", il suo "Mosé" neonato sul Nilo. E Mosé, come si
vedrà, è veramente il personaggio in cui egli si cela per un
esemplare matrimonio ermetico, quello dell'opera giovanile lo
"Sposalizio della V.", del quale il tema, come già detto, doveva
essere tutto predisposto, nel futuro da venire, per
"trasfigurazione" divina di Raffaello Sanzio. |
|
LA MATERIA
DELL'OPERA - PRIMA FASE DELL'OPERA |
|
|
|
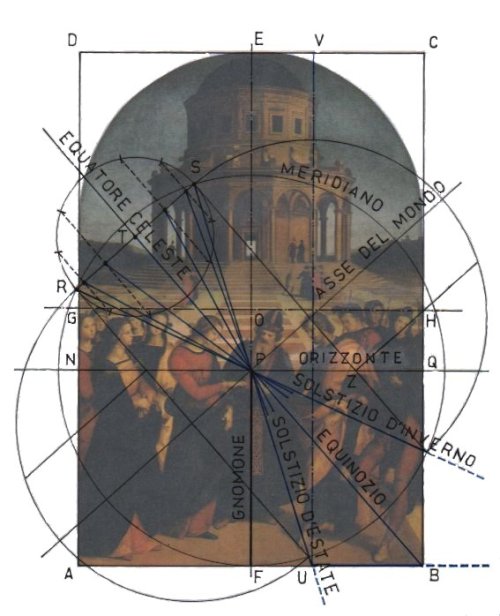 |
|
|
|
Si capisce
subito che la "materia dell'opera" per un qualsiasi artista
della pittura è l'opera stessa, la tavola, la tela o il muro da
affrescare. Perciò, stimando una cosa seria l'alchimia, questi
generi di supporti su cui viene dipinta l'opera – mettiamo – da
un artista profano, diventano per certi versi opere d'alchimia.
Ma in questo modo potrebbero stimarsi alchemiche tutte le opere
dell'uomo.
Tuttavia si è ben lungi dall'Alchimia con l'arte concepita senza
l'indispensabile partecipazione attiva dei tre elementi
costitutivi dell'uomo, spirito anima e corpo, cosa che nel caso
Raffaello Sanzio, come già supposto, è sembrato possibile.
Insomma Raffaello doveva conoscere molto bene le cose
d'alchimia, sulla scorta dell'indagine pittorica fin qui da me
disposta.
Con questo capitolo farò vedere come Raffaello ha concepito
l'impronta ermetica in "Sposalizio della V.", mettendoci sulla
strada a lui congeniale, la geometria.
Per prima cosa, dovendo procedere alla disamina della pala di
Raffaello in questione sotto il profilo della geometria, mi sono
accinto ad verificare il lato dimensionale della tavola su cui è
riportato la pittura. Dico subito che sarebbe stato l'ideale
avere sottomano l'opera in questione che è invece ben custodita
alla pinacoteca di Brera.
Dal web per la maggior parte si rileva che le sue misure
dichiarate sono di 117 x 170 cm. Ho immaginato che si
riferiscono alla parte visibile mentre la pala avrebbe un
contorno in più di 2 cm. per l'alloggio nella cornice con la
quale è esposta a Brera, tant'è che in altri casi di esposizioni
sul web, le misure sono invece 121 x 174.
Però avendo esaminato gran parte delle foto, sia del web e sia
altre rilevate dall'enciclopedia Treccani libri e dalla rivista
Art e Dossier, in buona scala dimensionale, è risultato che il
rapporto della base con l'altezza è diverso da quello derivante
dalle suddette misure. Non è grande la differenza, ma è tale da
impedirmi di avere certezze su cui impostare una serie di
ipotesi di geometria strutturale cui ricorrevano ritualmente gli
artisti del Rinascimento.
Volendo comunque procedere ho dato credito più alle dimensioni
derivanti dalle foto che non alle suddette misure, immaginando
che la misura al netto della pala di "Sposalizio della V." possa
essere 117 x 173 o anche 115 x 170.
A questo punto si hanno abbastanza elementi strutturali per
confrontarli con il grafico da me concepito nel saggio sopra
menzionato, "La geometria astronomica in Sposalizio della V."
Ma è una cosa già fatta e con successo per avere la certezza che
Raffaello si sia servito dell'analemma vitruviano per
dimensionare la sua pala (illustrazione 6). |
|
SECONDA FASE
DELL'OPERA |
|
|
|
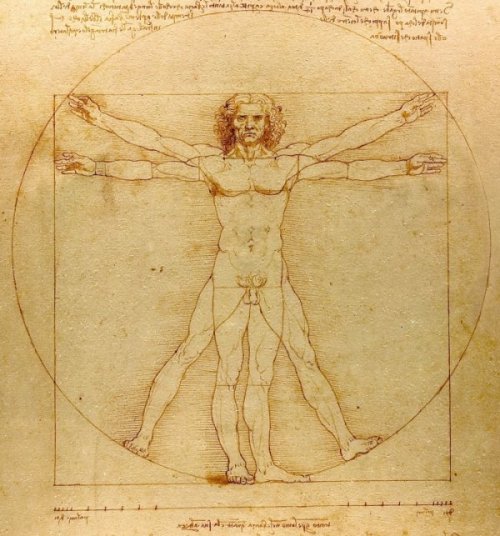 |
|
|
|
Finalmente ora
si va avanti speditamente introducendo la novità su come poté
iniziare i lavori Raffaello (che ipotizzo impostati
sull'esoterismo) nel concepire velatamente la Materia dell'opera
ermetica. Raffaello, attratto fortemente dalle concezioni di
Leonardo da Vinci, pensò bene di partire dall'Uomo Vitruviano
(illustrazione 7) di questi disponendo la Materia della sua
opera con un quadrato di altezza pari a quella della pala di 173
o 170 che, forse, si riferiva alla sua statura fisica.
E, naturalmente, sorge subito la domanda di com'è che dal
quadrato si passa poi al rettangolo arrotondato a semicerchio
superiormente? Ma perché partendo proprio da questo quadrato si
delinea il processo di trasmutazione e con essi il
concretizzarsi delle supposte "nozze alchemiche". Ricorrendo ad
un artificio geometrico si possono avvicinare gradualmente i due
sposi, Maria e Giuseppe. |
|
|
|
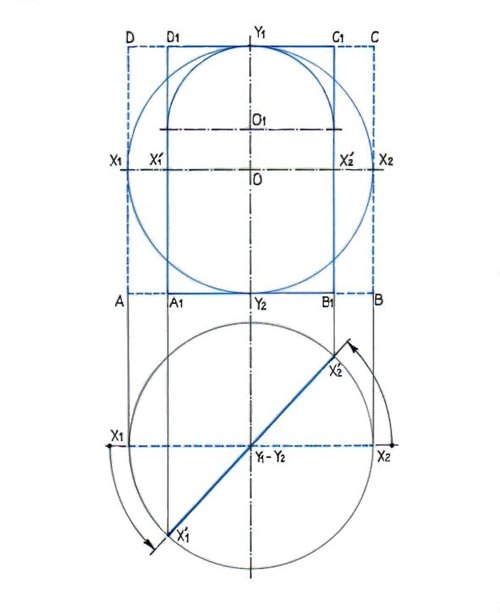 |
|
|
|
Dall'illustrazione
8 si capisce chiaramente come questo può avvenire. Visto in
elevazione la retta tratteggiata X1X2 è il quadrato suddetto che
ruotando di un angolo definito e visto di fronte, si vede come
se fosse rimpicciolito con i nuovi punti sull'asse di mezzeria
con centro 0 in X'1X'2.
Questi punti, che si sono portati verso il centro, danno appunto
l'idea dell'avvicinarsi dei due sposi, Maria e Giuseppe. Vedremo
poi come si può conciliare il ricorso obbligato
all'arrotondamento superiore della pala con il rettangolo
derivato dall'inclinazione del quadrato dell'uomo vitruviano di
Leonardo. |
|
|
|
TERZA FASE
DELL'OPERA |
|
|
|
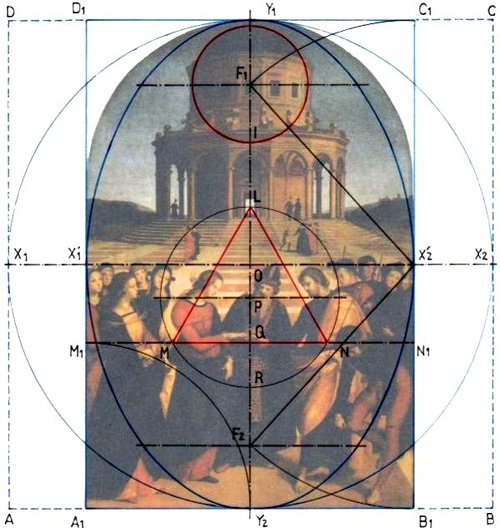 |
|
|
|
Ed ora si
comincia a delineare la meravigliosa geometria di Raffaello con
la quale le due concezioni ermetiche del suo sole e fuoco,
idealmente rappresentate col cerchio e triangolo equilatero
(entrambe in rosso) che non sono stati disegnati a caso come si
vedrà.
Si è visto che dal quadrato dell'uomo vitruviano si passa al
rettangolo della pala, ovvero dal cerchio si passa l'ellisse che
vi corrispondono secondo l'illustrazione 9. La prima cosa che
viene chiarita è che l'ellisse trova buon riferimento alla
suddetta necessità di eseguire l'arrotondamento superiore del
quadro. Subito dopo si scoprono due cose stupefacenti che
permettono al cerchio e il triangolo suddetti (in rosso) di
armonizzarsi con l'ellisse e quindi con la pala nel suo
complesso.
Prima cosa: si punta col compasso in X'2 e con apertura X'2 C1
si traccia un arco fino all'asse verticale mediano nel punto F1
e vediamo che quest'intersecazione coincide con due cose, il
centro del cerchio in rosso ed il punto focale dell'ellisse.
Seconda cosa: si punta il compasso in A1 del rettangolo della
pala A1B1C1D1 e con apertura A1Y2, la metà della base A1B1, si
traccia un arco fino a intersecare il lato verticale A1D1 in M1.
Si traccia poi la parallela M1N1 alla base A1B1 e riscontriamo
che essa coincide con la base MN del triangolo equilatero MNL
(in rosso). Ed ora si passa alle fase successive per scoprire
altre due cose meravigliose, l'apparizione dell'esagramma e
pentagramma, due emblemi cari al Cristianesimo ma anche
all'ermetismo. |
|
QUARTA FASE
DELL'OPERA |
|
|
|
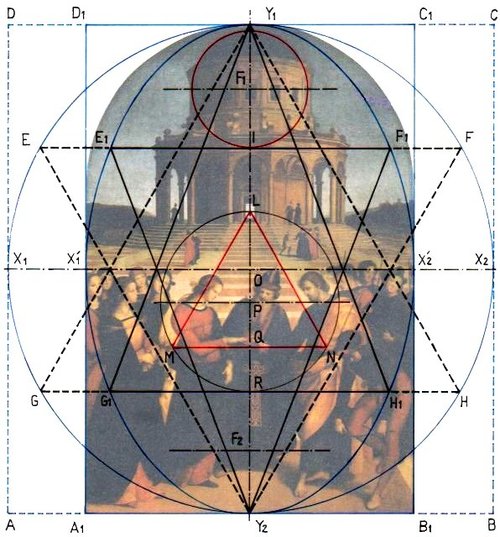 |
|
|
|
Riferendoci
all'illustrazione 10 si comincia a tracciare l'esagramma sul
cerchio relativo al quadrato ABCD. Per fare questo basta segnare
con un archetto di raggio pari a quello del cerchio, i quattro
punti E,F,G e H che non si conoscono, puntando il compasso prima
in Y1 e poi in Y2. Fatto questo si disegna l'esagramma relativo
al cerchio e poi la figura corrispondente sull'ellisse
utilizzando in punti di intersezione E1,F1, G1 e H1 di questa.
Ecco che si scoprono le due cose meravigliose suddette. Il
segmento dell'esagramma E1F1 risulta tangente al cerchio con
centro F1 (in rosso) ed il segmento opposto G1H1 risulta
tangente al cerchio circoscritto al triangolo equilatero MNL (in
rosso).
E qui viene da riflettere sul contenuto emblematico che riguarda
l'esagramma. Se la pala è intonata alla Stella di David, per
sancire che si tratta dell'armonia divina in atto, tale da far
nascere, dal matrimonio di Maria e Giuseppe, Gesù il Figlio di
Dio appunto, deve per forza essere anche intonata al
pentagramma, emblema dell'uomo che sancisce che Gesù è anche il
figlio dell'uomo. Infatti con la rappresentazione grafica del
pentagramma che seguirà sembra concordare ogni cosa detta. |
|
|
|
QUINTA FASE
DELL'OPERA |
|
|
|
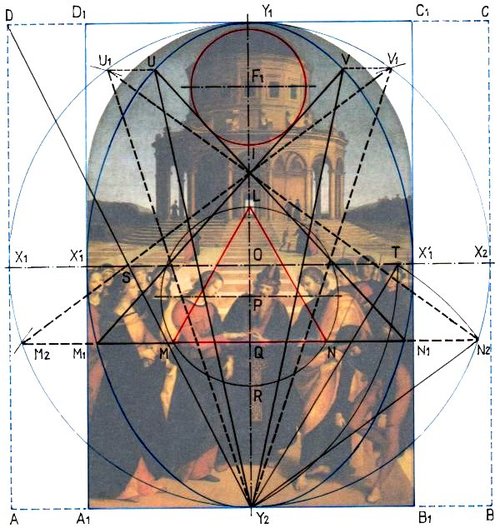 |
|
|
|
Ci si riferisce
all'illustrazione 11. La prima cosa è identificare sul cerchio
relativo al quadrato ABCD il pentagramma ricercato. Si segue il
metodo seguito a scuola di disegno nel modo seguente. Si
individua il punto S tracciando la diagonale DY2 del
semiquadrato AY2Y1D poi, puntandovi il compasso con apertura
SY2, si traccia un arco fino a intersecare l'asse mediano
orizzontale in T. Di qui puntando il compasso in Y2 con apertura
Y2T si traccia un altro arco fino a intersecare il cerchio,
relativo al pentagramma da trovare, in N2. Il resto è facile
ricorrendo al compasso con la stessa apertura precedente Y2T o
Y2N2 per eseguire dei piccoli archetti sul lato opposto in M2 e
successivamente in U1 e e V1 col puntale del compasso in M2 ed
N2.
Anche in questa quinta fase ci sono le belle sorprese perché il
nostro pentagramma trova due coincidenze. Il suo segmento M1N1
con la base del triangolo equilatero MNL (in rosso) e la doppia
tangenza dei segmenti UN1 e VM1 con il cerchio con centro F1 (in
rosso).
A questo punto sorge nell'osservatore la perplessità nel non
accettare la rappresentazione del pentagramma in modo capovolto
che tanto si accosta all'emblema del maligno, Satana.
Ma occorre riflettere per capire che la rappresentazione è più
che coerente per porre in mostra una meravigliosa armonia fra le
due figure e per traslazione il "Figlio di Dio" ed il "figlio
dell'uomo" in Gesù Cristo. Sono i due divini che si compiacciono
fra loro guardandosi come immagini riflesse in uno stagno: di
qui la concezione del Cielo e della Terra. Diversamente, vedendo
i due ideogrammi staccati, ossia di un mondo diviso in sé,
veramente il pentagramma capovolto si riferisce a Satana. |
|
|
|
SESTA FASE
DELL'OPERA |
|
E qui, ora si entra nelle cose del
regno di Dio, perché ciò che non è possibile all'uomo «...è
possibile a Dio». Ricordate la questione evangelica del
«cammello» e della «cruna d'ago» relativa al giovane ricco che
cercava la perfezione? Ma gli fu di impedimento la rinuncia dei
suoi beni che non riusciva ad attuare (Mt 19,16-26; Mc 10,17-27;
Lc 10,18-27). Può dunque la matematica, e per essa la fedele
geometria, non esservi conforme in qualche modo? E se non in chi
serve fedelmente Iddio in nome del Padre, del figlio e dello
Spirito santo, il sacerdote che Raffaello ritrae nella postura,
che vediamo in "Sposalizio della V.", quale segno di
sottomissione?
Dunque, trattandosi delle cose riservate a Dio, nulla che
scandalizzi pensare che esse si attuano al tempo debito, in un
futuro in cui il giusto frutto è maturo per dar luogo alla
perfezione, nel caso di Raffaello, della sua agognata
"trasfigurazione" davanti ai suoi simili.
E qui Iddio si serve del frutto della "scienza del bene e del
male", che solo lui può cogliere, per sbaragliare gli increduli.
Nella fisica ottica tutti i raggi, passanti per uno dei fuochi
di un ellisse, riflettendosi entro di esso convergono all'altro
fuoco per poi ripetersi nello stesso analogo modo il transito
verso il primo fuoco e così via indefinitivamente all'infinito
per approssimarsi sempre più a coincidere con l'asse passante
per i due fuochi. |
|
|
|
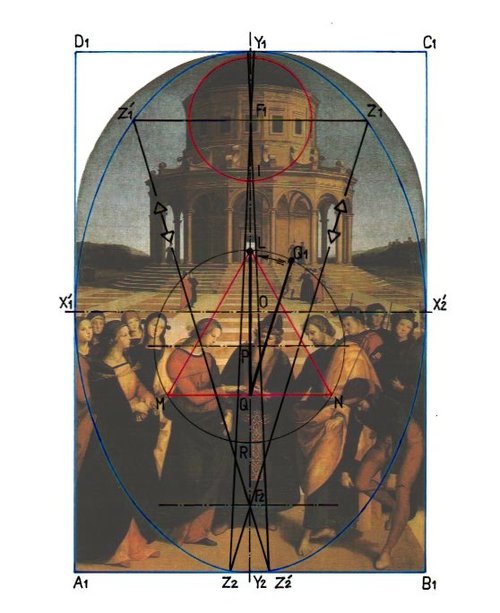 |
|
|
|
Nel caso
dell'illustrazione 12 si tratta del raggio Z1Z2 che passa per il
fuoco F2 e che trova simmetria con il contrapposto raggio Z1'
Z2'. Fatto è che l'asse QQ1, passante lungo il tronco-testa
superiore del sacerdote, risulta parallelo al raggio Z1Z2
suddetto e questo per effetto "induttivo" del potere riposto in
questi vi si adegua facendo suo il potere di orientarsi sulla
verticale se pur con approssimazione.
Naturalmente altri raggi passano per il fuoco F2 per poi
disporsi dopo infiniti riflettersi nel cavo dell'ellisse, e fra
questi vi sono quelli che risultano paralleli alle verghe di S.
Giuseppe e dei suoi amici dietro di lui. Dunque anche queste
verghe, saranno oggetto dell'influsso induttivo dei raggi
paralleli.
Ora sulla base del fatto che è indefinito nel tempo il fenomeno
di riflessione testè descritto, viene da concepire in che modo
si concretizza l'immortalità, nel nostro caso, propria di un
uomo destinato appunto alla divinità assicurato nel Vangelo di
Giovanni 10,34, come già detto.
Mancava a tutt'oggi ‒ ho detto nel capitolo iniziale ‒, al mondo
intero dell'Arte, la giusta visione degli astri che Raffaello
rese splendenti, come suddetto. Mancava appunto la sua reale
"Trasfigurazione" che lui non poté completare e perciò dispose
la sua personale "bottiglia del naufrago", il suo "Mosé" neonato
sul Nilo, attraverso un emblematico Giuseppe sposo di Maria, in
cui egli stesso vi si raffigura, e la affidò al fiume del tempo.
Oggi io lo raccolta e da buon "geometra" ho avuto modo di
adempiere le intime "scritture" pittoriche del maestro di
Urbino, Raffaello Sanzio.
Raffaello ha avuto una grande fede e questo ha permesso alla sua
mano di congegnare la "disposizione" di "Sposalizio della
Vergine" facendo da maestro alla Natura, ma con "sottomissione".
Ed è questo che gli è valso la sua esaltazione e immortalità. |
|
NOTE |
|
•1)
Dal "Trattato della pittura" di Leonardo da Vinci:
Precetti del pittore
«Quello non sarà universale che non ama egualmente tutte le cose
che si contengono nella pittura; come se uno non gli piace i
paesi, esso stima quelli esser cosa di breve e semplice
investigazione, come disse il nostro Botticella, che tale studio
era vano, perché col solo gettare di una spugna piena di diversi
colori in un muro, essa lascia in esso muro una macchia, dove si
vede un bel paese. Egli è ben vero che in tale macchia si vedono
varie invenzioni di ciò che l'uomo vuole cercare in quella, cioè
teste d'uomini, diversi animali, battaglie, scogli, mari, nuvoli
e boschi ed altre simili cose; e fa come il suono delle campane,
nelle quali si può intendere quel dire quel che a te pare. Ma
ancora ch'esse macchie ti dieno invenzione, esse non t'insegnano
finire nessun particolare. E questo tal pittore fece tristissimi
paesi. ...».
Modo d'aumentare e destare l'ingegno a varie invenzioni
«Non resterò di mettere fra questi precetti una nuova invenzione
di speculazione, la quale, benché paia piccola e quasi degna di
riso, nondimeno è di grande utilità a destare l'ingegno a varie
invenzioni. E questa è se tu riguarderai in alcuni muri
imbrattati di varie macchie o in pietre di vari misti. Se avrai
a invenzionare qualche sito, potrai lì vedere similitudini di
diversi paesi, ornati di montagne, fiumi, sassi, alberi, pianure
grandi, valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai vedere
diverso battaglie ed atti pronti di figure strane, arie di volti
ed abiti ed infinite cose, le quali tu potrai ridurre in integra
e buona forma; che interviene in simili muri e misti, come del
suono delle campane, che ne' loro tocchi vi troverai ogni nome e
vocabolo che tu t'immaginerai. Non isprezzare questo mio parere,
nel quale ti si ricorda che non ti sia grave il fermarti alcuna
volta a vedere nelle macchie, de' muri, o nella cenere del
fuoco, o nuvoli o fanghi, od altri simili luoghi, ne' quali, se
ben saranno da te considerati, tu troverai invenzioni
mirabilissime, che destano l'ingegno del pittore a nuove
invenzioni sì di componimenti di battaglie, d'animali e
d'uomini, come di vari componimenti di paesi e di cose
mostruose, come di diavoli e simili cose, perché saranno causa
di farti onore; perché nelle cose confuse l'ingegno si desta a
nuove invenzioni. Ma fa prima di sapere ben fare tutto le membra
di quelle cose che vuoi figurare, così le membra degli animali
come le membra de' paesi, cioè sassi, piante e simili ...». |
|
|
|
|
|
|
|