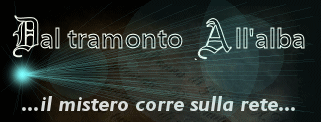|
|
 |
| |
|
Raffaello
Sanzio - Geometria Astronomica in Sposalizio della Vergine |
|
a cura di
Gaetano Barbella |
| |
|
L'ORDINE NELLE
OPERE DI RAFFAELLO |
|
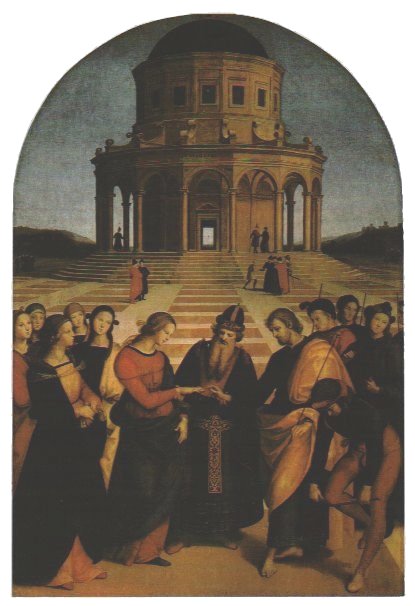 Scrive
Raffaello: «il pittore ha
l'obbligo di fare le cose non come le fa la natura, ma come ella le
dovrebbe fare». Ed ancora:
«Qualunque cosa la mente
umana si trovi a dover comprendere, l'ordine ne è una indispensabile
condizione. Disposizioni quali la planimetria di una città o di un
edificio, un insieme di utensili, un'esposizione di mercanzia, la
manifestazione verbale di fatti o di idee, ovvero quali un dipinto o
un brano musicale, sono disposizioni dette tutte ordinate quando sia
possibile a chi le osservi o le ascolti per coglierne la struttura
generale ed anche il diramarsi di essa in una certa articolazione di
dettaglio. L'ordine consente di concentrar l'attenzione su quanto si
assomiglia e quanto è, invece, dissimile; su quanto vicendevolmente
si corrisponde o è, invece, segregato in sé.». Scrive
Raffaello: «il pittore ha
l'obbligo di fare le cose non come le fa la natura, ma come ella le
dovrebbe fare». Ed ancora:
«Qualunque cosa la mente
umana si trovi a dover comprendere, l'ordine ne è una indispensabile
condizione. Disposizioni quali la planimetria di una città o di un
edificio, un insieme di utensili, un'esposizione di mercanzia, la
manifestazione verbale di fatti o di idee, ovvero quali un dipinto o
un brano musicale, sono disposizioni dette tutte ordinate quando sia
possibile a chi le osservi o le ascolti per coglierne la struttura
generale ed anche il diramarsi di essa in una certa articolazione di
dettaglio. L'ordine consente di concentrar l'attenzione su quanto si
assomiglia e quanto è, invece, dissimile; su quanto vicendevolmente
si corrisponde o è, invece, segregato in sé.».
Detto questo, col presente saggio, non mi pongo subito la questione
di capire come Raffaello intenda l'"ordine" con il quale egli si
prefigge di correggere la natura, attraverso le sue opere pittoriche
ed altro. Ma seguendo le relative possibili "disposizioni" cui egli
si è attenuto in virtù di quanto egli stesso assicura di fare di
proposito, mi preme mettere a fuoco non poche avvisaglie anomale che
mi è parso di riscontrare in una sua opera in particolare,
"Sposalizio della Vergine". Una volta riscontrato con assoluta
certezza tale sua "disposizione" in tutti i possibili dettagli e
implicazioni, mi dispongo a procedere per intenderne la possibile
ragione che ha mosso Raffaello, di certo per far da maestro alla
natura come egli, da buon artista della pittura, si "obbliga" di
fare.
In questa ottica dunque, nulla di strano che Raffaello abbia
manipolato a bella posta la visione reale delle cose di "Sposalizio
della V.", visto che in questa sede si concentra la mia attenzione.
Un'opera che, secondo me, non è stata veramente svelata, proprio
perché l'autore deve avere "disposto" ad arte i dettami suddetti. Da
buon iniziato, a lui premeva che fossero celati nel tempo perché
maturasse in modo occulto la sua personale didattica sulla natura
che solo in tal modo è in grado di "accettare" gli ammaestramenti
dagli uomini disposti a far loro da maestri. E non meraviglia che la
natura arrivi anche a tale previdenza per salvaguardare il processo
di generazione che potrebbe subire deviazioni incontrollate, a causa
di possibili imprevisioni del progetto creativo degli albori della
creazione. Ma è così anche per i tanti iniziati alle arti occulte,
operanti nel tempo in tanti modi per il bene dell'umanità. Ecco una
visione razionale di un procedere evolutivo in cui l'uomo svolge una
duplice funzione: quella di "studente" che impara e si sviluppa e
l'altra di "maestro" che insegna.
Onde la Vergine che si unisce al suo sposo Giuseppe in "Sposalizio
della V.", ovvero al maestro d'Arte in Raffaello è la Natura stessa
che si dispone alla trasmutazione, quasi predisposta con
impercettibile alchimia attraverso modificazioni strutturali che
poco o niente sembrano differire dalla esatta disposizione
geometrica secondo la perfezione. Si tratta come si vedrà di
rappresentazioni geometriche che Raffaello tenta e con successo, di
"sposare" fra loro con una sola immagine pittorica. Ed è qui la vera
maestria del divino Raffaello, appunto.
Entrando ora nel vivo di "Sposalizio della V.", il tema è in che
modo abbia potuto inserire in tale contesto, ciò che ho supposto in
anteprima col titolo di questo saggio, una inconsueta geometria
astronomica. È davvero un'impresa fuori dai canoni introdurre il
concetto dell'astronomia in un tema pittorico ed in particolare in
quello di "Sposalizio della V." e se Raffaello veramente lo ha fatto
è davvero mirabile. Come a voler stigmatizzare quest'opera con lo
stesso «fulgore» che percosse la mente del sommo poeta Dante
facendogli concludere la sua Commedia con «l'amor che move il sole e
l'altre stelle». In materia d'arte questa concezione riferita
all'astronomia ha trovato sostegno in un'opera architettonica di
notevole pregio, Castel Del Monte che, secondo taluni, fu fatto
erigere dall'imperatore Federico II di Svevia su ispirazione dei
Templari.
|
|
|
|
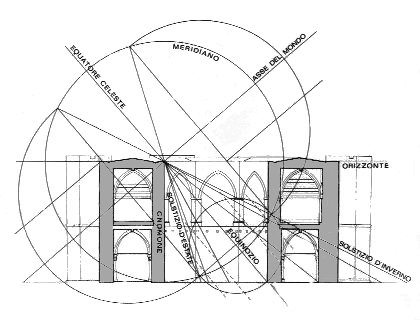 |
|
|
|
Infatti le
proporzioni di questo castello, secondo studiosi degni di stima,
sono state disposte in modo da fungere da segna tempo facendo
capo alla teoria vitruviana dell'analemma dello gnomone.
La gnomonica è lo studio delle ombre proiettate da un bastone
conficcato in terra, ombre che consentono di stabilire le ore
del giorno, i giorni dell'anno, la latitudine del luogo, la
forma e la grandezza della Terra. L'architetto romano Vitruvio,
vissuto al tempo dell'imperatore Augusto, per la realizzazione
dei suoi analemmi (sono i diagrammi dalla caratteristica forma a
"8", che mettono in relazione il giorno dell'anno, la
declinazione del Sole, cioè la sua distanza angolare
dall'equatore celeste, e l'equazione del tempo) adottava nella
zona di Roma il rapporto 8/9 come latitudine e l'angolo di 24°
come inclinazione dell'eclittica, in quanto tale misura divide
il cerchio mediano in pentadecagono (360°/24° = 15).
Nella figura sopra: la linea dell'equinozio è la diagonale del
triangolo rettangolo formato dallo gnomone, l'altezza del
castello, pari a 9 e dalla base, il cortile interno del
castello, pari a 8; mentre l'angolo di 24°, che in questo caso è
diverso da questo angolo essendo la latitudine locale diversa da
quella di Roma della teoria di Vitruvio, è pertanto quello
relativo compreso dalle semirette dell'equinozio e il solstizio
invernale da un lato e il solstizio d'estate dal lato opposto.
Chiusa, per il momento, la parentesi sull'analemma dello gnomone
vitruviano e riprendendo la discussione su "Sposalizio della
V.", ci si rende conto che questa opera è composta di due parti
distinte di cui quella superiore si presenta come "distaccata"
dal gruppo dello sposalizio in basso.
Ed è questa parte superiore che sarà oggetto di discussione del
presente scritto, rimandando ad un successivo saggio la
trattazione dell'altra parte suddetta.
Si tratta di un tempietto garbatamente architettato, che sembra
troneggiare, ma con moderazione. Tutti concordano nel
paragonarlo al tempietto di S. Pietro in Montorio a Roma
(1502-3) progettato da Donato Bramante. Dunque ecco la
costruzione architettonica posta – io dico a bella posta – da
Raffaello per fare concentrare l'attenzione dell'osservatore,
tanto per cominciare, senza per questo trascurare di fare la
stessa cosa al gruppo degli sponsali. Il maestro di Urbino ha
disposto le cose in modo che la pala, proporzionata al
rettangolo ricavato dall'analemma suddetto, sia in armonia con
l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci del quale si serve per
sviluppare lo scenario del gruppo degli sponsali. Ma com'è
possibile una tal cosa visto che si tratta di due geometrie
diverse (l'uomo disposto in un quadrato che poi si ritroverebbe
in un rettangolo)? Eppure farò vedere che Raffaello è stato
capace di trovarne la geometria confacente, non solo, ma è
andato ben oltre a questa concezione così inconsueta...
Ritornando al tempietto da esaminare, essendo un'opera
architettonica nulla deve aver vietato a Raffaello, che mirava a
far sbalordire i suoi conterranei, dapprima tutti suoi maestri,
di servirsi dei canoni di Vitruvio, di cui Leonardo da Vinci ne
fu il proseguitore, ma che dovette trovare Raffaello pronto a
trovarne le giustapposizioni in Sposalizio della Vergine,
appunto. Ma, come già accennato, anche per il gruppo degli
sponsali è di scena ancora Vitruvio con l'uomo vitruviano di
Leonardo da Vinci. |
|
|
|
UN TEMPIETTO CHE
LASCIA PERPLESSI |
|
|
|
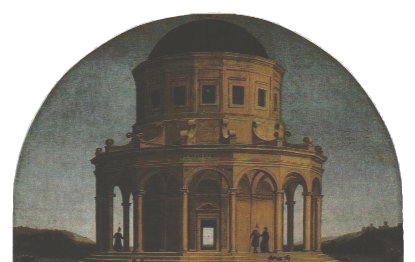 |
|
|
|
La domanda che
pongo all'osservatore, ora, è di concentrare l'attenzione su
questo tempietto che secondo l'opinione generale dei critici
d'arte, Raffaello, nel dipingerlo con queste proporzioni, si è
ispirato al tempietto di S. Pietro in Montorio a Roma (1502-3)
progettato da Donato Bramante. Infatti così sembra ma fino ad un
certo punto perché si ingenerano diverse anomalie in materia
dell'invocato "ordine" geometrico di Raffaello stesso in questo
caso.
Se il tempietto in osservazione fosse realmente proporzionato
come quello suddetto del Bramante che è di 16 colonne, non
dovrebbero presentarsi ai due lati i pilastri sul retro. Si sa
che in un esadecagono la parte anteriore degli otto spigoli è
simmetrica a quella posteriore dei restanti otto spigoli,
mentre, a quanto pare non è nel caso in questione.
Non solo, ma in qualsiasi poligono regolare, disposto
anteriormente come nella figura in osservazione, il lato di
centro frontale è maggiore della proiezione dei due lati
accanto, mentre nel tempietto di Sposalizio della Vergine questo
lato è appena appena maggiore, ma di pochissimo, di quelli
laterali, e questo non basta.
Quindi se non è un poligono di sedici lati la base della
pilastratura del tempietto, a ragione dei pilastri laterali del
retro che si vedono, dovremo considerare che il poligono è di
quindici lati, facendo finta che i pilastri frontali siano
disposti in modo conforme. Però resta un serio ostacolo a quest'altra
ipotesi, il fatto che il supposto pilastro centrale posteriore
si dovrebbe intravedere attraverso la porta centrale illuminata
(che lascia intendere la presenza di un'altra nella parte
opposta, infatti così è per il tempietto di paragone di S.
Pietro in Montorio di Roma).
Ma è vero anche che se Raffaello si è proposto di disegnare la
geometria di questo tempietto in modo da far compenetrare
diverse sue soluzioni architettoniche – mettiamo della
pilastratura in questione –, non poteva che architettarsi così
come ha fatto per lasciare intendere due o più concezioni che
riguardano l'astronomia come farò vedere.
Non resta che vedere la cosa con riga e compasso e rendercene
conto con delle certezze geometriche che si mostrano evidenti
con la figura che segue. |
|
|
|
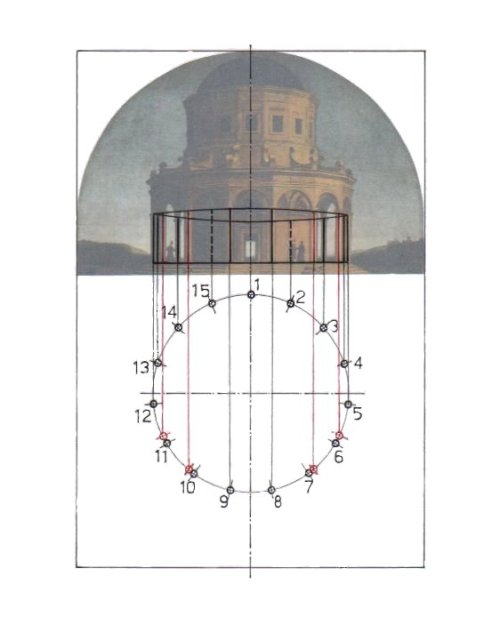 |
|
|
|
Ci voleva
proprio, disegnare le ipotesi testé fatte a lume di naso e
occhio, per convincerci sulle ipotesi fatte che vede fondata la
"disposizione" dei pilastri tutta orientata per il pentadecagono
e immaginare che a causa di una certa "ombra", di cui fra poco
se ne parlerà, non ci si accorge del pilastro numero 1 della
figura sopra. Come si vede tutto è ben disposto eccetto le due
coppie di pilastri (in rosso) 6, 7 e 10,11, ma così come sono
poste (irregolarmente) non destano turbamenti, infatti mai alcun
critico d'arte, ch'io sappia, lo ha rilevato.
Vedremo poi perché quest'anomalia. Intanto ci si pone
immediatamente il perché del pentadecagono e non l'esadecagono
del tempietto di paragone del Bramante. Con l'esadecagono si
poteva pensare alla simbologia della stella di Davide che vi può
derivare, mentre con il pentadecagono è il pentagramma a far da
simbolo relativo. Questo può pure andare, ma nel rendermi conto
di questo pentadecagono ho subito pensato all'analemma Di
Vitruvio che sfrutta le ombre dello gnomone illuminato dal sole
per stabilire le variabili del tempo durante l'anno. Di qui la
possibilità che Raffaello, attraverso l'ombra di uno gnomone –
poi vedremo quale –, ha cercato di proporzionale la sua tavola
su cui poi ha dipinto "Sposalizio della V.". In merito alla
questione dell'esadecagono e pentagramma poc'anzi sfiorata, è
sta stimarsi come anticipazione di relative geometrie che
svilupperò nel saggio successivo a questo su "Sposalizio della
V.". |
|
|
|
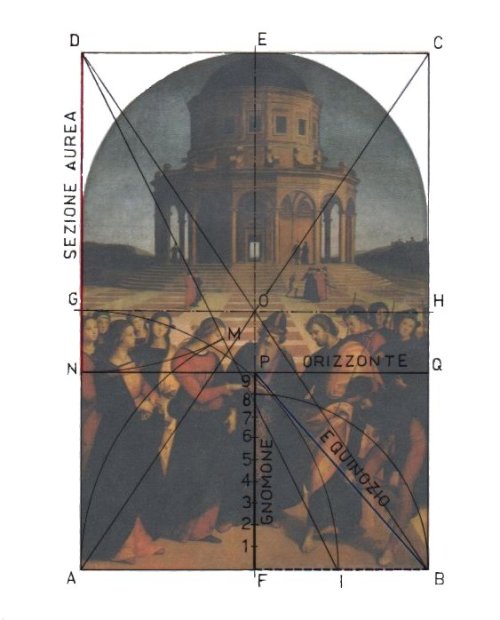 |
|
|
|
Riprendendo il
tema sullo gnomone vitruviano da sviluppare, sempre con riga e
compasso, mi sono accinto a concepire la base di partenza per
stabilire che gnomone disporre sul quadro di Sposalizio della
Vergine e subito ho pensato che potesse essere ciò che resta
dell'unità (immaginando l'altezza della pala pari a 1) se si
detrae la relativa sezione aurea. Ora guardando la figura sopra
ho fatto queste operazioni per giungere alla rappresentazione
della sezione aurea. Si tracciano le diagonali della tavola di
"Sposalizio della V." che è il rettangolo ABCD. Rintracciato il
centro O si tracciano poi gli assi mediani FG e GH, poi col
compasso puntato sul centro A e con apertura AG si segna un arco
fino al punto I sulla base AB. Indi si congiunge I con D e si
traccia un successivo arco con centro in I e con la stessa
apertura precedente, fino ad incontrare l'ipotenusa ID nel punto
M. Puntando poi il compasso in D con apertura DM, si esegue
l'arco fino ad intersecare il lato verticale Ad del quadro in N.
Ecco che DN è la sezione aurea di AD ricercata. Dopodiché lo
gnomone, come ho stabilito in precedenza, è il segmento NA che
per comodità didattica preferisco considerarlo mediano, ossia il
segmento PF.
Procediamo poi per la determinazione del raggio equinoziale che,
secondo Vitruvio, interseca la base relativa all'ombra prodotta
dallo gnomone in un punto che è distante dalla base dello
gnomone di un'entità numerica dettata dal rapporto di 8/9
valevole per Roma però. Ma il tempietto in osservazione è stato
immaginato all'insegna di quello di S. Pietro in Montorio che è
di Roma, quindi il rapporto anzidetto di 8/9 va più che bene.
E qui la sorpresa nel vedere che l'ombra relativa alla fase
equinoziale corrisponde esattamente al limite estremo B del
quadro in esame. Resta ora da completare l'opera intrapresa e
disegnare di seguito l'analemma sul quadro di "Sposalizio della
V." per perfezionare lo studio che porta all'ipotesi di partenza
che vede l'astronomia in perfetta armonia con quest'opera di
Raffaello in osservazione.
Ora vorrei far riflettere sulla portata dell'idea vitruviana
suddetta nel contesto di uno speciale sposalizio. Quale
migliore, e addirittura meravigliosa concezione, di servirsi di
un segno equinoziale della portata astronomica! Al cospetto di
questa prospettiva raffaellesca non sto nella pelle e debbo
convenire col Vasari quando dice di Raffaello queste parole:
«... era bello e raffinato oltre che di grande abilità e colui
che sa creare opere simili non va chiamato uomo ma, se
possibile, dio mortale...». |
|
|
|
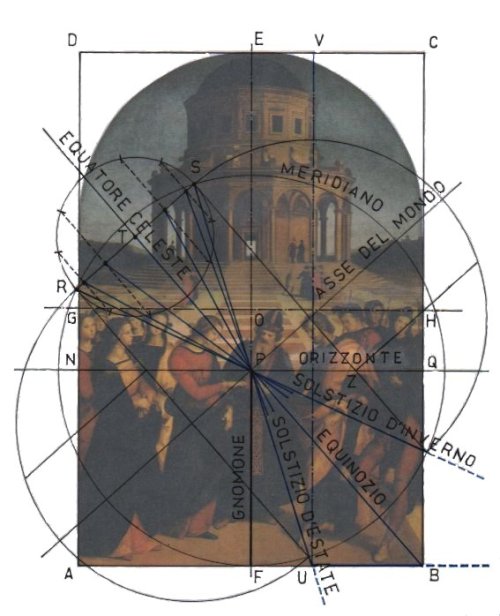 |
|
|
|
Completato il
grafico che si vede sopra in figura, con piacevole sorpresa si
aggiungono altre due interessanti coincidenze. La prima completa
l'individuazione del quadro di Raffaello col punto H dell'asse
mediano orizzontale grazie alla proiezione del punto Z comune
all'orizzonte dell'analemma con l'asse del cerchio vernale
(derivato dal solstizio relativo). E così abbiamo la prova
(ipotetica) di come abbia "disposto" le sue pennellate Raffaello
per proporzionale il suo capolavoro. Resta la seconda
coincidenza che, attraverso il punto U sulla base AB del quadro
(individuato dal raggio solare del solstizio d'estate), trova
relazione con una colonna del tempietto in alto. Si tratta,
guarda caso, del pilastro anomalo, insieme a quello accanto, che
non si armonizzano, sia con la disposizione della pilastratura
secondo un esadecagono (come il tempietto di S. Pietro in
Montorio romano), sia con la disposizione secondo un
pentadecagono precedentemente analizzato e disegnato.
A questo punto ho immaginato che Raffaello abbia voluto
suggerire una terza cosa a perfezionamento del legame del tema
della sua opera di "Sposalizio della V." con la realtà temporale
attraverso l'astronomia, appunto. E così mi sono accinto a fare
un altro disegno per vedere se la disposizione anomala dei
pilastri 6,7 e 10,11 in rosso, della figura della pilastratura a
forma di pentadecagono precedentemente esposta, dia luogo ad
un'altra forma di poligono regolare. |
|
|
|
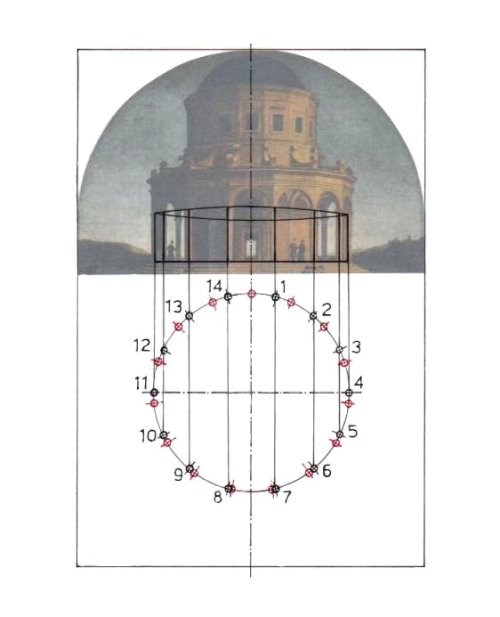 |
|
|
|
Infatti,
guardando il nuovo disegno, sopra in bella vista, risulta che i
quattro pilastri anomali si armonizzano con un tetradecagono.
Che vorrebbe significare questa ulteriore "disposizione",
dunque? L'unica idea che mi viene da pensare è che si possa
riferire a tutto ciò che della realtà temporale immaginata in
precedenza e comprovata (restando sempre un'ipotesi, ovviamente)
con l'analemma vitruviano attraverso il concetto legato al
numero sette. Di qui l'idea della settimana in relazione al
tempo, ma anche alla scala dell'armonia musicale, ai colori
dell'iride! Per non parlare delle 4 fasi del mese lunare che è
di 28 giorni. |
|
|
|
|
|
|
|