|
Per Giacomo Leopardi, la
Luna sta nel cielo,
immota, immobile,
vergine, incurante delle
umane disgrazie,
lontana,
irraggiungibile. E’
ancora così? Nel 1987,
nelle librerie
statunitensi comparve un
libro che fece scalpore
e che valse, al suo
autore, la creazione di
un fascicolo tutto suo
negli archivi della CIA.
L’uomo in questione è
Bill Kaysing, direttore
delle pubblicazioni
tecniche presso la
Rocketdyne Research, la
ditta che ha progettato
e realizzato i motori
per i viaggi lunari; il
libro è We never went to
the Moon, Non siamo mai
andati sulla Luna
nell’edizione italiana
della Cult Media Net
Edizioni del 1997.
L’intero libro, come si
capirà dal titolo,
ruotava intorno alla
convinzione, suffragata
e avvallata da
moltissime immagini e
documenti più o meno
segreti portati
dall’autore, che l’uomo
non fosse mai andato
sulla Luna e che, di
conseguenza, l’intero
programma Apollo della
NASA fosse un’enorme
balla. Il volume
descrive quelle che sono
le trame segrete
governative per la
costruzione di questa
epocale messa in scena,
trame che hanno
protagonisti nel
governo, ovviamente,
negli ambienti
dell’agenzia spaziale
americana e,
soprattutto, negli
astronauti. La trama,
chiaramente, è molto
complessa: di
conseguenza, in questo
scritto, ci
concentreremo
soprattutto delle prove
fotografiche portate da
Kaysing a conferma della
sua idea, forse le prove
più facili da valutare,
rispetto a misteriosi ed
oscuri documenti
governativi, che
richiederebbero
discussioni e
disquisizioni eterne; di
seguito, ci
concentreremo su quali
siano stati i motivi per
la costruzione di una
messa in scena di questo
tipo.
Prima di procedere
all’analisi delle foto,
alcune caratteristiche
tecniche, utili
soprattutto per chi si
intende di fotografia.
La NASA utilizzò, per
tutte le missioni
lunari, apparecchi
fotografici Hasselblad,
macchine usate per
ritratti, paesaggi e
nature morte: il meglio
del tempo, le più
moderne che la
tecnologia potesse
offrire. Il mirino si
trovava nella parte
superiore
dell’apparecchio, cosa
ottimale per gli
astronauti, che avevano
la macchina montata sul
petto. L’obbiettivo era
da 250 mm a fuoco fisso,
quindi relativamente
facile ed immediato da
usare. Il pulsante dello
scatto era inserito nei
guanti di gomma della
tuta. Il formato delle
foto era quadrato.
Passiamo ora alle foto,
provenienti dai books
fotografici di tutte le
missioni Apollo,
cominciando, ovviamente,
da quelle della missione
Apollo 11.
[Nota:
le sigle riportate sotto
le foto corrispondono ai
numeri di
identificazione usati
dall’ente spaziale
americano per siglare
ogni fotografia. Per
comodità di
impaginazione, le
immagini sono state
ridotte nelle
dimensioni.]
La prima immagine che
andremo ad analizzare è
una “cartolina” dalla
Luna, precedente
all’atterraggio, che ci
lascia un po’ perplessi
e sulla quale è bene
fermarsi un momento.

AS11-37-5437
L’ombra che si può
osservare in basso a
sinistra è quella
prodotta dall’ugello del
modulo di comando
dell’Apollo 11. In base
a quanto affermato dalla
NASA, tale ombra aveva
una lunghezza di 95
chilometri ed era
proiettata ancora sulla
faccia visibile della
Luna. Gli occhi
terrestri puntati sulla
superficie del nostro
satellite, quel giorno
di luglio, erano
certamente più di un
paio e grande sarebbe
stata l’emozione che,
vedere in prima persona
tale ombra, avrebbe
prodotto in tutti gli
spettatori terrestri.
Tuttavia, la NASA non
fece mai riferimento a
quest’ombra nei momenti
direttamente precedenti
all’atterraggio. E dire
che sarebbe stata
un’ottima pubblicità,
per l’agenzia americana.
Perché questo silenzio?
Forse l’ombra era
impossibile da vedersi?
A parte questo fatto,
ciò che colpisce è
l’incredibile perfezione
dei bordi dell’ombra. In
genere, tanto più un
corpo è lontano dalla
fonte di luce (od anche
dalla superficie sulla
quale viene gettata
l’ombra), tanto più i
contorni dell’ombra che
produce risultano
indefiniti;
contemporaneamente, il
“colore” dell’ombra
stessa non appare più
nettamente nero, ma
varia lungo tutta la
scala di grigi. Quest’ombra
di 95 chilometri, oltre
ad essere esageratamente
grande, è anche
incredibilmente
perfetta, nella forma e
nel colore.
Il LEM si è staccato dal
modulo di comando
Columbia ed inizia
l’atterraggio sul suolo
lunare.
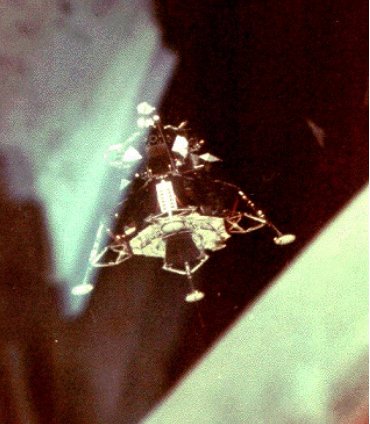

AS11-44-6574
AS11-44-6598
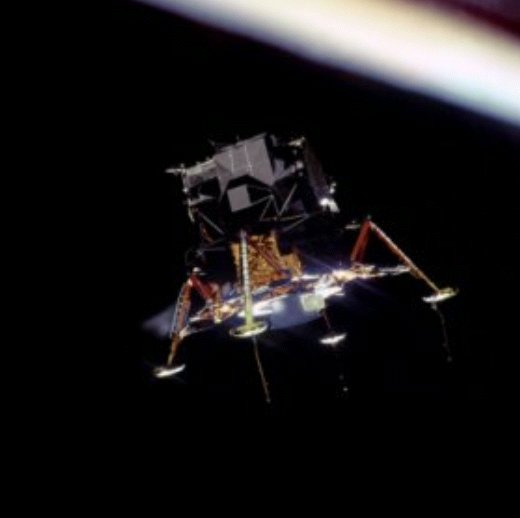
AS11-44-6581
Sono foto
incredibilmente perfette
sia dal punto di vista
dell’inquadratura
(ricordiamo che gli
astronauti galleggiavano
nella loro navicella
priva di gravità) che
dell’illuminazione, che,
con questi effetti di
luce rosata e azzurra,
rendono quasi magici i
momenti dell’allunaggio.
L’ultima immagine, in
particolare, pare
l’illustrazione di un
romanzo di
fantascienza…
Il LEM è atterrato e gli
astronauti iniziano la
discesa sul suolo
lunare. Un momento
storico senza
precedenti, un momento
che celebra la grandezza
del genio umano, in
grado di varcare i
confini terreni imposti
dal destino.

AS11-40-5863
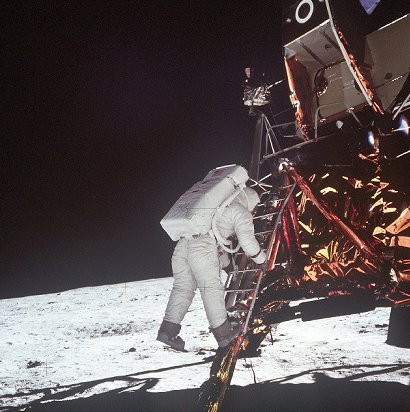
AS11-40-5868

AS11-40-5869
Due fatti,
principalmente, in
riferimento a queste
foto. Il primo riguarda
la terza immagine: tutti
gli obiettivi delle
macchine fotografiche
usate dagli astronauti
erano supportate da
“crocette”, utili a
centrare e raddrizzare
l’oggetto della foto
nell’obiettivo. In
questa immagine,
dicevamo, le “crocette”
sono storte:
evidentemente
l’astronauta che scattò
la foto era in posizione
non proprio verticale
rispetto al terreno;
l’orizzonte, però, è
perfettamente
orizzontale. L’altro
fatto riguardante queste
immagini è la misteriosa
sparizione dei negativi
delle foto. Un fatto ben
strano, visto che si
tratta delle prime due
immagini tratte
dell’uomo sulla Luna.

AS11-40-5864
Questa immagine mostra
il suolo sotto il LEM in
seguito all’atterraggio.
Secondo quanto affermato
da Armstrong, la polvere
sollevata dai razzi
frenanti durante
l’atterraggio era tale
da mettere in pericolo
lo stesso atterraggio.
Un tale movimento di
polvere avrebbe dovuto
quantomeno creare un
piccolo cratere sotto al
LEM. Eppure, il suolo è
intatto. A questo si
aggiunge un’altra
stranezza: nonostante il
suolo polveroso, le
parti color oro del LEM
non si sono minimamente
sporcate.

AS11-40-5920
Questa strana anomalia è
riscontrabile anche
osservando i “piedi” del
modulo di atterraggio.
Vista la consistenza del
suolo lunare, costituito
da una sabbia a grana
irregolare e soffice,
essi avrebbero dovuto
almeno affondare di
qualche centimetro nel
terreno. Invece…

AS11-40-5880
Un discorso simile si
può fare anche riguardo
alle impronte degli
astronauti nel terreno.
Le impronte lasciate
dagli scarponi sono un
po’ troppo regolari e
pulite per essere state
lasciate su un suolo
sabbioso. Sembra quasi,
invece, vista la loro
perfezione, che siano
state lasciate nella
creta. Un ottimo
surrogato terrestre del
terriccio lunare è un
miscuglio di pozzolana,
pietra pomice e cenere
vulcanica.
A questo punto, gli
astronauti Armstrong ed
Aldrin, per sancire
ufficialmente davanti al
mondo il primato
statunitense nella
conquista dello spazio,
piantano, nel suolo
lunare, la bandiera
americana.
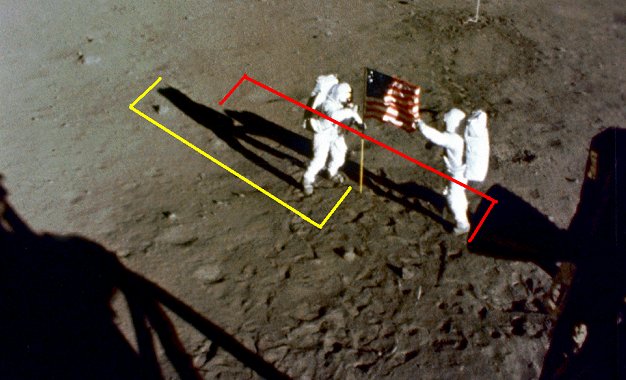
S69-40308
Quello che balza
immediatamente
all’occhio, riguardo
questa foto, è l’enorme
disparità nella
lunghezza delle ombre
gettate dai due
astronauti. Ora, la
lunghezza di un’ombra di
un oggetto proiettata
sul terreno è
determinata
dall’altezza, rispetto
alla linea
dell’orizzonte, della
fonte di luce. Per fare
un esempio, alla massima
altezza, ossia allo
zenit, un corpo non avrà
alcuna ombra, in quanto
il sole sarà
perfettamente
perpendicolare
all’orizzonte; alla
minima altezza del sole,
invece, cioè al tramonto
o all’alba, un oggetto
avrà un’ombra alla
massima lunghezza. In
questo caso, la
differenza di lunghezza
delle ombre è spiegabile
con un unico motivo: ci
sono due fonti di luce
distinte. Il che,
inutile dirlo, è cosa
assai strana, nello
spazio, dove l’unica
fonte di luce dovrebbe
essere il Sole.
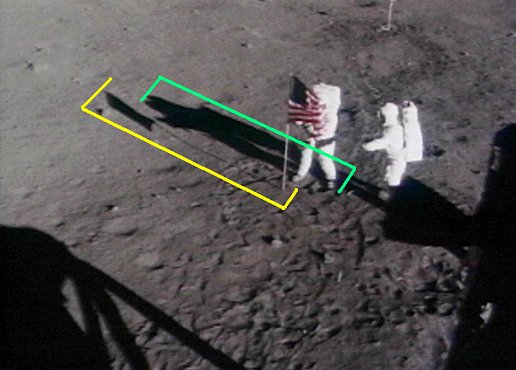
A questo si aggiunge,
inoltre, un altro fatto:
incredibilmente, la
lunghezza dell’ombra
della bandiera americana
è, proporzionalmente,
uguale a quella
dell’ombra
dell’astronauta
all’estrema sinistra.
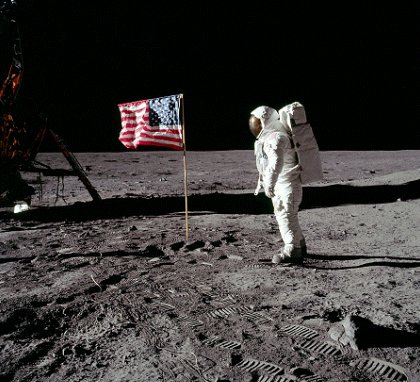
AS11-40-5874
Un’altra immagine di
Aldrin di fronte alla
bandiera americana.
Questa foto soprattutto,
ma anche tutte le altre,
ci fa sorgere un dubbio.
Per usare le parole di
Kaysing, “perché in
tutte le foto delle
missioni lunari le
uniche stelle visibili
sono quelle della
bandiera statunitense?”
I corpi celesti luminosi
sono visibili ad occhio
nudo dalla Terra
nonostante i molti
strati di gas
atmosferici che ne
smorzano la luminosità
relativa: a maggior
ragione, sulla Luna,
dove l’atmosfera è del
tutto assente e perciò
non ci sono “filtri”
alla luce, le stelle
dovrebbero essere non
solo visibili, ma anche
molto più luminose.
Eppure, un misterioso
buio cosmico è presente
in tutti gli sfondi
lunari.

Inoltre, cosa
incredibile per tutti
meno che per Peter Pan e
per gli astronauti
Apollo, l’ombra della
bandiera americana è
scomparsa dal terreno!
Parliamo ancora di ombre
ed osserviamo questa
fotografia.

AS11-40-5927
L’ombra del LEM sembra
sfiorare lo sfondo nero,
che, però, è troppo
vicino per essere
all’orizzonte. Il sole,
infatti, è in alto e non
sull’orizzonte, come
dimostrano le ombre
gettate dal LEM sotto di
esso. Una spiegazione è
che il modulo sia
atterrato sulla montagna
più alta della Luna,
montagna che, guarda un
po’, ha una cima piana
ed abbastanza ampia da
consentire un
atterraggio. Un’altra
spiegazione è che il
cielo nero sia un
fondale fotografico.

AS11-40-5961
In tutte le fotografie
precedenti,
l’illuminazione era
ristretta alla sola zona
dell’atterraggio.
Nell’immagine qui sopra,
invece, il campo appare
illuminato in maniera
molto maggiore. Come se,
al posto del Sole, ci
fosse un “occhio di
bue”, un faro di solito
utilizzato negli studi
fotografici. E veniamo,
ora, a quella che è
forse la più famosa
immagine del programma
“Apollo”.
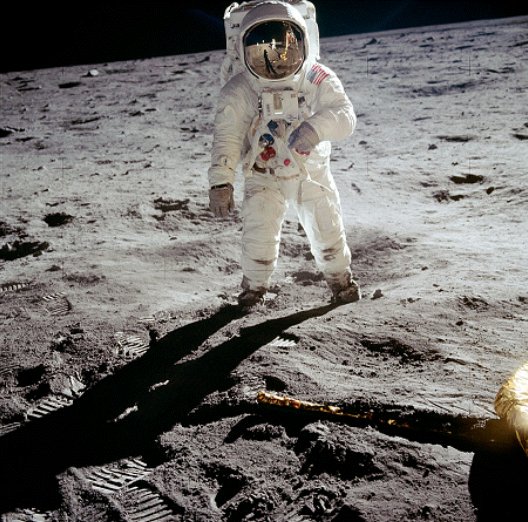
10075267
La foto è stata scattata
da Neil Armstrong e
mostra “Buzz” Aldrin in
avvicinamento verso il
LEM. A vederla così,
niente appare così
strano (tralasciati i
vari elementi fin qui
esaminati e presenti
anche in questa foto,
ovviamente). Ma proviamo
ad osservare meglio la
visiera dell’astronauta
e noteremo alcune cose
interessanti.
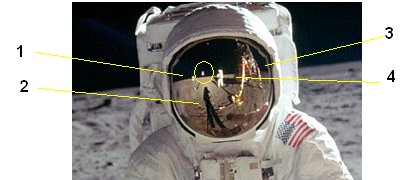
Nella visiera sono
riflessi Armstrong
(4), l’ombra
di Aldrin
(2), il LEM
(3), la
bandiera
dell’esperimento sul
vento solare
(1) e… un
misterioso oggetto. A
prima vista, questo
oggetto sembra
“fluttuare nell’aria”,
privo di appoggi sul
terreno. Alcuni
(soprattutto coloro che
credono alla
messinscena) dicono che
si tratti di un
elicottero, altri di una
struttura in
vetro-plastica alta 12
metri. La NASA, invece,
sostiene che si tratti
di una parte
dell’equipaggiamento. Di
cosa in particolare si
tratti, però, non si sa.
Un’altra osservazione va
fatta, riguardo a questa
foto. Come detto in
precedenza, sulla Luna
non c’è atmosfera a fare
da filtro alla luce,
attenuandola. Per questo
motivo, tutte le foto
dovrebbero essere
estremamente nitide,
luminose. Invece, il
paesaggio dietro Aldrin
sfuma verso il buio:
l’unica spiegazione a
questo fenomeno va forse
vista nella diversa
adattabilità della
pellicola, inferiore a
quella dell’occhio
umano. Quello che,
invece, non trova
spiegazione plausibile è
un altro “difetto” di
illuminazione. Sulla
Luna, il contrasto tra
luce ed ombra dovrebbe
essere molto netto,
visto il motivo di cui
sopra. Un esempio di
questo nell’immagine
seguente.
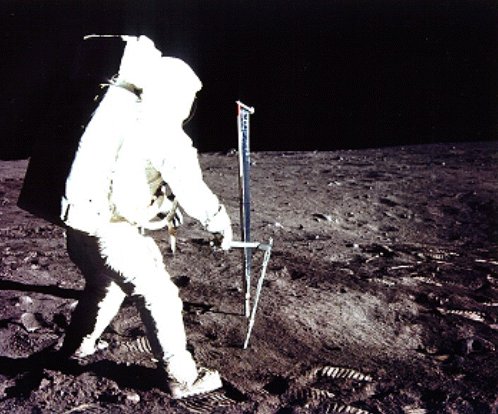
AS11-40-5964
Invece, sulla tuta di
Aldrin, per esempio, si
notano molti
particolari: con i
dovuti ingrandimenti, si
potrebbero leggere
perfino l’ora (ora della
Luna, naturalmente), in
cui è stata scattata la
fotografia…
Non è soltanto il
contributo fotografico
della missione Apollo 11
a lasciare dei dubbi
sull’autenticità delle
spedizioni spaziali.
Anche nelle successive
missioni ci sono alcuni
particolari
interessanti.
Ovviamente, analizzare
tutte le foto di tutte
le missioni sarebbe cosa
noiosa, oltre che
infinita. Dunque, ci
limiteremo a studiare
alcune immagini
“esemplari”, non più di
un paio per missione.
Missione Apollo 12.
Alan Bean viene
fotografato da Charles
Conrad
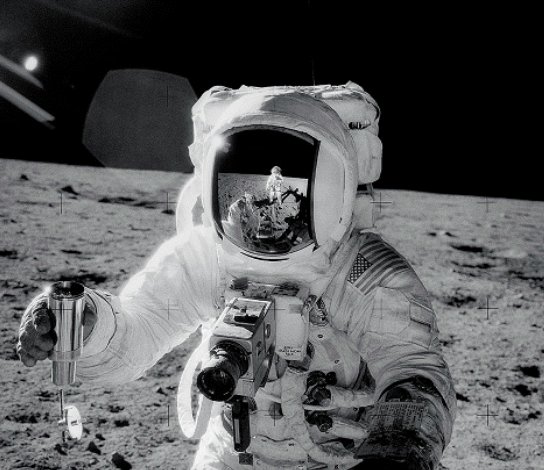
AS12-49-7278
Il casco di Bean è ben
visibile per intero:
cosa ben strana, se si
considera che Conrad
aveva la macchina
fissata al petto ed era
al livello di Bean e che
il terreno sembrava
essere piano. Inoltre,
le ombre che si possono
vedere riflesse sulla
visiera dello stesso
Bean non seguono linee
parallele, come se ci
fossero più fonti di
luce. Ancora: il
contenitore che Bean
tiene in mano sembra
risplendere nella parte
inferiore, che, però,
non è rivolta verso la
luce. La sua luminosità
potrebbe essere dovuta
alla luce riflessa
proveniente dalla tuta
dell’astronauta;
tuttavia, il resto del
contenitore, dallo
stesso lato, appare
scuro.

AS14-66-9277
Questa immagine è stata
scattate durante la
missione Apollo 14.
Oltre a non vedere, come
al solito, alcun cratere
al di sotto del LEM,
possiamo notare un’altra
cosa assai strana.
Nonostante nessuno vi
abbia ancora messo piede
(e comunque, per farlo,
sarebbe dovuto passare
al di sotto dell’ugello
del modulo come se
ballasse il limbo…),
sotto il modulo di
escursione lunare si può
notare quella che sembra
l’impronta di uno
stivale.

Missione Apollo 16.
Nonostante la parete del
LEM sia completamente in
ombra, buia, gli unici
dettagli facilmente
leggibili sono le targhe
“United States” e la
bandiera americana. Caso
strano…
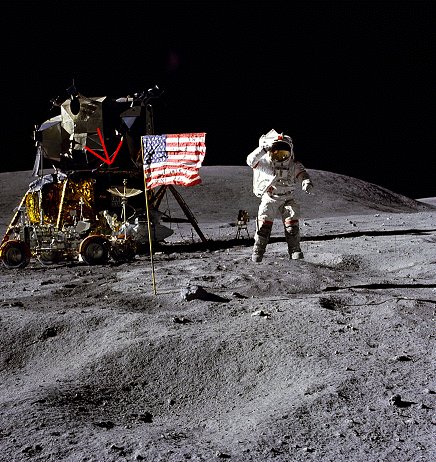
AS16-113-18339
Un’altra immagine
dell’Apollo 16. Questa
immagine offre almeno
tre spunti di
riflessione.

AS16-107-17446
Il primo riguarda
l’antenna del Lunar
Rover, la “jeep dello
spazio” fornita agli
astronauti per le loro
escursioni lunari a
partire dalla missione
Apollo 12. Osservando
con attenzione
l’antenna, notiamo che
questa sembra
sovrapporsi ad una delle
“crocette”
dell’inquadratura. Due
sono le spiegazioni a
questo: o la fotografia
è stata ritoccata oppure
si tratta di un raro ma
possibile fenomeno di
rifrazione avvenuto
all’interno della
pellicola, dovuto ad una
sovraesposizione della
stessa.

Il secondo punto
riguarda la strana curva
a 90° lasciata dalle
gomme della Rover
lunare.

A meno che gli
astronauti non si
divertissero ad
organizzare rally sulla
luna (anche se un caso
c’è stato…), sgommando
usando il freno a mano,
possiamo pensare che si
tratti di tracce
lasciate dai tecnici e
fotografi che hanno
scattato le fotografie
del finto allunaggio.
Altro particolare da
notare è l’incredibile
nitidezza delle impronte
dei copertoni,
difficilmente spiegabili
se si pensa che il suolo
lunare è estremamente
arido e polveroso. Come
si può constatare
osservando il nuvolone
di polvere alzato dalla
Rover in questa altra
immagine.
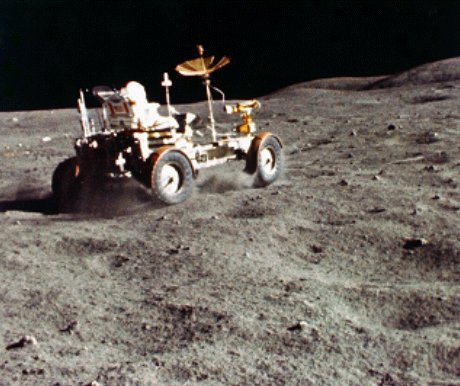
AP16-s72-37002
Il terzo ed ultimo punto
riguardante questa
immagine è quasi
clamoroso. Osservando lo
spazio compreso tra le
due linee, è possibile
notare sassi e pietrisco
terminino
improvvisamente su un
fondo piatto e sfuocato
e, cosa incredibile,
verticale,
perpendicolare al
terreno. Sembra quasi
una quinta teatrale…
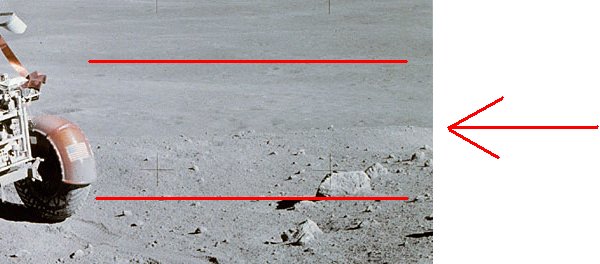
Ora, una piccola
curiosità. La seguente
immagine è stata
catturata durante la
missione Apollo 11. Si
tratta di un’immagine
molto affascinante,
soprattutto per
l’effetto ed il gioco
cromatico scaturito dal
contrasto con la luce
solare.

AS11-40-5863-69
Un’attenta analisi di
questa immagine,
condotta aumentando la
luminosità, ha mostrato
la presenza di alcuni
ritocchi e cancellature,
camuffati, ovviamente,
operati sullo sfondo.

A prima vista,
ovviamente, questo
potrebbe far pensare che
si cercasse di
nascondere qualcosa.
Tuttavia, questa
immagine è stata
realizzata “a mosaico”,
unendo, cioè, varie
fotografie di piccoli
particolari, allo scopo
di ottenere
un’inquadratura più
ampia. E’ quello che,
per esempio, è stato
fatto, di recente, con
le foto scattate dalla
sonda spedita su Marte,
allo fine di avere una
visione panoramica
dell’ambiente marziano.
Tornando alla nostra
foto, dunque, è
possibile che queste
cancellature derivino
dalla costruzione
dell’immagine nella sua
totalità. Stavolta,
quindi, nessun tentativo
di “fregarci”…
Riguardo i motivi che
spinsero gli americani a
mettere su questo
spettacolo da circo,
peraltro riuscito ad una
prima occhiata solamente
superficiale, come si è
potuto notare osservando
le foto, il discorso si
fa più complesso. Nel
maggio del 1961, il
presidente John
Fitzgerald Kennedy aveva
pronunciato, davanti al
Congresso degli Stati
Uniti, questa frase:
“Prima che questo
decennio finisca, gli
Stati Uniti devono
mandare un uomo sulla
Luna e farlo tornare a
casa sano e salvo”. Una
sfida non da poco, che
apriva ufficialmente la
corsa alla conquista
umana dello spazio. La
prima medaglia di questa
gara fu però assegnata
ai russi, i quali, nel
1961, riuscirono a
spedire il primo uomo
nello spazio (Yuri
Gagarin, a bordo del
Vostok 1). Gli USA
arrivarono leggermente
in ritardo e si
dovettero accontentare
del secondo posto,
ottenuto riuscendo a
spedire, per la prima
volta, un uomo, John
Glenn, in orbita attorno
al pianeta. A questo
piccolo trionfo
americano seguì la
tragedia dell’Apollo 1,
che, nel 1967, durante
alcune esercitazioni,
esplose con tre
astronauti a bordo. I
tempi per il primo
allunaggio sembravano
allungarsi di molto.
Almeno per gli USA,
visto che la Russia
continuava a mietere
successi: a Gagarin, nel
1963, seguì la prima
donna nello spazio,
Valentina Tereshkova;
nel 1965 Aleksey Leonov
compì la prima
passeggiata spaziale;
nel 1966 il Lunik 9 fu
il primo oggetto creato
dall’uomo a raggiungere
il suolo lunare; nel
1968 lo Zond 5 compie
un’orbita attorno alla
Luna senza equipaggio.
Ovviamente, gli Stati
Uniti non potevano
sopportare che “quei
comunisti dei Russi”
arrivassero per primi
sulla Luna. Dobbiamo
ricordare che eravamo
nel periodo della Guerra
Fredda: una sconfitta in
campo spaziale degli USA
avrebbe significato una
sconfitta anche politica
ed ideologica, cosa,
ovviamente, da evitare a
tutti i costi. Ed i
costi, in questo caso,
furono relativamente
esigui. Nel suo libro,
Kaysing riferisce che,
allo scopo di avere il
primato nella corsa allo
spazio, la DIA (Defense
Intelligence Agency, i
servizi segreti della
difesa) e la NASA
falsificarono le
immagini ed i documenti
della missione Apollo
11. Dalla base Kennedy,
dunque, il 15 luglio
1969, fecero partire un
razzo Saturn V
completamente vuoto, che
ricadde al suolo non
appena l’attenzione del
pubblico venne meno.
Mentre tutto questo
avveniva, in un’enorme
caverna nel deserto del
Nevada scienziati,
astronauti e… fotografi
preparavano le foto
della missione, i
filmati e le
registrazioni radio tra
la base ed i moduli
spaziali. Non appena
tutto fu pronto, gli
astronauti entrarono in
un finto modulo di
rientro, che fu caricato
su un aereo e sganciato,
in diretta televisiva
mondiale, sull’oceano.
Dunque, partenza,
viaggio e ritorno a
casa: tutto era stato
documentato con
immagini, anche in
diretta televisiva. Come
se questo non bastasse,
onde evitare che gli
astronauti
involontariamente si
lasciassero scappare
qualche informazione
compromettente, il
governo e la NASA li
sottoposero ad un
accurato lavaggio del
cervello. Questo
spiegherebbe anche gli
innumerevoli problemi di
salute e disturbi
mentali cui tutti gli
astronauti sono andati
incontro al loro ritorno
sulla terra, problemi
che tutti i medici della
NASA hanno spiegato
tirando il ballo la
famosa “sindrome dello
spazio”. I motivi di
questa messa in scena,
abbiamo detto, sono
soprattutto di natura
politica, ideologica,
propagandistica. Ma
possiamo anche supporre
(ed è quello che fa
Kaysing) che tutta la
“favola” sia stata
costruita dalla NASA per
ottenere maggiori fondi
da parte del governo per
attuare serie ricerche e
reali programmi
spaziali. I fondi per la
NASA, infatti,
soprattutto dopo la
tragedia dell’Apollo 1,
erano stati notevolmente
ridotti. Anche perché
gli americani si stavano
impegnando con sempre
maggior foga, sia dal
punto di vista umano sia
dal punto di vista
economico, nella inutile
guerra in Vietnam. Ora,
ovviamente, dal punto di
vista della propaganda
politica, per il governo
americano sarebbe stata
più redditizia una
vittoria sulla terra
contro il “nemico rosso”
in carne ed ossa che a
distanza (siderale, in
questo caso), nello
spazio. Insomma, per
concludere, l’ipotesi di
Kaysing rimane
affascinante e non priva
di indizi reali e
plausibili. E’
difficile, almeno per un
momento, non crederci: è
difficile credere, come
afferma, che gli
astronauti siano giunti
sulla Luna con dei
computer che avevano
meno memoria di una
lavatrice…
BIBLIOGRAFIA
·
Bill Kaysing, Non
siamo mai andati sulla
Luna, Cult Media Net
Edizioni, Roma, 1997
ARCHIVIO FOTOGRAFICO
·
www.apolloarchive.com/apollo_gallery.html
·
http://history.nasa.gov/alsj
·
www.nasa.gov
·
http://www.nexusitalia.com
- Immagine
AS11-40-5863-69 |