|

Giugno 1952. Messico,
sito archeologico della
città di Palenque. Dopo
tre anni di lungo
lavoro, tre anni di
tenace lavoro per
liberare quell’imponente
edificio dal soffocante
abbraccio della
vegetazione, finalmente
l’uomo poteva entrare
nelle antiche stanze di
quella poderosa
costruzione ed
esplorarle. Faceva
caldo, molto caldo,
l’aria era umida e lo
faceva sudare
copiosamente, inzuppando
e facendo aderire gli
abiti al corpo. Come se
non bastasse il quadro
climatico equatoriale,
anche l’eccitazione per
la scoperta aveva il suo
peso nello scombussolare
il suo bioritmo e la sua
situazione emotiva.
L’uomo osserva gli
spessi muri della
costruzione, ne osserva
le decorazioni e prova
ad immaginare quante e
quali mani abbiano
realizzato quelle opere
incredibili.
Quell’edificio,
anticamente luogo di
culto dedicato al re
Pacal, era conosciuto
come “tempio delle
iscrizioni”, poiché al
suo interno si potevano
ammirare ben 617 glifi,
l’antica forma di
scrittura del popolo dei
Maya. Il suo sguardo si
posa poi sul pavimento,
un pavimento che, pensa,
era stato calpestato per
l’ultima volta centinaia
di anni fa da uomini che
erano diventati ormai
polvere. La sua
attenzione viene
attirata da un
particolare: le pareti
del tempio sembravano
non congiungersi al
pavimento, ma andare
oltre; in un punto del
pavimento stesso, poi,
l’uomo osservò strani
fori praticati sulla
superficie di una lastra
e coperti con una doppia
fila di tasselli in
pietra. Si avvicinò per
esaminarli e notò che si
potevano asportare e che
si potevano infilare le
dita nei fori. Decise
allora di chiamare i
suoi uomini e di far
sollevare la lastra,
nella speranza che al di
sotto potesse esserci
qualcosa. Sollevata la
pesante pietra, ecco
apparire ai suoi occhi
un oscuro cunicolo
invaso dai detriti.
Nell’uomo l’eccitazione
andò aumentando e non
senza emozione ordinò ai
suoi uomini di ripulire
la scalinata che,
attraverso il cunicolo,
si snodava obliquamente
nelle profondità della
terra. Terminate le
operazioni di
ripulitura, l’uomo
decise di inoltrarsi nel
cunicolo. Alla fine
discesa, lunga 45
scalini, l’uomo si
ritrovò in un
pianerottolo
rettangolare sul quale
si aprivano due pozzi,
destinati un tempo, con
tutta probabilità,
all’entrata sia della
luce che dell’aria.
L’uomo ed i suoi
compagni osservarono
notarono poi un’altra
scalinata, che si
snodava sempre più in
profondità nella terra.
Percorsa anche
quell’altra rampa, ad
ormai trenta metri di
profondità l’uomo si
trovò davanti un
corridoio orizzontale
sbarrato da un muro;
rimosso anche questo
ostacolo, apparvero,
sparsi a terra un po’
dovunque, vasi, oggetti
di giada ed anche una
perla. La presenza di
questi reperti assumeva
importanza determinante
nella circostanza,
soprattutto perché
ricordavano i doni
sacrificali posti
davanti o comunque in
prossimità delle celle
funerarie egizie. Oltre
questi oggetti, furono
rinvenute le ossa di sei
individui, cinque uomini
e una donna,
probabilmente sei
giovani nobili
sacrificati o
sacrificatisi a custodia
di qualcosa di molto
importante. Percorrendo
ancora il corridoio,
l’uomo giunse infine
davanti ad una porta
sbarrata. Con un nodo
alla gola, l’uomo aprì
anche quella porta: ciò
che vide oltre fu una
stanza triangolare di 10
metri per 4 ed altra 7
metri, le cui pareti
erano completamente
ricoperte di geroglifici
e bassorilievi
rappresentanti i “nove
signori della notte”, i
guardiani dei nove regni
degli inferi della
mitologia maya. Al
centro della stanza,
come mai avrebbe
immaginato, un sarcofago
di pietra. Solo questo
fatto rappresentava una
scoperta incredibile,
visto che mai era stata
rinvenuta una tomba maya
con una sepoltura: i
templi avevano sempre
avuto funzione di luogo
di culto, mai di luogo
di sepoltura. L’uomo si
avvicinò ad esso e ne
toccò la superficie.
Chiuse gli occhi e cercò
di immaginare scavatori
e decoratori che si
affaccendavano nella
realizzazione di
quell’immane sepolcro.
Poi aprì gli occhi ed
osservò il coperchio del
sarcofago: i disegni su
di esso erano
assolutamente unici ed
altrettanto misteriosi.
Desideroso di andare
avanti nell’esplorazione
di quella stanza
(dopotutto era il suo
lavoro), l’uomo ordinò
che il coperchio della
tomba fosse sollevato.
Alla luce delle torce
apparvero i resti di un
uomo con il volto
coperto da una splendida
maschera verde fatta di
pezzetti di giada uniti
a mosaico: gli occhi
erano di conchiglia e le
iridi di ossidiana.
Tutto intorno erano
sparpagliate un’infinità
di oggetti preziosi.
Con un po’ di fantasia è
probabilmente questa la
scena cui avremmo
assistito anche noi se,
nel giugno del 1952,
avessimo fatto parte
della spedizione
scientifica condotta
dall’uomo protagonista
del nostro breve
racconto. L’uomo in
questione era un
archeologo messicano di
nome Alberto Ruz
Lhuillier. Il personaggi
sepolto nella tomba era
il re maya Pacal. La
lastra a copertura del
suo sepolcro è oggi nota
come Lastra di Palenque.
Oltre ad essere un
oggetto archeologico
estremamente importante,
essa rappresenta anche
uno dei più misteriosi
ed eccitanti quesiti
della storia.
Prima di entrare nello
specifico ed analizzare
compiutamente la Lastra
di Palenque, è opportuno
delineare un breve
tratto
storio-social-politico
della civiltà maya e del
luogo dove la Lastra fu
ritrovata, cioè la città
di Palenque.
La civiltà Maya fiorisce
all’incirca tra il 100
ed il 900 d.C. La loro
zona è molto vasta e
copre i territori
dell’odierno Messico
meridionale, il
Guatemala, l’Honduras,
il Belize ed il
Salvador. Inizialmente,
la loro civiltà è
organizzata in centri
abitati non più ampi di
piccoli villaggi; in
seguito, però, forse per
sfuggire all’influenza
del popolo di
Teotihuacan, si
concentrano sempre più a
sud. Tra il 200 ed il
300 inizia quello che
gli studiosi chiamo
“periodo classico”,
caratterizzato dalla
nascita di un grande
numero di città e da una
eccezionale fioritura di
architettura, scultura,
pittura, da un primato
delle conoscenze
scientifiche. I Maya
praticano una scrittura
a geroglifici e
pittogrammi. Gran parte
dei loro scritti sono
stati bruciati dagli
spagnoli conquistatori
perché “opera del
demonio”; soltanto tre
testi si sono salvati e
si trovano oggi nelle
biblioteche di Dresda,
Parigi e Madrid.
Fortunatamente,
moltissime iscrizioni su
pietra si sono
conservate.
I Maya si basano su un
calendario molto
preciso, con due diverse
misurazioni del tempo:
una rituale di 260
giorni; l’altra solare,
di 365 giorni divisi in
18 mesi di 20 giorni
ciascuno più un periodo
aggiuntivo di 5 giorni.
Altrettanto precise sono
le loro conoscenze in
campo astronomico (sanno
calcolare con esattezza
le eclissi di sole e
l’anno di Venere).
Queste conoscenze sono
rese possibili da una
profonda sapienza
metamerica, soprattutto
eccezionale per
l’invenzione dello zero,
sconosciuto ai Fenici ed
ai Romani, introdotto in
Italia dall’India agli
inizi del 200. Tutte le
conoscenze sono
applicate ai campi
astrologico-religiosi.
Tutto fa pensare che sia
esistito davvero un
abisso culturale tra la
classe sacerdotale e la
classe dei contadini,
costretti a lavorare nei
campi con metodi
primitivi. Non sappiamo
dove siano avvenuti i
processi di formazione
di queste conoscenze,
così come non sappiamo
nulla circa la storia
dell’insediamento maya:
in quei luoghi non
esiste nessuna
condizione di base
(niente terreno fertile,
niente fiumi da
utilizzare come mezzi di
comunicazione, niente
terreni pianeggianti,
clima insopportabile)
che permetta lo sviluppo
di una civiltà.
Lo stato maya non
esiste. Esistono molte
città stato,
indipendenti le une
dalle altre. Al vertice
della gerarchia sociale
stanno i sacerdoti ed un
monarca, da cui
dipendono i capi dei
villaggi; la società è
composta da popolo
minuto, contadini e
schiavi. Il lavoro del
contadino maya è
faticoso, assorbito in
gran parte a disboscare
la foresta tropicale con
rudimentali arnesi in
pietra; si allevano
cani, tacchini, api;
gran parte del tempo è
dedicato alla
costruzione dei templi,
giganteschi, fatti con
materiali che spesso non
si trovano nel luogo, ma
vengono tagliati e
spostati (come non si
sa).
La famiglia maya è
monogamica; l’economia
si fonda sulla caccia,
sulla pesca, sulla
coltivazione del mais.
L’abbigliamento consiste
in brache lunghe sino al
ginocchio e decorate per
gli uomini, di una gonna
di cotone e una blusa,
entrambe ricamate, per
le donne; le classi
superiori usano spesso
ornarsi di giada e di
piume. L’idea di
bellezza è diversa
rispetto a quella degli
europei: ai neonati
delle famiglie nobili
viene serrato il cranio
tra due assi, per
produrre una
deformazione ed un
allungamento, segni di
bellezza; lo strabismo è
considerato una dote, sì
che, per provocarlo, si
appendono palle di legno
agli occhi dei neonati;
orecchie, labbra, naso
vengono perforati per
inserirvi degli
ornamenti; i giovani
amano dipingersi di
nero, gli adulti di
rosso.
I Maya si distinguono o
si dispersero per motivi
sconosciuti: forse per
una catastrofe naturale
(ma è un’ipotesi poco
probabile, visto che gli
edifici sono integri ed
intatti), forse per una
rivolta contadina, forse
per un’invasione
straniera, forse per un
aumento eccessivo della
popolazione, forse per
una circostanze di cause
che provocò
l’inaridimento del
territorio e
l’impossibilità di
sfruttare l’agricoltura
come unico mezzo di
sostentamento.
Vediamo ora di
presentare la città di
Palenque.

La città si trova nelle
tierras calientes,
dove si incontrano la
piana del Campeche e gli
altipiani del Chiapas,
quasi al centro della
penisola dello Yucatan,
al confine tra Messico e
Guatemala. Si dice che
Palenque sia stata la
più grande città
dell’emisfero
occidentale; poi, circa
11 secoli fa, senza un
apparente motivo, la
popolazione la abbandonò
e la lasciò alla
giungla.
Quando nel 1519 Cortés
sbarcò in Messico,
Palenque era già una
città fantasma sommersa
dalla giungla. Il nome
originario della città
era Na Chan Caan, cioè
“la casa del serpente
piumato” o “gran città
dei serpenti”; tuttavia,
poiché si trovava vicino
all’insediamento
spagnolo di Santo
Domingo di Palenque, che
era stato circondato da
uno steccato in legno
per evitare gli attacchi
da parte degli indios,
l’antico centro maya fu
ribattezzato proprio
Palenque, cioè
“steccato”.
Le rovine sono
riscoperte una prima
volta dal vescovo Numes
de la Vega nel 1691.
Tuttavia, bisognerà
aspettare la fine del
XVIII secolo perché uno
spagnolo, Antonio del
Rio, ne ritrovi le rovine. Nel
suo rapporto del Rio
scriveva che gli edifici
avevano una architettura
del tutto simile a
quella romana, egizia e
di altri popoli. La
pubblicazione di questo
rapporto fu ad opera di
Paul Felix Cabrera che
giunse alla conclusione
che i Cartaginesi, prima
delle guerre puniche
(264 a.C.), erano giunti
in Messico ed avevano
dato origine al popolo
degli Olmechi. Le sue
ricerche, però, non
avranno seguito, e
Palenque sarà nuovamente
dimenticata. Nel 1830 ci
fu una riscoperta della
città da parte di un
soldato di ventura, Jean
Frédéric Waldeck, che
rimase nella zona per
più di tre anni,
realizzando diversi
schizzi dei ruderi.
Rimasta per secoli
nascosta dalla
vegetazione, la città fu
riscoperta nuovamente
nell’aprile del 1840
dall’avvocato americano
John Stephens e dal
disegnatore inglese
Frederick Catherwood, i
quali erano in marcia
nella terribile giungla
dello Yucatan, a circa
500 chilometri di
distanza dall’antica
città di Copan, un altro
importante insediamento
del popolo Maya. Essendo
stati preceduti nel
secolo precedente
soltanto da spedizioni
militari spagnole, e due
non avevano con loro né
dati né carte
sufficienti per
localizzare con
precisione Palenque. Fu
quasi un caso, quindi,
il comparire improvviso
fra la fitta vegetazione
del primo lastricato
stradale che li avrebbe
condotti fino all’antica
città.
ritrovi le rovine. Nel
suo rapporto del Rio
scriveva che gli edifici
avevano una architettura
del tutto simile a
quella romana, egizia e
di altri popoli. La
pubblicazione di questo
rapporto fu ad opera di
Paul Felix Cabrera che
giunse alla conclusione
che i Cartaginesi, prima
delle guerre puniche
(264 a.C.), erano giunti
in Messico ed avevano
dato origine al popolo
degli Olmechi. Le sue
ricerche, però, non
avranno seguito, e
Palenque sarà nuovamente
dimenticata. Nel 1830 ci
fu una riscoperta della
città da parte di un
soldato di ventura, Jean
Frédéric Waldeck, che
rimase nella zona per
più di tre anni,
realizzando diversi
schizzi dei ruderi.
Rimasta per secoli
nascosta dalla
vegetazione, la città fu
riscoperta nuovamente
nell’aprile del 1840
dall’avvocato americano
John Stephens e dal
disegnatore inglese
Frederick Catherwood, i
quali erano in marcia
nella terribile giungla
dello Yucatan, a circa
500 chilometri di
distanza dall’antica
città di Copan, un altro
importante insediamento
del popolo Maya. Essendo
stati preceduti nel
secolo precedente
soltanto da spedizioni
militari spagnole, e due
non avevano con loro né
dati né carte
sufficienti per
localizzare con
precisione Palenque. Fu
quasi un caso, quindi,
il comparire improvviso
fra la fitta vegetazione
del primo lastricato
stradale che li avrebbe
condotti fino all’antica
città.
Gli scavi archeologici
iniziarono soltanto nel
1930, diretti
dall’archeologo M. A.
Fernandez in
collaborazione con F.
Blom e Ruz Lhuillier. Fu
nel corso di questi
lavori che vennero
riportati alla luce
numerosi templi;
soprattutto è da
ricordare la scoperta
del Tempio delle
Iscrizioni che in futuro
avrebbe rivelato una
scoperta sensazionale.
Palenque, insieme ai
centri cerimoniali di
Copan, Tikal e Calakmul,
fu considerata dagli
antichi Maya come uno
dei quattro angoli
dell’universo. Secondo
la tradizione, il
fondatore della città fu
Makin Pacal, nome che
significa “Grande Scudo
Sole”. Secondo gli
antichi documenti, il
sovrano Pacal era nato
il 26 marzo 603 da Chan
Bahlum Mo, suo padre, e
dalla nobile Zac Kuk,
membro di una delle
famiglie locali
dominanti. Salì al trono
nel 615, all’età di 12
anni, e regnò per oltre
68 anni prima di morire
il 31 agosto 683. Il 22
marzo 626 sposò
 Tz’ak
Ahwal, da cui ebbe due
figli, Chan Bahlum,
designato come erede, e
Chan Hoch Chitam.
Durante il suo regno
dovette affrontare due
diversi attacchi
sferrati dal signore
della città di Calakmul,
più altre guerre dalle
quali Pacal uscì
vittorioso,
stabilizzando così il
suo regno e garantendo
il diritto alla
successione sul trono di
suo figlio. Questi gli
succedette all’età di 50
anni e morì, nel 702,
dopo aver regnato per 18
anni. Il regno di questi
due sovrani, costruttori
di quasi tutti gli
edifici più importanti
della città, coprì in
pratica tutto il settimo
secolo. Sempre secondo i
testi, la costruzione
del tempio cominciò nel
675 e fu completata nel
692 da Chan Bahlum nove
anni dopo sua la
morte. Sebbene il sito
fosse già occupato nel I
sec. a.C., la città
conosce il suo massimo
splendore nel VII sec.
d.C., quando il regno è
guidato dal sovrano Kin
Pacal e poi da suo
figlio Chan Bahlum. Il
centro è un magnifico
esempio di architettura
maya di epoca classica,
paragonabile solo a
Tikal in Guatemala e a
Copán in Honduras.
Quello che oggi vediamo
di Palenque non è che
una minima parte di una
città che si estendeva
per ben 15 chilometri
quadrati. Gli edifici
più importanti, come il
Gruppo della Croce, il
Tempio delle Iscrizioni
e il Palazzo, sono tutti
databili ad un periodo
che va dall’inizio del
VII secolo alla metà
dell’VIII secolo, quando
Palenque e i suoi
sovrani dominavano un
vasto territorio.
Palenque presenta uno
stile architettonico di
particolare bellezza:
doveva apparire
grandiosa al tempo del
suo massimo splendore,
con le piramidi dipinte
di rosso avvolte dal
verde cupo della
vegetazione. L’utilizzo
dello stucco, che
ricopre interamente gli
edifici, ha permesso
agli artisti locali di
creare decorazioni di
elevato livello
estetico. Palenque è la
vera “capitale” dello
stucco, la città in cui
questo materiale si è
meglio conservato grazie
all’umidità della
foresta tropicale, e che
presenta più di ogni
altra il gusto
decorativo che dominava
l’architettura maya. Dal
punto di vista
architettonico Palenque
presenta caratteri
unici, come i tetti
inclinati a mansarda,
che avevano forse la
funzione di proteggere i
delicati rilievi a
stucco collocati sui
muri esterni. Edifici
singolari come la torre
del Palacio o il Tempio
delle Iscrizioni con la
sua tomba nascosta,
sanciscono l’originalità
della cultura artistica
di Palenque. Snelle
cresterías, alte
merlature traforate,
elevano e alleggeriscono
gli edifici. Le
cresterías hanno una
esplicita funzione
estetica, slanciando i
tozzi edifici che
assumono una leggerezza
formale superiore a
quella concessa dalle
spesse strutture
murarie. Tz’ak
Ahwal, da cui ebbe due
figli, Chan Bahlum,
designato come erede, e
Chan Hoch Chitam.
Durante il suo regno
dovette affrontare due
diversi attacchi
sferrati dal signore
della città di Calakmul,
più altre guerre dalle
quali Pacal uscì
vittorioso,
stabilizzando così il
suo regno e garantendo
il diritto alla
successione sul trono di
suo figlio. Questi gli
succedette all’età di 50
anni e morì, nel 702,
dopo aver regnato per 18
anni. Il regno di questi
due sovrani, costruttori
di quasi tutti gli
edifici più importanti
della città, coprì in
pratica tutto il settimo
secolo. Sempre secondo i
testi, la costruzione
del tempio cominciò nel
675 e fu completata nel
692 da Chan Bahlum nove
anni dopo sua la
morte. Sebbene il sito
fosse già occupato nel I
sec. a.C., la città
conosce il suo massimo
splendore nel VII sec.
d.C., quando il regno è
guidato dal sovrano Kin
Pacal e poi da suo
figlio Chan Bahlum. Il
centro è un magnifico
esempio di architettura
maya di epoca classica,
paragonabile solo a
Tikal in Guatemala e a
Copán in Honduras.
Quello che oggi vediamo
di Palenque non è che
una minima parte di una
città che si estendeva
per ben 15 chilometri
quadrati. Gli edifici
più importanti, come il
Gruppo della Croce, il
Tempio delle Iscrizioni
e il Palazzo, sono tutti
databili ad un periodo
che va dall’inizio del
VII secolo alla metà
dell’VIII secolo, quando
Palenque e i suoi
sovrani dominavano un
vasto territorio.
Palenque presenta uno
stile architettonico di
particolare bellezza:
doveva apparire
grandiosa al tempo del
suo massimo splendore,
con le piramidi dipinte
di rosso avvolte dal
verde cupo della
vegetazione. L’utilizzo
dello stucco, che
ricopre interamente gli
edifici, ha permesso
agli artisti locali di
creare decorazioni di
elevato livello
estetico. Palenque è la
vera “capitale” dello
stucco, la città in cui
questo materiale si è
meglio conservato grazie
all’umidità della
foresta tropicale, e che
presenta più di ogni
altra il gusto
decorativo che dominava
l’architettura maya. Dal
punto di vista
architettonico Palenque
presenta caratteri
unici, come i tetti
inclinati a mansarda,
che avevano forse la
funzione di proteggere i
delicati rilievi a
stucco collocati sui
muri esterni. Edifici
singolari come la torre
del Palacio o il Tempio
delle Iscrizioni con la
sua tomba nascosta,
sanciscono l’originalità
della cultura artistica
di Palenque. Snelle
cresterías, alte
merlature traforate,
elevano e alleggeriscono
gli edifici. Le
cresterías hanno una
esplicita funzione
estetica, slanciando i
tozzi edifici che
assumono una leggerezza
formale superiore a
quella concessa dalle
spesse strutture
murarie.
Numerosi templi hanno
struttura simile: sono
elevati su piccole
piramidi, sovrastati da
merlature, ricoperti da
rilievi in stucco, sia
sulle pareti sia sul
tetto. Internamente gli
spessi muri lasciano
liberi soltanto spazi
angusti, un portico
lungo tutta la parete
d’ingresso e sul retro
un santuario con due
stanze laterali. In tali
templi, di piccole
dimensioni, i santuari
ospitano i simboli del
dio cui sono dedicati:
lastre di pietra
decorate in modo
superbo, veri capolavori
dell’arte precolombiana. Al centro della città,
su una piattaforma alta
10 metri, venne eretto
il cosiddetto Palacio.
In realtà si tratta di
più edifici che si
addossano l’uno
all’altro e che furono
costruiti in un arco di
120 anni. La struttura
più antica, attorno alla
quale si sono sviluppate
le successive, sarebbe
databile al 600 d.C.
circa, anni in cui
Palenque era governata
dalla regina Zak Kuk,
madre di Pacal. Tutti
gli edifici si aprono su
delle corti interne e
sono decorati con scene
di incoronazione o di
imprese dei sovrani e
ciò fa pensare che
l’intero complesso fosse
usato come residenza per
la classe dirigente o
comunque come centro
amministrativo del
potere. Come in quasi
tutte le città maya, le
costruzioni di Palenque
erano coperte da uno
strato di stucco rosso,
su cui spiccavano i
rilievi dipinti in
colori sgargianti, come
giallo, verde e blu. I
bassorilievi e gli
stucchi del Palazzo sono
di incredibile finezza
stilistica e i
personaggi sono ritratti
realisticamente, come
nella scena in cui Pacal
riceve le insegne reali
dalla regina-madre. Come
simbolo del potere e
della forza di Palenque
appaiono numerose
rappresentazioni di
schiavi, talvolta anche
di alto rango a
giudicare dalle vesti
sfarzose.
Al centro della città,
su una piattaforma alta
10 metri, venne eretto
il cosiddetto Palacio.
In realtà si tratta di
più edifici che si
addossano l’uno
all’altro e che furono
costruiti in un arco di
120 anni. La struttura
più antica, attorno alla
quale si sono sviluppate
le successive, sarebbe
databile al 600 d.C.
circa, anni in cui
Palenque era governata
dalla regina Zak Kuk,
madre di Pacal. Tutti
gli edifici si aprono su
delle corti interne e
sono decorati con scene
di incoronazione o di
imprese dei sovrani e
ciò fa pensare che
l’intero complesso fosse
usato come residenza per
la classe dirigente o
comunque come centro
amministrativo del
potere. Come in quasi
tutte le città maya, le
costruzioni di Palenque
erano coperte da uno
strato di stucco rosso,
su cui spiccavano i
rilievi dipinti in
colori sgargianti, come
giallo, verde e blu. I
bassorilievi e gli
stucchi del Palazzo sono
di incredibile finezza
stilistica e i
personaggi sono ritratti
realisticamente, come
nella scena in cui Pacal
riceve le insegne reali
dalla regina-madre. Come
simbolo del potere e
della forza di Palenque
appaiono numerose
rappresentazioni di
schiavi, talvolta anche
di alto rango a
giudicare dalle vesti
sfarzose.
Davanti al Palacio,
sulla riva opposta del
fiume che attraversava
la città, sorge un
gruppo omogeneo di tre
templi: il Tempio della
Croce, quello della
Croce Fogliata e il
Tempio del Sole. Questo
gruppo fu fatto erigere
dal re Chan Bahlum (o
Chan Balám - Serpente
Giaguaro), figlio del
potente sovrano Pacal,
per celebrare la sua
ascesa al trono nel 683
d.C.
La struttura è simile
per tutti e tre i
templi: su una
piattaforma artificiale
o naturale si eleva un
edificio a pianta
rettangolare sul cui
tetto si alza una
cresta, in origine
ornata con figure di
stucco. Coperti da
decorazioni erano anche
gli spioventi del tetto
e i pilastri che
scandiscono la facciata.
L’interno è diviso in
tre stanze e quella
centrale custodisce un
piccolo santuario con
pannelli a rilievo.
Il Tempio della Croce,
il primo probabilmente
ad essere stato
costruito, venne
chiamato così perché il
grande pannello interno
mostra un Albero della
Vita (la
ceiba che
affonda le radici nell’Inframondo,
attraversa il mondo
degli uomini con il suo
tronco e arriva al Cielo
con i suoi rami) che
agli occhi dei primi
scopritori apparve come
un Croce. Ai lati
dell’Albero si vede il
re Pacal che trasmette
al figlio i simboli del
potere.

Nel rilievo del Tempio
della Croce Fogliata
l’Albero della Vita è
ornato da pannocchie di
mais, un simbolo di
fertilità rafforzato
dall’immagine di Chan
Bahlum che si appresta a
compiere un
autosacrificio.
Il Tempio del Sole
mostra invece dei
giaguari e si pensa
quindi che fosse
dedicato ai sacrifici e
alla guerra.

Ai tre Templi erano
associate altrettante
divinità di cui non si
conoscono i nomi e
perciò chiamate “Triade
di Palenque”. Citati
anche nel libro sacro
Popol Vuh,
sono dei che
rappresentano i diversi
aspetti del Sole e che
venivano considerati dai
Maya i progenitori delle
stirpi reali. Anche a
Palenque una vasta area
è destinata al Gioco
della Palla (nell’area
Maya si sono scoperti
circa quaranta campi di
gioco). Erano
costruzioni rettangolari
a forma di doppio T
circondate da mura: un
anello di pietra conficc ato
perpendicolarmente su
una parete fungeva da
porta attraverso la
quale doveva passare il
pallone. Venivano
chiamati “campi di gioco
degli dei”, perché il
gioco era una vera e
propria cerimonia
religiosa. Il pallone
era formato da una
grossa palla di caucciù,
massiccia ma anche molto
elastica del peso di tre
chilogrammi, la quale
non poteva essere
colpita, come ricorda il
Codice Mendoza,
“se non con la giuntura
della coscia, o del
braccio, o del gomito;
chiunque la toccava con
la mano o col piede o
con qualunque altra
parte del corpo perdeva
un punto. Chiunque
faceva passare il
pallone per il buco, ciò
che di rado accadeva,
vinceva la partita”. Il
senso profondo del gioco
sta appunto nel suo
valore sacrale:
rimettere in moto il
Sole, rinnovando
ritualmente il gesto
dell’Essere supremo che
crea il cosmo, mettendo
in moto tempo e spazio.
Gli anelli di pietra
recavano frequentemente
l’immagine del Sole o
simboli celesti sui due
lati. Già nell’VIII
secolo la città subisce
una sempre più forte
influenza da parte di
Toniná, un sito maya
distante un’ottantina di
chilometri, ma la
definitiva decadenza e
il successivo abbandono
avvengono soltanto nel X
secolo, probabilmente a
causa dell’arrivo di
nuove popolazioni
provenienti dal Golfo
del Messico. Gran parte
della sua storia
Palenque la porta
scritta su i suoi
monumenti sotto forma di
rilievi o di glifi e
l’universo maya si
esprime attraverso le
sue architetture: il
mondo dei mortali è
rappresentato dal
Palacio e il mondo degli
dei dai Templi del
Gruppo della Croce,
mentre il Tempio delle
Iscrizioni è il luogo
dove l’uomo si fa dio. ato
perpendicolarmente su
una parete fungeva da
porta attraverso la
quale doveva passare il
pallone. Venivano
chiamati “campi di gioco
degli dei”, perché il
gioco era una vera e
propria cerimonia
religiosa. Il pallone
era formato da una
grossa palla di caucciù,
massiccia ma anche molto
elastica del peso di tre
chilogrammi, la quale
non poteva essere
colpita, come ricorda il
Codice Mendoza,
“se non con la giuntura
della coscia, o del
braccio, o del gomito;
chiunque la toccava con
la mano o col piede o
con qualunque altra
parte del corpo perdeva
un punto. Chiunque
faceva passare il
pallone per il buco, ciò
che di rado accadeva,
vinceva la partita”. Il
senso profondo del gioco
sta appunto nel suo
valore sacrale:
rimettere in moto il
Sole, rinnovando
ritualmente il gesto
dell’Essere supremo che
crea il cosmo, mettendo
in moto tempo e spazio.
Gli anelli di pietra
recavano frequentemente
l’immagine del Sole o
simboli celesti sui due
lati. Già nell’VIII
secolo la città subisce
una sempre più forte
influenza da parte di
Toniná, un sito maya
distante un’ottantina di
chilometri, ma la
definitiva decadenza e
il successivo abbandono
avvengono soltanto nel X
secolo, probabilmente a
causa dell’arrivo di
nuove popolazioni
provenienti dal Golfo
del Messico. Gran parte
della sua storia
Palenque la porta
scritta su i suoi
monumenti sotto forma di
rilievi o di glifi e
l’universo maya si
esprime attraverso le
sue architetture: il
mondo dei mortali è
rappresentato dal
Palacio e il mondo degli
dei dai Templi del
Gruppo della Croce,
mentre il Tempio delle
Iscrizioni è il luogo
dove l’uomo si fa dio.
Nonostante l’estrema
bellezza ed il grande
fascino del luogo,
occorrerà concentrare la
nostra attenzione sul
Tempio delle Iscrizioni,
il luogo all’interno del
quale fu rinvenuta la
Lastra. Il Tempio delle
Iscrizioni (databile
attorno al 690 d.C.) non
è soltanto un luogo
sacro, ma la
testimonianza in pietra
della dinastia più
potente di Palenque. I
pilastri della facciata
sono decorati con
stucchi che mostrano il
re Pacal insieme al Dio
Kukulkan, una divinità
legata alla classe
regnante. In origine i
rilievi erano dipinti e
i colori non venivano
scelti a caso, ma
avevano un significato
ben preciso: il rosso
serviva per dipingere il
corpo umano e le parti
umane delle figure
antropomorfe ed era
quindi il colore del
mondo degli uomini; il
giallo veniva usato per
le immagini dei
giaguari, delle piante
acquatiche e dei
serpenti, tutti simboli
dell’Inframondo; il blu
era invece il colore del
Cielo e in questa
tonalità erano
rappresentati gli dei e
gli attributi divini del
re.
Sulle pareti interne del
Tempio sono scolpiti più
di 600 glifi che
illustrano quasi 150
anni di storia della
città. Grazie a queste
immagini l’epigrafista
tedesco Heinrich Berlin
riuscì nel 1958 a
individuare i cosiddetti
“glifi emblematici”
(glifi che indicano nomi
di sovrani o di città
come i cartigli degli
antichi egizi) che
fecero fare un grande
passo avanti per la
decifrazione della
scrittura maya.
Entriamo nel tempio e
percorriamo le scale ed
i corridoi che, più di
50 anni fa, Alberto Ruz
Lhuillier percorse prima
di noi. Alla fine della
discesa troveremo la
camera sepolcrale di re
Pacal.


 Una
prima curiosità ci si
para davanti non già sul
sepolcro o sul suo
coperchio, ma su una
stele presente nella
stanza. Abbiamo d Una
prima curiosità ci si
para davanti non già sul
sepolcro o sul suo
coperchio, ma su una
stele presente nella
stanza. Abbiamo d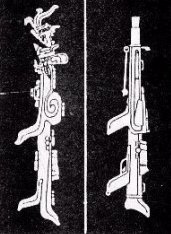 etto
all’inizio che sulle
pareti della stanza del
sarcofago appaiono
raffigurati i “nove
signori della notte”, i
guardiani dei nove regni
degli inferi della
mitologia maya. Vicino
ad uno di questi, in
piedi, appare un uomo: i
suoi tratti somatici
sono assai simili a
quelli dell’uomo
raffigurato sulla
Lastra; i suoi abiti
sono estremamente
lussuosi ed eleganti
(almeno per i canoni
dell’epoca e per la
cultura). Nella mano
destra dell’uomo della
stele uno strano oggetto
non meglio identificato.
A suffragare e
rafforzare questa
ipotesi, l’idea che
quelle che vediamo
all’estremità superiore
siano fiamme, provocate,
possiamo pensare, dalla
detonazione del colpo o
dalla fiamma del
lanciafiamme. Insomma, è
possibile che l’uomo
raffigurato nella stele
trovata nella camera
sepolcrale di re Pacal
sia un antico guerriero
maya armato con un
moderno fucile o
lanciafiamme. etto
all’inizio che sulle
pareti della stanza del
sarcofago appaiono
raffigurati i “nove
signori della notte”, i
guardiani dei nove regni
degli inferi della
mitologia maya. Vicino
ad uno di questi, in
piedi, appare un uomo: i
suoi tratti somatici
sono assai simili a
quelli dell’uomo
raffigurato sulla
Lastra; i suoi abiti
sono estremamente
lussuosi ed eleganti
(almeno per i canoni
dell’epoca e per la
cultura). Nella mano
destra dell’uomo della
stele uno strano oggetto
non meglio identificato.
A suffragare e
rafforzare questa
ipotesi, l’idea che
quelle che vediamo
all’estremità superiore
siano fiamme, provocate,
possiamo pensare, dalla
detonazione del colpo o
dalla fiamma del
lanciafiamme. Insomma, è
possibile che l’uomo
raffigurato nella stele
trovata nella camera
sepolcrale di re Pacal
sia un antico guerriero
maya armato con un
moderno fucile o
lanciafiamme.
Visto questo strano e
misterioso personaggio,
procediamo nella nostra
esplorazione ed
avviciniamoci al
sepolcro.
 Prima
di analizzare la Lastra,
diamo un’occhiata a ciò
che copriva. Il
sarcofago nel suo
insieme risultò
collegato alla soglia
della cripta con una
strana modanatura di
calce, che si
trasformava poi
addirittura in una
condotta vuota. Questa
seguiva le scale fino al
congiungimento con la
lastra rimossa dagli
archeologi sul pavimento
del tempio nel momento
in cui fu iniziata
l’esplorazione
dell’interno della pira Prima
di analizzare la Lastra,
diamo un’occhiata a ciò
che copriva. Il
sarcofago nel suo
insieme risultò
collegato alla soglia
della cripta con una
strana modanatura di
calce, che si
trasformava poi
addirittura in una
condotta vuota. Questa
seguiva le scale fino al
congiungimento con la
lastra rimossa dagli
archeologi sul pavimento
del tempio nel momento
in cui fu iniziata
l’esplorazione
dell’interno della pira mide;
una sorta di
collegamento magico fra
il sepolto (un probabile
principe divinizzato), e
l’Ah Kin Mai, ovvero il
sommo sacerdote. Il
sarcofago, all’interno
intonacato di rosso
cinabro, conteneva il
corpo di un uomo posto
in posizione supina e
senza apparenti lesioni.
L’uomo che vi era
sepolto era chiamato
halac uinic, ossia il
“Vero Uomo”. Era alto
173 centimetri: fatto,
questo, di particolare
rilievo, visto che
l’altezza media dei Maya
era attorno ai 150
centimetri. L’età che
approssimativamente si
può assegnare al corpo
contenuto nel sarcofago
è circa 40 anni. Ora,
iscrizioni varie
affermano che quella era
ed è la tomba di re
Pacal, il quale visse
per 80 anni, tra il 603
ed il 683. Considerando
che il corpo contenuto
nel sarcofago appare
appartenere ad un uomo
di 40 circa di età,
possiamo fare due
supposizioni: o Pacal
non dimostrava i suoi
anni, oppure quello non
è il suo corpo. Abbiamo
detto, più sopra, come
fosse usanza estetica
dei Maya quella di
schiacciare il cranio
dei neonati allo scopo
di deformarlo. A
dispetto di questa
usanza, il corpo nel
sepolcro non presenta
questo tipo di
deformazione (e neanche
le altre caratteristiche
deformazioni dentarie):
questo fatto, unito al
dato della sua
relativamente
impressionante altezza,
ci può far supporre che
il corpo contenuto nel
sarcofago non sia quello
di Pacal, forse nemmeno
di un uomo maya. A
suffragio di
quest’ipotesi un altro
fatto: l’ analisi del
cranio nei punti “Glebella”,
“Nasion”, mide;
una sorta di
collegamento magico fra
il sepolto (un probabile
principe divinizzato), e
l’Ah Kin Mai, ovvero il
sommo sacerdote. Il
sarcofago, all’interno
intonacato di rosso
cinabro, conteneva il
corpo di un uomo posto
in posizione supina e
senza apparenti lesioni.
L’uomo che vi era
sepolto era chiamato
halac uinic, ossia il
“Vero Uomo”. Era alto
173 centimetri: fatto,
questo, di particolare
rilievo, visto che
l’altezza media dei Maya
era attorno ai 150
centimetri. L’età che
approssimativamente si
può assegnare al corpo
contenuto nel sarcofago
è circa 40 anni. Ora,
iscrizioni varie
affermano che quella era
ed è la tomba di re
Pacal, il quale visse
per 80 anni, tra il 603
ed il 683. Considerando
che il corpo contenuto
nel sarcofago appare
appartenere ad un uomo
di 40 circa di età,
possiamo fare due
supposizioni: o Pacal
non dimostrava i suoi
anni, oppure quello non
è il suo corpo. Abbiamo
detto, più sopra, come
fosse usanza estetica
dei Maya quella di
schiacciare il cranio
dei neonati allo scopo
di deformarlo. A
dispetto di questa
usanza, il corpo nel
sepolcro non presenta
questo tipo di
deformazione (e neanche
le altre caratteristiche
deformazioni dentarie):
questo fatto, unito al
dato della sua
relativamente
impressionante altezza,
ci può far supporre che
il corpo contenuto nel
sarcofago non sia quello
di Pacal, forse nemmeno
di un uomo maya. A
suffragio di
quest’ipotesi un altro
fatto: l’ analisi del
cranio nei punti “Glebella”,
“Nasion”,
 “Rinion”
non corrispondono a
punti uguali di un
cranio di alcuna razza
terrestre conosciuta. Il
corpo appariva coperto
da una maschera di giada
e madreperla e
presentava un grano di
giada scura nella cavità
orale, secondo l’usanza
maya. Oltre a questo,
nella mano sinistra fu
ritrovata una perla
sferica e nella destra
una perla cubica. Una
possibile
interpretazione della
sfera è che essa
rappresenti la totalita’,
la perfezione, il tempo
oppure il cielo o la
Terra stessa, mentre il
cubo potrebbe indicare
la determinazione di un
punto nello spazio,
attraverso le tre
dimensioni, usando i tre
assi cartesiani. A
completare il corredo
funerario un diadema,
orecchini, una collana,
bracciali (ai polsi,
formati da più di 200
perle), anelli (uno per
ogni dito delle mani) e
statuine, tutti in
giada, nonché preziose
teste a tutto tondo in
stucco, forse ritratti
del sovrano stesso.
L’oggetto più
interessante, oltre la
maschera, è un pettorale
composto da nove cerchi
concentrici, costituiti
ognuno da 21 perle, con
al centro una perla
falsa costituita da due
ostriche perlifere
unite. Tutti gli
Studiosi concordano
nell’affermare che i
nove cerchi concentrici
rappresentano le orbite
dei nove Pianeti
costituenti il Sistema
Solare e la falsa perla
rappresenterebbe il
Sole. Questo è ciò che
era contenuto
all’interno del
sarcofago. Accanto alla
tomba furono trovate due
teste di stucco: una è
uguale al cranio
dell’uomo, mentre
l’altra è uguale al
cranio di uomini
appartenenti alla razza
del popolo Maya, come la
forma della testa
suggerisce. “Rinion”
non corrispondono a
punti uguali di un
cranio di alcuna razza
terrestre conosciuta. Il
corpo appariva coperto
da una maschera di giada
e madreperla e
presentava un grano di
giada scura nella cavità
orale, secondo l’usanza
maya. Oltre a questo,
nella mano sinistra fu
ritrovata una perla
sferica e nella destra
una perla cubica. Una
possibile
interpretazione della
sfera è che essa
rappresenti la totalita’,
la perfezione, il tempo
oppure il cielo o la
Terra stessa, mentre il
cubo potrebbe indicare
la determinazione di un
punto nello spazio,
attraverso le tre
dimensioni, usando i tre
assi cartesiani. A
completare il corredo
funerario un diadema,
orecchini, una collana,
bracciali (ai polsi,
formati da più di 200
perle), anelli (uno per
ogni dito delle mani) e
statuine, tutti in
giada, nonché preziose
teste a tutto tondo in
stucco, forse ritratti
del sovrano stesso.
L’oggetto più
interessante, oltre la
maschera, è un pettorale
composto da nove cerchi
concentrici, costituiti
ognuno da 21 perle, con
al centro una perla
falsa costituita da due
ostriche perlifere
unite. Tutti gli
Studiosi concordano
nell’affermare che i
nove cerchi concentrici
rappresentano le orbite
dei nove Pianeti
costituenti il Sistema
Solare e la falsa perla
rappresenterebbe il
Sole. Questo è ciò che
era contenuto
all’interno del
sarcofago. Accanto alla
tomba furono trovate due
teste di stucco: una è
uguale al cranio
dell’uomo, mentre
l’altra è uguale al
cranio di uomini
appartenenti alla razza
del popolo Maya, come la
forma della testa
suggerisce.
I tratti somatici dello
scheletro e di una delle
due teste di stucco
presentano gli stessi
tratti somatici che
appaiono nell’uomo che
si trova sulla lastra
posta a coperchio della
tomba.
Analizzato il contenuto
del sarcofago, passiamo
finalmente ad osservare
la sua copertura, la
famosissima Lastra di
Palenque:


La Lastra misura 380 per
220 centimetri, con uno
spessore di 25; il peso
è stato calcolato essere
attorno alle 5
tonnellate. Attorno
all’orlo della Lastra
corre un’iscrizione
pressoché indecifrabile,
ricca di segni e
simboli; in essi gli
studiosi riconobbero,
ricavandole a fatica,
tredici date, che
permisero di datare
l’opera al 692 d.C. e di
risalire al nome del
defunto, il re-sacerdote
Pacal.
Come si può vedere dalle
rappresentazioni più
sopra, vi è
rappresentato un uomo
(poiché non vi sono
evidenti segni da far
supporre che sia una
figura femminile)
raffigurato in una
strana posizione, come
se stesse guidando una
bicicletta moderna; le
sue mani sembrano
armeggiare su delle
leve; la testa pare
essere poggiata su un
supporto (anche se è
probabile che si tratti
di un gioco
prospettico); il volto è
rivolto verso sinistra
ed ha lo sguardo vigile
di chi sta osservando
qualcosa con grande
attenzione; nel naso
sembra essere inserito
un oggetto dalla vaga
forma triangolare.
Davanti a lui, volendo
usare un po’ di
fantasia, tubi,
utensili, apparecchi
misti a simboli scolpiti
alla rinfusa. Sul retro
una grossa maschera che
alcuni indicano come la
raffigurazione del
Sole.
Le disquisizioni circa
il vero significato
della rappresentazione
sono state, sono e
saranno infinite.
Vediamo di elencare
quelle più plausibile o,
perché no, quelle più
affascinanti.
Secondo una spiegazione
“tradizionale”, il
bassorilievo mostra il
re tra le fauci del
Mostro Terrestre una
divinità con sembianze
di grosso rettile o
dragone che si nutre dei
corpi dei defunti, quasi
con la funzione di
riassorbirli nel proprio
interno (così come da
esso un tempo sono stati
generati, secondo quella
che appare essere
un’allegoria della
discesa nell’aldilà);
sopra di lui sarebbe
l’Albero della Vita,
sulla cui sommità sta
appollaiato Itzamná, il
Dio Supremo nelle vesti
di un ibrido metà
uccello e metà serpente.
La scena è arricchita
ovunque da molte altre
allegorie simboleggianti
il mais, l’acqua, il
fulmine, il sole e la
luna e l’onnipresente
Quetzal (nella parte
superiore) una sorta di
grosso pappagallo
ritenuto un uccello
sacro. Se proviamo per
un attimo ad osservare
altri numerosi esempi
dell’arte della
raffigurazione simbolica
del popolo maya, potremo
facilmente ritrovare
molti degli elementi che
costituiscono proprio la
lastra tombale di
Palenque; questo non
perché in altri casi si
sono voluti esprimere
gli stessi significati,
bensì perché ci troviamo
di fronte ad una specie
di alfabeto figurato
componibile, in grado di
essere costruito a
seconda delle esigenza
proprie del significato
stesso.
Altra teoria “con i
piedi per terra”: Adrian
Gilbert e Maurice
Cotterel, nel libro Le
Profezie dei Maya,
sostengono che sulla
pietra sia raffigurata
la dea Chalchiuthlique e
con lei gli Dei Tlaloc,
Tonatiuh e Ehecatl. I
simboli e i disegni
rappresenterebbero, in
pratica, il Popol Vuh
scritto, con la
creazione delle razze e
le loro relative
distruzioni.
L’ipotesi che, però,
pare più affascinante e
più fantasiosa (e che
inconsciamente soddisfa
di più) è quella che
vede raffigurato, nella
Lastra di Palenque, un
antico astronauta,
magari neanche
terrestre. Secondo
quest’interpretazione,
l’uomo della Lastra
sarebbe un viaggiatore
spaziale impegnato a
manovrare i complicati
comandi della propria
astronave. Quelle nelle
sue mani sarebbero
dunque delle leve (forse
i comandi della sua
astronave) e quello
attaccato al suo naso un
respiratore. Alla luce
di questo, ancora,
quegli strani segni che
sono presenti alle sue
spalle
rappresenterebbero le
fiamme prodotte dal
sistema di propulsione
del suo mezzo di
trasporto spaziale,
mentre quelli davanti a
lui, che qualcuno ha
inteso a vaga forma di
vortice, risucchi d’aria
provocati dal movimento
generato dal motore a
reazione dell’astronave.
Se vogliamo dare per
buona questa ipotesi
(cosa che non costa
fatica e che soddisfa,
ma che apre moltissimi
problemi), allora le due
teste di stucco presenti
vicino al sarcofago
acquisterebbero un
significato particolare:
la testa non deformata,
uguale a quella
dell’uomo contenuto nel
sepolcro, posta vicino
ad una testa maya
deformata indicherebbe
chiaramente come il
corpo nel sarcofago non
appartenga ad un maya. O
magari neanche ad un
essere umano.
Dunque la Lastra di
Palenque come
rappresentazione di uno
dei primissimi
astronauti della storia
dell’uomo.
Apparentemente, questa
teoria, per quanto
sufficientemente logica,
potrebbe stupire.
Eppure, non deve essere
così. Infatti, la storia
e la mitologia di quasi
tutti i popoli
precolombiani del centro
e del sud America è
costellata dalla
presenza di viaggiatori
stranieri, spesso
esplicitamente indicati
come provenienti dalle
stelle. Facciamo un
esempio. I nativi della
regione Chihuahua, in
Messico, narrano di un
antica leggenda,
risalente a più di 200
anni fa, il cui
protagonista sarebbe un
certo “ragazzo delle
stelle”. In sintesi, nel
mito si parla di esseri
venuti dalle stelle,
che, scesi dal cielo,
fecondarono le donne
umane nei villaggi
sperduti di questa
popolazione. Alle donne
fecondate da questi
esseri alieni era
permesso allevare i
propri figli, detti
anch’essi “figli delle
stelle”, fin quando gli
esseri delle stelle non
sarebbero ritornati dal
cielo per prelevare e
portare via con loro
nello spazio la loro
progenie nata sulla
Terra.
Questo è soltanto un
esempio e, come detto
sopra, di matrice mitica
e leggendaria. Prove più
concrete e logiche di
queste antiche visite da
parte di esseri
provenienti dallo spazio
sono state fornite da
Alan Landsburg nel suo
Alla scoperta di antichi
misteri. Il punto di
partenza per l’indagine
condotta da Landsburg è,
questa volta,
geografico. In sud
America, tra Perù e
Bolivia, esiste un lago
chiamato Titicaca.
Nell’antica lingua degli
abitanti di quel luogo,
l’aymara, Titicaca
significa “pietra del
giaguaro”. Per quasi due
secoli, nessuno studioso
delle civiltà
precolombiane seppe dare
una spiegazione allo
strano nome di quello
specchio d’acqua in
Perù. Soltanto grazie ai
primi voli spaziali,
alle prime spedizioni
che abbandonarono la
superficie del pianeta
si poté dare una
risposta a questo
enigma: il lago Titicaca
si chiama così perché
dall’alto (e stiamo
parlando di altitudini
comparabili con quelle
raggiunte da alcuni
satelliti) il lago ha
proprio la forma di un
giaguaro. Visto questo
fatto, la domanda sorge
spontanea: come è stato
possibile che una
civiltà precolombiana
potesse “indovinare” la
forma di un lago quale
appare da altitudini
simili? L’unica
spiegazione, secondo
Landsburg, è che quegli
antichi uomini fossero
in grado di viaggiare
nello spazio e che,
proprio dallo spazio,
abbiano visto la forma
del lago.
Poco distante da
Titicaca, esiste
un’antica città chiamata
Tiahuanaco. Ormai questo
centro abitato è
piuttosto degradato e
corroso dall’azione del
tempo, ma, nonostante
questo, conserva un
fascino misterioso ed
inquietante. Il mistero
di questa città, in
particolare, sta nel
modo in cui essa fu
costruita: i suoi muri,
infatti, sono formati da
enormi massi,
giganteschi e massicci
come megaliti, che sono
stati squadrati e
levigati, in modo che
combaciassero tra loro
senza alcun bisogno di
intonaco od altri
materiali collanti. In
quelle mura non ci sono
crepe ed è impossibile
penetrare con uno
scalpello tra un masso e
l’altro. Ogni masso è
scanalato perfettamente,
in maniera da
incastrarsi sopra il
masso inferiore e tra i
massi laterali. Alcuni
studiosi hanno
ipotizzato che, per
costruire tali opere di
muratura, si usasse un
procedimento simile al
seguente: un masso viene
issato e fatto calare
sopra un altro, allo
scopo di determinare i
punti congiunzione con
quello sottostante e
quelli laterali; in
seguito, il masso viene
di nuovo sollevato e
posto su in fianco
perché le scanalature
siano realizzate;
infine, il masso viene
nuovamente issato e
finalmente collocato nel
muro in costruzione.
Detto così, non ci
sarebbe nulla di strano,
in questo; ciò che fa
riflettere, però, sta
nell’enorme peso di ogni
masso (circa 12
tonnellate) e nella
posizione della città
(la cima di un monte,
certamente non agevole
per la realizzazione di
tali costruzioni e con
questo procedimento).
Una struttura analoga si
trova presso la città
pre-incaica di
Ollantaytambo. Anche in
questo caso, inutile
dirlo, la costruzione di
tali opere lascia
sbalorditi tutti gli
studiosi terrestri:
un’opera così grandiosa,
considerando la
complessità della
struttura, l’enorme peso
dei materiali usati, è
certamente incredibile
per gli standard edili
di quei tempi. Oltre a
queste bizzarrie
architettoniche, sulle
mura di Tiahuanaco è
possibile ammirare una
stupefacente quanto
estesa raffigurazione di
guerrieri (piuttosto
stilizzati, va detto, ma
comunque
sufficientemente ben
delineati) in
processione. Anche in
questo caso,
apparentemente nulla
appare fuori posto. Il
fatto incredibile, però,
è che molti dei
guerrieri rappresentati
hanno fattezze e tratti
somatici appartenenti a
nessun popolo vivente, a
quel tempo, in sud
America: vi sono
guerrieri dai tratti
africani (con naso
schiacciato e labbra
piene e leggermente
sporgenti), vi sono
guerrieri dai tratti
asiatici (con i
caratteristici occhi a
mandorla), vi sono
guerrieri dai tratti
caucasici e semitici.
Come è stato possibile,
per gli abitanti di
queste due città,
costruire simili
colossali opere? Come è
stato possibile, per gli
architetti e gli artisti
di Tiahuanaco,
rappresentare l’enorme
varietà di popoli della
Terra, a loro del tutto
sconosciuti? A questi
quesiti, sostiene
Landsburg, ci sono due
sole possibili: gli
abitanti di Tiahuanaco e
Ollantaytambo non erano
terrestri, ma alieni;
gli abitanti di
Tiahuanaco e
Ollantaytambo erano in
contatto con esseri in
grado di viaggiare
liberamente sul nostro
pianeta e, dunque,
raggiungere paesi e
popoli lontani. Secondo
l’appena citato
studioso, circa
14.000-13.000 anni fa,
dallo spazio (l’unica
altezza possibile per
rendersi conto della
forma del lago Titicaca)
vennero alcuni
visitatori
extraterrestri. Tali
visitatori si
stabilirono in quella
zona ed insegnarono a
popoli là stanziati la
tecnologia per costruire
(o costruirono loro
stessi) la due città
descritte sopra. In
seguito, sempre secondo
la teoria, da quel
luogo, questi visitatori
si mossero in varie
parti del Sud America:
quando essi incontrarono
dei popoli (Maya ed
Inca, per esempio),
insegnarono loro la
propria tecnologia,
creando, praticamente,
le due civiltà
precolombiane
sudamericane che
conosciamo e le loro
incredibili,
avanzatissime, realtà
tecnologiche e
culturali. Questi
visitatori, secondo
quanto narrato ad alcuni
conquistadores spagnoli
dagli stessi indigeni
locali, erano in grado
di curare i malati gravi
e resuscitare i morti;
erano in grado di
prevedere importanti
fenomeni celesti,
insegnarono loro a
contare. I nomi di
questi visitatori e
“maestri”, nelle culture
sudamericane, sono
Vicocha e Quetzacoatl.
In seguito, come ci è
testimoniato da alcune
leggende locali, questi
viaggiatori
abbandonarono
improvvisamente i loro
amici terrestri
utilizzando “tappeti che
viaggiavano sull’acqua”,
ma preannunciando il
loro prossimo ritorno.
Sempre secondo la teoria
di Landsburg, millenni
dopo le conoscenze dei
visitatori furono
trasmesse anche agli
antichi Egizi, che le
utilizzarono per la
costruzione delle
piramidi e per la
creazione della loro
splendente civiltà e
cultura, forse la più
avanzata del mondo
antico. Ovviamente i
dati raccolti da
Landsburg non si fermano
a questo, ma riguardano
la maggior parte degli
antichi popoli della
Terra. Tuttavia, per
pertinenza di argomento
e per non subissare chi
sta leggendo di una
quantità infinita di
dati, ci siamo voluti
attenere agli elementi
riguardanti le civiltà
sudamericane.
Dunque i Maya e gli Inca
come fruitori di
conoscenze provenienti
da spazi cosmici. Ma non
tutto. Landsburg colloca
i primi arrivi alieni
sulla Terra ancora più
indietro nel tempo. Nel
XIX secolo, lo
scienziato inglese
Calvin sostenne che la
vita sulla Terra non era
un prodotto casuale
(nato dalla casuale
aggregazione di elementi
che hanno formato la
prima cellula) o del
tutto “autoctono”. Al
contrario, Calvin
riteneva che la vita
sulla Terra provenisse
da una “spora” giunta
sulla Terra per mezzo di
un meteorite. Il grande
chimico svedese Svante
Arrhenius, poi, riteneva
che l’arrivo di questo
meteorite non fosse
stato casuale, ma fosse
un evento accaduto per
precisa volontà di
“qualcuno” che si
trovava in un altro
sistema solare. Insomma,
la Terra, ancora priva
di vita, sarebbe stata
“fecondata” da forme di
vita aliena. Per lungo
tempo, queste teorie
furono viste come mere
speculazioni
fantascientifiche. Di
recente, però, grazie
all’osservazione
dell’infinitamente
piccolo biologico,
queste teorie hanno
ritrovato parzialmente
credito. Si è osservato,
per esempio, che, nei
processi cellulari, un
elemento chimico
fondamentale è il
molibdeno. Tale
minerale, però, è
scarsamente presente
sulla Terra, in quantità
minore, per esempio,
rispetto al nichel o al
cromo, relativamente
meno importanti nei
processi vitali
cellulari. Questo è un
primo indizio
importante. Lo studio
dell’evoluzione umana,
poi, ha aperto altre
vie, che hanno fatto
supporre, ai sostenitori
della teoria
dell’inseminazione, che
i nostri “creatori” non
si siano limitati a
fecondare la Terra, ma
che abbiano anche
controllato e regolato
l’evoluzione della vita
con successive
modificazioni genetiche
od altre inseminazioni
di forme di vita più
evolute. Facciamo
qualche esempio. Nel
1961, in Africa
Orientale, fu scoperto
un ominide, lo
Zinjanthropus, che esami
rivelarono da datarsi a
due milioni di anni fa.
Era privo di zanne,
squame, artigli,
speroni; era lento a
muoversi e lento a
salire sugli alberi e
camminava quasi eretto.
Il suo viso era a forma
di vanga, con una fronte
sfuggente ed una
mascella adatta a
sgranocchiare ossa; la
scatola cranica era metà
di quella dell’Homo
Sapiens Sapiens. Appare
strano a tutti gli
antropologi che sia
sopravvissuto. Il
successivo stadio
dell’evoluzione umana è
rappresentato dal
cosiddetto Uomo di
Pechino, che visse sulla
Terra circa un milione
di anni fa, esattamente
ad un milione di anni di
distanza dallo
Zinjanthropus. La
scatola cranica
dell’Uomo di Pechino è
leggermente più capace
di quella del suo
progenitore, cosa che,
probabilmente, gli ha
permesso di acquisire le
conoscenze fondamentali
per poter accendere il
fuoco ed imparare come
mantenerlo vivo. Ora, è
lecito pensare che, se
c’è voluto un milione di
anni per scoprire il
fuoco, per raggiungere
le conoscenze attuali ce
ne sarebbero voluti come
minimo miliardi. Eppure,
incredibilmente, poche
centinaia di migliaia di
anni dopo appare sulla
Terra l’Uomo di
Neanderthal. Questo
antico progenitore
dell’uomo ha un aspetto
completamente differente
dai suoi antenati: se
vivesse ai giorni
nostri, sostengono gli
studiosi, ben pochi,
incontrandolo in strada,
si girerebbero a
guardarlo. Il
Neanderthal conosce il
fuoco, naturalmente,
spela gli animali,
fabbrica piccoli
utensili, anche in
legno, vive in comunità,
seppellisce i propri
morti, cura gli
ammalati. Ed ha una
scatola cranica una
volta e mezzo quella di
Zinjanthropus e
dell’Uomo di Pechino e
ben duecento centimetri
cubici più ampia della
nostra.
Inspiegabilmente, 35.000
anni fa, il Neanderthal
scompare nel nulla. Non
si sa bene quale fine
abbia fatto: forse si è
semplicemente estinto.
Al suo posto,
altrettanto
improvvisamente, compare
l’Uomo di Cro-Magnon o
Homo Sapiens, il nostro
antenato più diretto:
era alto fino ad un
metro e ottantacinque,
era molto abile
manualmente (era in
grado di costruire armi,
come delle specie di
antiche fionde, e
moltissimi utensili,
anche piuttosto
complessi), praticava
l’allevamento e
l’agricoltura ed aveva
senso artistico (come
dimostrano i dipinti di
Lescaux ed Altamira); il
suo cervello era più
voluminoso del nostro
anche di trecento
centimetri cubici.
E’ opinione di molti
scienziati che
un’evoluzione tanto
rapida sia cosa
incredibile, sia a
livello fisico (il piede
dell’Uomo di
Neanderthal, dicono gli
esperti, non può essere
derivato da quello
dell’Uomo di Pechino in
così breve tempo) che
mentale. Insomma, la
rapidità vertiginosa
dell’evoluzione umana,
considerando i parametri
riguardanti gli altri
esseri viventi, se non
fosse provata da reperti
fossili sarebbe da
considerarsi
impossibile. Eppure è
avvenuta.
Visti questi fatti, la
teoria di Calvin ed
Arrhenius non sembra
così campata per aria:
anticamente, almeno tre,
quattro miliardi di anni
fa, qualcuno da un altro
pianeta fecondò la Terra
con il proprio codice
genetico, dando origine
a tutta la vita presente
su questo pianeta. In
seguito, questi
misteriosi “genitori”
vennero sul nostro
pianeta e guidarono,
mediante modificazioni
genetiche, innesti,
incroci, la nostra
evoluzione, fino a dare
origine all’uomo come lo
conosciamo. Creato un
uomo dalle potenzialità
e capacità sufficienti a
dominare la Terra, i
genitori spaziali
avrebbero condotto
successive visite, dando
origine alle civiltà
precolombiane e a quella
egizia.
Le nostre origini,
insomma, dalla nascita
della primigenia cellula
ai tempi moderni,
sarebbero il frutto del
lavoro oscuro di esseri
provenienti dallo
spazio, esseri che ci
hanno dato la vita,
l’intelligenza ed i
mezzi per imporci su
tutte le altre specie
viventi. E la Lastra di
Palenque ne potrebbe
essere la prova: forse
l’uomo viene dalle
stelle.
BIBLIOGRAFIA
·
Alla scoperta di antichi
misteri, di Alan e Sally
Landsburg, Milano,
Arnoldo Mondadori
Editore, 1974.
·
Nella Storia, di Carlo
Cartiglia, Torino,
Loescher Editore, 1997,
vol. 1, Dal XIV secolo
al 1650, pagg.123-125.
WEBGRAFIA
·
www.edicolaweb.net/edic064s.htm
, contenete l’articolo Palenque: l’ultimo
steccato, di Mauro
Paoletti.
·
www.edicolaweb.net/nonsoloufo/um_fot07.htm
·
www.edicolaweb.net/pacal01g.htm
·
http://amolt.interfree.it/Messico/arte_prec02_palenque.htm
·
www.mexicoart.it/Ita/PacalLap.htm
·
www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/re_bambino_dei_maya.htm
·
www.the1phoenix.net/x-files/archeosp.htm |