|
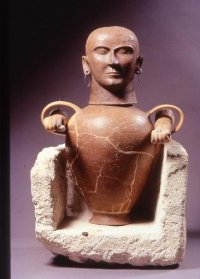 Con
la caduta di Veio invece
di festeggiare una
vittoria ci si trovò
sull'orlo della
catastrofe, perché ci fu
l'invasione gallica.
Qualcuno disse che la
sventura fu attirata
sulla città dal
vincitore, Camillo, che
celebrò il proprio
trionfo con cavalli
bianchi, privilegio di
Giove. Per la sua
empietà fu punito con
l'esilio, ma
naturalmente i Galli non
si fermarono. Anche per
quest'avvenimento
disponiamo ormai di due
fonti: Livio e
l'annalistica greca, con
un leggero scarto di
date, il primo la fa
risalire al 390, mentre
i Greci la collocano nel
386 a. C. entrambi
concordano invece sul
giorno: 18 luglio, che
da allora fu
ufficialmente dichiarato
giorno nefasto. Gli
storici, sostanzialmente
contrari ai Fabi, non
hanno esitato a parlar
di tradimento,
soprattutto per quanto
riguarda la presa di
Chiusi. L'ipotesi non è
incredibile. Le guerre
erano ancora un fatto
del tutto privato, come
suggeriscono gli "elmi
firmati" ritrovati un
po' ovunque ed è
impensabile che un
semplice esercito di
cittadini, per quanto
coraggioso, potesse aver
ragione sui "signori
della guerra" che da tre
secoli ormai dominavano
la penisola; non è
escluso che qualcuno
avesse reclutato milizie
celtiche e poi non
potendo pagarle, abbia
dovuto cedere qualche
territorio al
saccheggio. Anche in
quest'occasione infatti
non si può assolutamente
parlare d'invasioni
nell'accezione rovinosa
d'un tempo. I Galli
erano semplicemente a
caccia di bottino e fu
relativamente facile per
Roma mettere in salvo
gli oggetti sacri e le
Vestali, che L. Albinio
condusse in una città
etrusca alleata: Caere.
Per il buon esito della
spedizione, la moglie d'Albinio
votò nel 375 a. C. un
tempio all'ormai romana
Juno Lucina. Si trattava
però d'una salvezza
relativa, in città la
strenua resistenza dei
giovani romani sul
Campidoglio meritò
addirittura l'attenzione
d'Aristotele: per la
prima volta il pericolo
rappresentato dai
Barbari si presentò al
mondo mediterraneo in
tutto il suo peso. In
quegli stessi giorni,
nel 388 a. C. cade
Melpum e finisce per
sempre il dominio
etrusco in Val Padana,
che da questo momento
diventerà "Gallia
Cisalpina"; solo le
valli dei Reti, restando
appunto isolate,
conserveranno un pallido
riflesso della cultura
etrusca. A differenza di
Roma, che cercherà al
più presto di respingere
l'invasore, la Val
Padana si mostra
soddisfatta della nuova
sistemazione. Più tardi,
in epoca imperiale,
Milano sosterrà appunto
d'essere stata fondata
dai Galli, tanto che
alcuni storici
suggeriscono che Melpum
sorgesse nei dintorni
della Melzo attuale. In
realtà è molto strano
immaginare questi
nomadi, scesi dalle Alpi
per arricchirsi, che
perdono tempo a radere
al suolo una città già
fiorente per poi
fondarne una nuova un
po' più in là. Più
semplice pensare invece
che Milano, con le
caratteristiche mura ed
il "pomerium" fiorito di
biancospino, come
racconterà più tardi
Bovesin della Riva, sia
di fondazione etrusca ed
i Galli, trovando una
buon'accoglienza,
abbiano deciso di farne
una loro sede stabile.
Dall'altra parte delle
Alpi non s'usava affatto
vivere in città. Al
massimo si circondava
d'un muraglione
difensivo qualche
villaggio
particolarmente esposto
agli assalti del nemico!
Tra l'altro proprio
dall'incontro tra
quest'usanza e l'antico
pomerium nasceranno, nel
III sec. a. C. le mura
cittadine come furono
concepite in seguito. La
favola della fondazione
di Milano tuttavia
contiene un fondo di
verità: nessuno più è
fiero delle origini
etrusche! Roma
riconoscerà a Caere una
posizione d'alleata, ma
questo non le impedirà
d'assoggettare ad una ad
una tutte le altre città
della Toscana. Inizia
così il lungo tramonto
di quella che era stata
la più gran potenza
della penisola,
l'anticipatrice della
stessa società romana.
Che cosa si rimprovera
agli Etruschi? La colpa
più grave del mondo:
aver perso la guerra! Le
città fondate col rito
etrusco son state messe
a ferro e fuoco, ne' più
ne' meno delle altre.
L'Etruria è devastata
dalle rivolte di schiavi
ed i liberti prendono
con la forza il potere
nei municipi di Volsini
ed Enarea. Le
sacerdotesse che
giravano tranquillamente
per le strade, coi loro
vistosi abiti tinti di
porpora e d'indaco han
subito violenza, senza
che i famosi auguri
riuscissero a prevenire,
ne' ad evitare la
catastrofe! A che
servono dunque tanti
complicati riti? E Roma,
che pure doveva tanto
alla cultura etrusca, la
ridusse ad un semplice
accumulo di
superstizioni. Con la
cacciata del Superbo e
la guerra a Porsenna,
gli Etruschi passarono
di moda e gli annalisti
non parlarono più di
prodigi, ma di
superstizioni, anche se
gli aruspici etruschi
furono ancora consultati
a lungo per la vita
privata. Per i pericoli
che minacciano lo stato
si consultano invece i
Libri Sibillini. Dionigi
d'Alicarnasso (IV, 62) e
Lattanzio (De
Istitutionis I, 6)
raccontano che una
misteriosa donna
straniera e vecchissima
ne propose l'acquisto a
Tarquinio il Superbo per
una somma spropositata.
Al suo rifiuto ne bruciò
progressivamente, con
l'aiuto delle sue arti
magiche, almeno tre,
continuando a chiedere
però sempre la stessa
somma, finché alcuni
auguri presenti
convinsero il re ad
acquistare ciò che
restava. I preziosi
testi furono nascosti
nei sotterranei del
tempio capitolino, dove
tuttavia bruciarono nel
83 a.C. La donna
misteriosa scomparve per
sempre; Lattanzio
suggerisce la
possibilità che si
trattasse della Sibilla
Cumana. In realtà
all'epoca la Sibilla era
consultata direttamente
dagli interessati e lo
stesso accadeva per le
sacerdotesse greche. Gli
Etruschi invece avevano
raccolto il proprio
sapere in numerosi testi
sacri: libri "fulgurales"
per l'interpretazione
dei fulmini, "rituales"
con le prescrizioni
necessarie per celebrare
i vari riti, "acheruntici"
con tutto ciò che
riguardava l'oltretomba.
È probabile che
Tarquinio il Superbo,
figlio e nipote
disacerdotesse, non
avesse certo bisogno di
vecchiette sconosciute
che gli proponessero
testi sacri... la
leggenda fu
evidentemente inventata
più tardi per
giustificare la presenza
dei testi etruschi nel
tempio e soprattutto la
necessità di continuare
a consultarli, anche
dopo la cacciata di
Tarquinio... che tra
l'altro si rifugiò
appunto a Cuma. Tutta la
storia appare inventata
per dare ai testi, senza
dubbio etruschi, una
patente esotica,
ellenistica. I tempi
s'erano fatti duri, non
c'era tempo per un
cerimoniale tanto
complesso, bisognava
avere il coraggio di far
delle scelte precise. La
tecnica divinatoria fu
rigidamente
disciplinata: si ridusse
il numero dei presagi
d'accogliere,
introducendo invece la
possibilità di
"suggerire" qualche
nuovo elemento,
semplicemente
nominandolo, quando la
divinità consultata
restava muta troppo a
lungo. Si limitò
drasticamente lo spazio
sacro al chiuso dei
templi ed alle loro
immediate adiacenze e si
considerarono
significativi solo gli
animali sacri allevati
in cattività, tanto più
facili da controllare!
La donna continuava ad
essere rispettata come
moglie e madre... purché
se ne stesse in casa sua
o nel tempio, come le
Vestali. I Greci avevano
operato da tempo questa
sana restrizione,
distinguendo bene le
madri di famiglia, che
vivevano nel gineceo,
dalle altre, le
cortigiane.
Significativo è il fatto
che in Italia la
prostituzione sacra
s'esercitasse nei templi
di Uni, nel cuore della
città, mentre in Grecia
nei giardini d'Afrodite,
strategicamente
costruiti accanto al
porto. Perché
complicarsi la vita?
Roma fa di più. Nega
proprio la sacralità
della cosa. Perché
mentire? Si tratta d'un
semplice mercato ed è
del tutto evidente che
la prostituta non può
più tornare ad essere
una madre di famiglia!
Può darsi che in origine
fossero solo norme di
guerra, senza
l'intenzionalità che vi
ha connesso la critica
femminista. Non
dimentichiamo che i
pirati infestavano le
coste e le città
dell'entroterra erano
tutte in guerra fra loro
per un motivo o per
l'altro. Tuttavia
chiudere una donna in
casa in un'epoca in cui
l'unico mezzo di
sostentamento lecito per
una famiglia era
l'amministrazione dei
beni fondiari, spesso
dotali, vuol dire
riconoscere lo "status"
di donna onesta soltanto
a chi è provvista di
mezzi! Per questo la
critica moderna fa
sempre più fatica a
credere che la cacciata
di Tarquinio avesse come
motore la difesa
dell'onore di Lucrezia!
Se anche stupro c'è
stato, certo la ragion
di stato ha
abbondantemente
strumentalizzato un
argomento che in altre
circostanze si sarebbe
tranquillamente
consumato in silenzio,
come tante tragedie
domestiche. In uno stato
che non poteva proibire
l'aborto, ma lo
condannava sempre più
apertamente, l'unica
soluzione possibile per
le famiglie non più
ricche era ricorrere
sempre più spesso
all'esposizione dei
neonati, soprattutto di
sesso femminile,
alimentando il fiorente
mercato degli schiavi.
Che accadeva intanto in
Toscana? Pare difficile
crederlo, ma tutto
continuava come prima.
Meglio di prima verrebbe
da pensare, vedendo i
reperti artistici degli
ultimi secoli avanti
Cristo, senza dubbio i
migliori, quando
affreschi e pitture
assorbono completamente
i modi del naturalismo
romano ed i corpi, un
tempo stilizzati,
s'animano di vita reale.
Gli oggetti più pregiati
appartengono a questo
periodo, che ci
attenderemmo di
decadenza. Poiché non è
mai esistita una nazione
etrusca, ma singole
città dal diverso
destino politico, pare
non esista neppure una
coscienza della
sconfitta subita.
Durante l'assedio di
Troilum, città oggi
sconosciuta, il console
Carvilio ebbe cura di
far fuggire, dietro al
pagamento di un
riscatto, tutti i
notabili della città
prima di far capitolare
la plebe. Anche se non
sempre ci sono
testimonianze così
precise è probabile che
lo statuto di città
federate proposto a
tutte le città toscane
prevedesse un
trattamento diverso per
le classi più elevate.
Molti nobili cercano
sempre più spesso
l'appoggio di Roma e
talvolta l'ottengono,
esercitando diritti
proporzionati alle
proprie finanze; non
manca nemmeno un console
etrusco, Volumnio Flamma
nel 307 a C. Il censore
Appio Claudio Ceco si fa
aiutare dagli Etruschi a
scavare il primo
acquedotto pubblico
della città noto come "aqua
Appia", fa costruire una
strada, che da lui
prenderà appunto il nome
di via Appia, per unire
Roma a Capua, città
etrusca che a
quell'epoca costituiva
un po' la capitale del
Meridione e chiama un
etrusco, Cn. Flavio a
redigere un nuovo
calendario, distinguendo
bene i giorni fasti, in
cui s'esercitava
l'attività giuridica, da
quelli nefasti, in cui
era meglio starsene in
casa. La complicata
nozione di sacro come
centro di potere dalla
pericolosa gestione è
del tutto sconosciuto ai
romani, che preferiscono
la più semplice
equazione:
sacro=sfortunato, la
distinzione tra giorno
feriale, in cui si può
amministrare la
giustizia e festivo, in
cui stare in casa
propria trae appunto
origine da quest'usanza.
Quando, alla fine del IV
sec. a C. si permette
agli "humiles"
d'iscriversi alle tribù
cittadine un nutrito
gruppo d'intellettuali
etruschi chiede d'essere
accolto a Roma, dove
presumibilmente si
guadagneranno da vivere
come precettori o
aruspici privati. Non
tutti però si rassegnano
così facilmente: negli
affreschi della tomba
Vulci, visibili per la
prima volta nella mostra
di palazzo Grassi, è
rappresentata
l'uccisione da parte
d'Achille dei
prigionieri troiani. È
una garbata satira
politica: se Roma
racconta di discendere
dai Troiani seguaci
d'Enea, gli Etruschi
rivendicano per se' il
ruolo di greci per
eccellenza, nella figura
del loro maggiore eroe.
Si tratta tuttavia d'una
resistenza tutta
intellettuale, nota a
pochi eletti; forse
neppure pubblicizzata,
ma sepolta nel cuore di
una tomba. Ed alle tombe
s'ispirano di fatto le
mostre dedicate agli
Etruschi, con
l'ambizione di
riprodurre in toto il
passato, quasi evocarlo.
Spesso ci aiutano i
colori caldi del cotto e
del ferro naturalmente
ossidato, contro il nero
dei reperti, in gran
parte di bronzo. In
occasione della mostra
del 2000 Palazzo Grassi
aveva allestito
nell'atrio la perfetta
ricostruzione d'una
tomba etrusca, col pozzo
di luce da cui piove
l'acqua ed una vasca
quadrata pronta a
raccoglierla. Gli
Etruschi erano
incineratori, ma le urne
erano sistemate entro
sepolcri sempre più
confortevoli, che
riproducevano tutte le
comodità della vita
domestica e dunque sono
un po' il simbolo della
loro civiltà, oltre ad
essere la nostra fonte
più certa
d'informazioni. Posto
d'onore era riservato ad
una chimera rinvenuta
nel 1553, che ha avuto
l'alto onore d'essere
restaurata dal Cellini:
il muso dell'animale è
un po' stilizzato, ma il
corpo è agile e
scattante, pare vivo e
certo appartiene al
periodo naturalista.
Come quasi tutte le
statue etrusche è fusa
in bronzo, ormai
annerito dal tempo, in
uno stampo d'argilla e
sulla zampa reca la
firma dell'artista o del
committente. La chimera
ed il leone, in fondo
molto simili, erano
amati sia dagli antichi
etruschi che dai toscani
del rinascimento, che vi
vedevano un simbolo
degno di competere con
l'aquila di Roma. Infine
ecco "l'ombra della
sera" statuina sottile,
stilizzatissima, ma con
v Con
la caduta di Veio invece
di festeggiare una
vittoria ci si trovò
sull'orlo della
catastrofe, perché ci fu
l'invasione gallica.
Qualcuno disse che la
sventura fu attirata
sulla città dal
vincitore, Camillo, che
celebrò il proprio
trionfo con cavalli
bianchi, privilegio di
Giove. Per la sua
empietà fu punito con
l'esilio, ma
naturalmente i Galli non
si fermarono. Anche per
quest'avvenimento
disponiamo ormai di due
fonti: Livio e
l'annalistica greca, con
un leggero scarto di
date, il primo la fa
risalire al 390, mentre
i Greci la collocano nel
386 a. C. entrambi
concordano invece sul
giorno: 18 luglio, che
da allora fu
ufficialmente dichiarato
giorno nefasto. Gli
storici, sostanzialmente
contrari ai Fabi, non
hanno esitato a parlar
di tradimento,
soprattutto per quanto
riguarda la presa di
Chiusi. L'ipotesi non è
incredibile. Le guerre
erano ancora un fatto
del tutto privato, come
suggeriscono gli "elmi
firmati" ritrovati un
po' ovunque ed è
impensabile che un
semplice esercito di
cittadini, per quanto
coraggioso, potesse aver
ragione sui "signori
della guerra" che da tre
secoli ormai dominavano
la penisola; non è
escluso che qualcuno
avesse reclutato milizie
celtiche e poi non
potendo pagarle, abbia
dovuto cedere qualche
territorio al
saccheggio. Anche in
quest'occasione infatti
non si può assolutamente
parlare d'invasioni
nell'accezione rovinosa
d'un tempo. I Galli
erano semplicemente a
caccia di bottino e fu
relativamente facile per
Roma mettere in salvo
gli oggetti sacri e le
Vestali, che L. Albinio
condusse in una città
etrusca alleata: Caere.
Per il buon esito della
spedizione, la moglie d'Albinio
votò nel 375 a. C. un
tempio all'ormai romana
Juno Lucina. Si trattava
però d'una salvezza
relativa, in città la
strenua resistenza dei
giovani romani sul
Campidoglio meritò
addirittura l'attenzione
d'Aristotele: per la
prima volta il pericolo
rappresentato dai
Barbari si presentò al
mondo mediterraneo in
tutto il suo peso. In
quegli stessi giorni,
nel 388 a. C. cade
Melpum e finisce per
sempre il dominio
etrusco in Val Padana,
che da questo momento
diventerà "Gallia
Cisalpina"; solo le
valli dei Reti, restando
appunto isolate,
conserveranno un pallido
riflesso della cultura
etrusca. A differenza di
Roma, che cercherà al
più presto di respingere
l'invasore, la Val
Padana si mostra
soddisfatta della nuova
sistemazione. Più tardi,
in epoca imperiale,
Milano sosterrà appunto
d'essere stata fondata
dai Galli, tanto che
alcuni storici
suggeriscono che Melpum
sorgesse nei dintorni
della Melzo attuale. In
realtà è molto strano
immaginare questi
nomadi, scesi dalle Alpi
per arricchirsi, che
perdono tempo a radere
al suolo una città già
fiorente per poi
fondarne una nuova un
po' più in là. Più
semplice pensare invece
che Milano, con le
caratteristiche mura ed
il "pomerium" fiorito di
biancospino, come
racconterà più tardi
Bovesin della Riva, sia
di fondazione etrusca ed
i Galli, trovando una
buon'accoglienza,
abbiano deciso di farne
una loro sede stabile.
Dall'altra parte delle
Alpi non s'usava affatto
vivere in città. Al
massimo si circondava
d'un muraglione
difensivo qualche
villaggio
particolarmente esposto
agli assalti del nemico!
Tra l'altro proprio
dall'incontro tra
quest'usanza e l'antico
pomerium nasceranno, nel
III sec. a. C. le mura
cittadine come furono
concepite in seguito. La
favola della fondazione
di Milano tuttavia
contiene un fondo di
verità: nessuno più è
fiero delle origini
etrusche! Roma
riconoscerà a Caere una
posizione d'alleata, ma
questo non le impedirà
d'assoggettare ad una ad
una tutte le altre città
della Toscana. Inizia
così il lungo tramonto
di quella che era stata
la più gran potenza
della penisola,
l'anticipatrice della
stessa società romana.
Che cosa si rimprovera
agli Etruschi? La colpa
più grave del mondo:
aver perso la guerra! Le
città fondate col rito
etrusco son state messe
a ferro e fuoco, ne' più
ne' meno delle altre.
L'Etruria è devastata
dalle rivolte di schiavi
ed i liberti prendono
con la forza il potere
nei municipi di Volsini
ed Enarea. Le
sacerdotesse che
giravano tranquillamente
per le strade, coi loro
vistosi abiti tinti di
porpora e d'indaco han
subito violenza, senza
che i famosi auguri
riuscissero a prevenire,
ne' ad evitare la
catastrofe! A che
servono dunque tanti
complicati riti? E Roma,
che pure doveva tanto
alla cultura etrusca, la
ridusse ad un semplice
accumulo di
superstizioni. Con la
cacciata del Superbo e
la guerra a Porsenna,
gli Etruschi passarono
di moda e gli annalisti
non parlarono più di
prodigi, ma di
superstizioni, anche se
gli aruspici etruschi
furono ancora consultati
a lungo per la vita
privata. Per i pericoli
che minacciano lo stato
si consultano invece i
Libri Sibillini. Dionigi
d'Alicarnasso (IV, 62) e
Lattanzio (De
Istitutionis I, 6)
raccontano che una
misteriosa donna
straniera e vecchissima
ne propose l'acquisto a
Tarquinio il Superbo per
una somma spropositata.
Al suo rifiuto ne bruciò
progressivamente, con
l'aiuto delle sue arti
magiche, almeno tre,
continuando a chiedere
però sempre la stessa
somma, finché alcuni
auguri presenti
convinsero il re ad
acquistare ciò che
restava. I preziosi
testi furono nascosti
nei sotterranei del
tempio capitolino, dove
tuttavia bruciarono nel
83 a.C. La donna
misteriosa scomparve per
sempre; Lattanzio
suggerisce la
possibilità che si
trattasse della Sibilla
Cumana. In realtà
all'epoca la Sibilla era
consultata direttamente
dagli interessati e lo
stesso accadeva per le
sacerdotesse greche. Gli
Etruschi invece avevano
raccolto il proprio
sapere in numerosi testi
sacri: libri "fulgurales"
per l'interpretazione
dei fulmini, "rituales"
con le prescrizioni
necessarie per celebrare
i vari riti, "acheruntici"
con tutto ciò che
riguardava l'oltretomba.
È probabile che
Tarquinio il Superbo,
figlio e nipote
disacerdotesse, non
avesse certo bisogno di
vecchiette sconosciute
che gli proponessero
testi sacri... la
leggenda fu
evidentemente inventata
più tardi per
giustificare la presenza
dei testi etruschi nel
tempio e soprattutto la
necessità di continuare
a consultarli, anche
dopo la cacciata di
Tarquinio... che tra
l'altro si rifugiò
appunto a Cuma. Tutta la
storia appare inventata
per dare ai testi, senza
dubbio etruschi, una
patente esotica,
ellenistica. I tempi
s'erano fatti duri, non
c'era tempo per un
cerimoniale tanto
complesso, bisognava
avere il coraggio di far
delle scelte precise. La
tecnica divinatoria fu
rigidamente
disciplinata: si ridusse
il numero dei presagi
d'accogliere,
introducendo invece la
possibilità di
"suggerire" qualche
nuovo elemento,
semplicemente
nominandolo, quando la
divinità consultata
restava muta troppo a
lungo. Si limitò
drasticamente lo spazio
sacro al chiuso dei
templi ed alle loro
immediate adiacenze e si
considerarono
significativi solo gli
animali sacri allevati
in cattività, tanto più
facili da controllare!
La donna continuava ad
essere rispettata come
moglie e madre... purché
se ne stesse in casa sua
o nel tempio, come le
Vestali. I Greci avevano
operato da tempo questa
sana restrizione,
distinguendo bene le
madri di famiglia, che
vivevano nel gineceo,
dalle altre, le
cortigiane.
Significativo è il fatto
che in Italia la
prostituzione sacra
s'esercitasse nei templi
di Uni, nel cuore della
città, mentre in Grecia
nei giardini d'Afrodite,
strategicamente
costruiti accanto al
porto. Perché
complicarsi la vita?
Roma fa di più. Nega
proprio la sacralità
della cosa. Perché
mentire? Si tratta d'un
semplice mercato ed è
del tutto evidente che
la prostituta non può
più tornare ad essere
una madre di famiglia!
Può darsi che in origine
fossero solo norme di
guerra, senza
l'intenzionalità che vi
ha connesso la critica
femminista. Non
dimentichiamo che i
pirati infestavano le
coste e le città
dell'entroterra erano
tutte in guerra fra loro
per un motivo o per
l'altro. Tuttavia
chiudere una donna in
casa in un'epoca in cui
l'unico mezzo di
sostentamento lecito per
una famiglia era
l'amministrazione dei
beni fondiari, spesso
dotali, vuol dire
riconoscere lo "status"
di donna onesta soltanto
a chi è provvista di
mezzi! Per questo la
critica moderna fa
sempre più fatica a
credere che la cacciata
di Tarquinio avesse come
motore la difesa
dell'onore di Lucrezia!
Se anche stupro c'è
stato, certo la ragion
di stato ha
abbondantemente
strumentalizzato un
argomento che in altre
circostanze si sarebbe
tranquillamente
consumato in silenzio,
come tante tragedie
domestiche. In uno stato
che non poteva proibire
l'aborto, ma lo
condannava sempre più
apertamente, l'unica
soluzione possibile per
le famiglie non più
ricche era ricorrere
sempre più spesso
all'esposizione dei
neonati, soprattutto di
sesso femminile,
alimentando il fiorente
mercato degli schiavi.
Che accadeva intanto in
Toscana? Pare difficile
crederlo, ma tutto
continuava come prima.
Meglio di prima verrebbe
da pensare, vedendo i
reperti artistici degli
ultimi secoli avanti
Cristo, senza dubbio i
migliori, quando
affreschi e pitture
assorbono completamente
i modi del naturalismo
romano ed i corpi, un
tempo stilizzati,
s'animano di vita reale.
Gli oggetti più pregiati
appartengono a questo
periodo, che ci
attenderemmo di
decadenza. Poiché non è
mai esistita una nazione
etrusca, ma singole
città dal diverso
destino politico, pare
non esista neppure una
coscienza della
sconfitta subita.
Durante l'assedio di
Troilum, città oggi
sconosciuta, il console
Carvilio ebbe cura di
far fuggire, dietro al
pagamento di un
riscatto, tutti i
notabili della città
prima di far capitolare
la plebe. Anche se non
sempre ci sono
testimonianze così
precise è probabile che
lo statuto di città
federate proposto a
tutte le città toscane
prevedesse un
trattamento diverso per
le classi più elevate.
Molti nobili cercano
sempre più spesso
l'appoggio di Roma e
talvolta l'ottengono,
esercitando diritti
proporzionati alle
proprie finanze; non
manca nemmeno un console
etrusco, Volumnio Flamma
nel 307 a C. Il censore
Appio Claudio Ceco si fa
aiutare dagli Etruschi a
scavare il primo
acquedotto pubblico
della città noto come "aqua
Appia", fa costruire una
strada, che da lui
prenderà appunto il nome
di via Appia, per unire
Roma a Capua, città
etrusca che a
quell'epoca costituiva
un po' la capitale del
Meridione e chiama un
etrusco, Cn. Flavio a
redigere un nuovo
calendario, distinguendo
bene i giorni fasti, in
cui s'esercitava
l'attività giuridica, da
quelli nefasti, in cui
era meglio starsene in
casa. La complicata
nozione di sacro come
centro di potere dalla
pericolosa gestione è
del tutto sconosciuto ai
romani, che preferiscono
la più semplice
equazione:
sacro=sfortunato, la
distinzione tra giorno
feriale, in cui si può
amministrare la
giustizia e festivo, in
cui stare in casa
propria trae appunto
origine da quest'usanza.
Quando, alla fine del IV
sec. a C. si permette
agli "humiles"
d'iscriversi alle tribù
cittadine un nutrito
gruppo d'intellettuali
etruschi chiede d'essere
accolto a Roma, dove
presumibilmente si
guadagneranno da vivere
come precettori o
aruspici privati. Non
tutti però si rassegnano
così facilmente: negli
affreschi della tomba
Vulci, visibili per la
prima volta nella mostra
di palazzo Grassi, è
rappresentata
l'uccisione da parte
d'Achille dei
prigionieri troiani. È
una garbata satira
politica: se Roma
racconta di discendere
dai Troiani seguaci
d'Enea, gli Etruschi
rivendicano per se' il
ruolo di greci per
eccellenza, nella figura
del loro maggiore eroe.
Si tratta tuttavia d'una
resistenza tutta
intellettuale, nota a
pochi eletti; forse
neppure pubblicizzata,
ma sepolta nel cuore di
una tomba. Ed alle tombe
s'ispirano di fatto le
mostre dedicate agli
Etruschi, con
l'ambizione di
riprodurre in toto il
passato, quasi evocarlo.
Spesso ci aiutano i
colori caldi del cotto e
del ferro naturalmente
ossidato, contro il nero
dei reperti, in gran
parte di bronzo. In
occasione della mostra
del 2000 Palazzo Grassi
aveva allestito
nell'atrio la perfetta
ricostruzione d'una
tomba etrusca, col pozzo
di luce da cui piove
l'acqua ed una vasca
quadrata pronta a
raccoglierla. Gli
Etruschi erano
incineratori, ma le urne
erano sistemate entro
sepolcri sempre più
confortevoli, che
riproducevano tutte le
comodità della vita
domestica e dunque sono
un po' il simbolo della
loro civiltà, oltre ad
essere la nostra fonte
più certa
d'informazioni. Posto
d'onore era riservato ad
una chimera rinvenuta
nel 1553, che ha avuto
l'alto onore d'essere
restaurata dal Cellini:
il muso dell'animale è
un po' stilizzato, ma il
corpo è agile e
scattante, pare vivo e
certo appartiene al
periodo naturalista.
Come quasi tutte le
statue etrusche è fusa
in bronzo, ormai
annerito dal tempo, in
uno stampo d'argilla e
sulla zampa reca la
firma dell'artista o del
committente. La chimera
ed il leone, in fondo
molto simili, erano
amati sia dagli antichi
etruschi che dai toscani
del rinascimento, che vi
vedevano un simbolo
degno di competere con
l'aquila di Roma. Infine
ecco "l'ombra della
sera" statuina sottile,
stilizzatissima, ma con
v istosi
genitali, investita di
luce radente per
proiettare sul muro una
lunga ombra. Il
manifesto della mostra
rappresenta un'altra
statuetta simile sempre
realizzata in bronzo,
che appartiene ad un
gruppo di quattro
misteriosi giovinetti,
una femmina e tre
maschi. L'oggettistica
etrusca è ricca di
queste figure umane,
talvolta adattate per
reggere candele, brucia
profumi, vasetti, più
spesso isolate: forse si
tratta dei più antichi
Penati o divinità
domestiche, della
storia. Oggi etrusco è
diventato sinonimo
d'aristocratico e
gaudente ed il legame
con la storia romana
pare sempre più assurdo.
La cacciata dei re e
l'inizio dell'era
repubblicana presenta
molte incognite e cui la
storia non ha saputo
rispondere del tutto. Il
carattere pratico e
politicamente impegnato
del nuovo cittadino
romano odia gli
intellettualismi
aristocratici ed accusa
di superstizione ogni
atteggiamento mistico.
Nel 89 a. C. il Latino è
dichiarato lingua
nazionale e condizione
indispensabile per
ottenere la cittadinanza
romana, quell'etrusca
sarà progressivamente
dimenticata. L'arte dei
sepolcri diventa ben
presto l'unico
linguaggio etrusco
conosciuto e Jean-René
Jannot (curatore della
sezione etrusca su:
Storia dell'arte / sotto
la direzione di Albert
Châtelet. - Roma :
Gremese, 1992) accusa
chiaramente i romani
d'aver volontariamente
distrutto ogni loro
testimonianza letteraria
ed archivistica. Non
esistono tuttavia prove.
I Greci, i Galli ed
infine i cristiani
saranno ferocemente
perseguitati, gli
Etruschi sono
semplicemente
dimenticati. Dopo aver
negato il più possibile
l'operato dei loro tre
re, il romano pare
convinto d'aver ormai
ridotto all'impotenza
questo popolo, una volta
tanto scomodo. Di fronte
ad una storia di più di
mille anni narrata solo
dai sepolcri è
impossibile non
ricordare le parole di
Tacito (Vita d'Agricola
30,7), sia pure riferite
alle popolazioni
celtiche: "solitudinem
faciunt, pacem appellant"
aveva detto, ma Tacito,
si sa, era un
aristocratico e quindi
un po' conservatore
anche lui. istosi
genitali, investita di
luce radente per
proiettare sul muro una
lunga ombra. Il
manifesto della mostra
rappresenta un'altra
statuetta simile sempre
realizzata in bronzo,
che appartiene ad un
gruppo di quattro
misteriosi giovinetti,
una femmina e tre
maschi. L'oggettistica
etrusca è ricca di
queste figure umane,
talvolta adattate per
reggere candele, brucia
profumi, vasetti, più
spesso isolate: forse si
tratta dei più antichi
Penati o divinità
domestiche, della
storia. Oggi etrusco è
diventato sinonimo
d'aristocratico e
gaudente ed il legame
con la storia romana
pare sempre più assurdo.
La cacciata dei re e
l'inizio dell'era
repubblicana presenta
molte incognite e cui la
storia non ha saputo
rispondere del tutto. Il
carattere pratico e
politicamente impegnato
del nuovo cittadino
romano odia gli
intellettualismi
aristocratici ed accusa
di superstizione ogni
atteggiamento mistico.
Nel 89 a. C. il Latino è
dichiarato lingua
nazionale e condizione
indispensabile per
ottenere la cittadinanza
romana, quell'etrusca
sarà progressivamente
dimenticata. L'arte dei
sepolcri diventa ben
presto l'unico
linguaggio etrusco
conosciuto e Jean-René
Jannot (curatore della
sezione etrusca su:
Storia dell'arte / sotto
la direzione di Albert
Châtelet. - Roma :
Gremese, 1992) accusa
chiaramente i romani
d'aver volontariamente
distrutto ogni loro
testimonianza letteraria
ed archivistica. Non
esistono tuttavia prove.
I Greci, i Galli ed
infine i cristiani
saranno ferocemente
perseguitati, gli
Etruschi sono
semplicemente
dimenticati. Dopo aver
negato il più possibile
l'operato dei loro tre
re, il romano pare
convinto d'aver ormai
ridotto all'impotenza
questo popolo, una volta
tanto scomodo. Di fronte
ad una storia di più di
mille anni narrata solo
dai sepolcri è
impossibile non
ricordare le parole di
Tacito (Vita d'Agricola
30,7), sia pure riferite
alle popolazioni
celtiche: "solitudinem
faciunt, pacem appellant"
aveva detto, ma Tacito,
si sa, era un
aristocratico e quindi
un po' conservatore
anche lui.
Le immagini inserite
nell'articolo provengono
dalla Mostra sugli
Etruschi di Palazzo
Grassi
www.palazzograssi.it
Visita il sito personale
di
Mary Falco
|