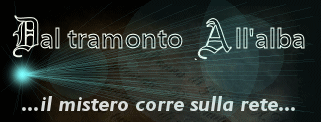|
Il Graal è un simbolo multiforme che racchiude in sé svariati significati. È un tramite per la divinità e rappresenta la molteplicità della potenza di Dio e, in questa veste, fra i suoi vari
attributi, c’è quello di rappresentare il principio creatore e, in genere, tutto quello che è
legato alla vita: guarigione, nascita e rigenerazione. I suoi cantori, durante tutta la storia, gli hanno fatto assumere varie forme (calice, pietra, vassoio), ma le sue proprietà di rigenerazione sono rimaste costanti. La forma principale con cui è conosciuto il Graal è quello di un calice o, più in generale, di un contenitore. Ci soffermeremo, in particolare, su questa forma ed amplieremo il nostro campo di indagine.
 Se esaminiamo il geroglifico egizio rappresentante la donna, vedremo la “presenza” di un pozzo d’acqua. La donna, quindi, che è sorgente di vita, è legata all’acqua, che, oltre ad essere la sorgente di vita per eccellenza, è anche associabile al liquido amniotico: il pozzo d’acqua come grembo materno, insomma. Nell’antico Egitto l’acqua assumeva un significato particolare: le capacità agricole dei territori dell’antico Regno dipendevano dalla regolarità delle piene del Nilo. Questo non avveniva soltanto in Egitto, ma anche presso moltissime altre civiltà: il Nilo per gli egiziani, il Tevere per i Romani, il fiume Giallo per i Cinesi, il Tigri e l’Eufrate per i Babilonesi, gli Assiri ed i Caldei, l’Indo per le civiltà indiane. Nell’antica Mesopotamia una divinità dell’oltretomba chiamata Enki, riempiva di acqua le vasche dei primi templi. Poi semidei in forma di pesce la donavano agli uomini. I fedeli persiani la raccoglievano in anfore e versavano libagioni in coppe approntate dinanzi agli altari. In queste antiche cerimonie religiose, la vasca e il bacile, l’anfora e la coppa rappresentavano la creazione della vita. Se esaminiamo il geroglifico egizio rappresentante la donna, vedremo la “presenza” di un pozzo d’acqua. La donna, quindi, che è sorgente di vita, è legata all’acqua, che, oltre ad essere la sorgente di vita per eccellenza, è anche associabile al liquido amniotico: il pozzo d’acqua come grembo materno, insomma. Nell’antico Egitto l’acqua assumeva un significato particolare: le capacità agricole dei territori dell’antico Regno dipendevano dalla regolarità delle piene del Nilo. Questo non avveniva soltanto in Egitto, ma anche presso moltissime altre civiltà: il Nilo per gli egiziani, il Tevere per i Romani, il fiume Giallo per i Cinesi, il Tigri e l’Eufrate per i Babilonesi, gli Assiri ed i Caldei, l’Indo per le civiltà indiane. Nell’antica Mesopotamia una divinità dell’oltretomba chiamata Enki, riempiva di acqua le vasche dei primi templi. Poi semidei in forma di pesce la donavano agli uomini. I fedeli persiani la raccoglievano in anfore e versavano libagioni in coppe approntate dinanzi agli altari. In queste antiche cerimonie religiose, la vasca e il bacile, l’anfora e la coppa rappresentavano la creazione della vita.
Il Graal e la sua leggenda ha memoria di questi antichi miti. Forse un legame diretto non esiste, ma questi simboli sono universali e portano con sé memoria degli antichi significati. La potenza del simbolo è quella di rappresentare significati universali a tutti gli uomini e di passare indenne attraverso le generazioni umane assumendo nuovi significati pur conservando gli antichi. Questa simbologia connessa all’origine della vita è indubbiamente legata alla donna e alla sua qualità di generatrice di vita. Il Graal contiene questa simbologia femminile, perché è un dispensatore di vita, come abbiamo visto.
In alcune altre leggende, il Graal è anche legato alla Lancia sanguinante con cui fu trafitto Cristo Crocifisso. Il sangue di Gesù, simbolo di vita (ed anche di divinità, in questo caso) cola nel Calice, mentre la lancia è simbolo maschile per eccellenza, in quanto richiama il fallo. Il Calice, la donna; la lancia, l’uomo: tutti questi elementi richiamano alla vita e rappresentano l’atto creatore di Dio. Quale
migliore rappresentazione della potenza creatrice divina, del mistero della generazione di una vita dall’unione di un uomo e di una donna? E, di fatto, in passato quale altro simbolo si poteva utilizzare? Più tardi lo sviluppo della ceramica portò l’immagine di un Dio vasaio. Già nell’antico Egitto, per esempio, fu adottato il simbolo del vaso per significare il verbo creare.
Anche il Dio cristiano che crea l’uomo dal fango riprende quella di un dio vasaio. Più tardi nel Medioevo Dio prenderà il compasso, per creare. Il riferimento è
all’architettur a che allora sviluppava imponenti opere. Il
Graal, essendo un contenitore, possiede anche quest’immagine del vaso come simbolo della creazione divina. Il Graal rappresenta il tutto, perciò racchiude in sé il principio femminile e maschile, a volte reso più esplicito dalla presenza della Sacra lancia, simbolo maschile e della guerra. Il
Graal, quindi, assume valore di dispensatore di vita e distruttore di nemici. a che allora sviluppava imponenti opere. Il
Graal, essendo un contenitore, possiede anche quest’immagine del vaso come simbolo della creazione divina. Il Graal rappresenta il tutto, perciò racchiude in sé il principio femminile e maschile, a volte reso più esplicito dalla presenza della Sacra lancia, simbolo maschile e della guerra. Il
Graal, quindi, assume valore di dispensatore di vita e distruttore di nemici.
Nella tradizione cristiana un collegamento fra la donna e un contenitore esiste nella Litania
Lauretana, in cui la Vergine Maria viene descritta come “Vas
sprirituale, Vas onorabile, Vas insigne devotionis”, ovvero “Vaso spirituale, Vaso dell’onore, Vaso pregiato di devozione”. La Vergine è descritta come un contenitore, il “contenitore” per eccellenza perché ha custodito il Figlio di Dio. Un esempio di connessione fra il simbolo del vaso e la donna si ritrova poi nelle decorazioni della chiesa di S. Vitale, a Ravenna, dove la regina Teodora viene accomunata ad un vaso. In entrambe queste rappresentazioni, la metafora è sempre quella della donna come contenitore della vita.
Nel racconto del Re Magagnato è presente l’idea del “re
taumaturgo”. Il suo benessere corrisponde al benessere delle sue
terre e del suo popolo; al contrario, la malattia del re (causata
da una ferita alle gambe, con ovvio riferimento alle capacità
riproduttive impedite) isterilisce le terre. In questo si ritrova
la presenza di una simbologia femminile legata ai culti di
fertilità e al culto della Grande Madre. Solo la domanda di
Perceval può risanare il Re e far rifiorire la terra. Questa
parte della leggenda graaliana ricorda il mito di Kore e Demetra:
Ade, re degli Inferi, con il permesso di Zeus rapisce Kore per
sposarla. Dopo il rapimento di Kore, la madre Demetra va alla sua
ricerca. Fintanto che Demetra non ritroverà la figlia, la terra
non germoglierà più. Una volta ritrovata, la terra tornerà a
rifiorire e la Dea, felice, farà dono agli uomini del grano. Il
dolore di Demetra per la perdita della figlia rende desolata la
terra, così come il dolore per l’impossibilità di muoversi a
causa della ferita alla coscia rende desolata la terra del reame
del Re Pescatore. Kore è donna: torna, riferita al Graal, una
simbologia femminile. Le similitudini tra le due leggende ci sono,
ma sono molte anche le differenze. Da una parte c’è una donna
che cerca; dall’altra, c’è un uomo. L’oggetto di una
ricerca è una donna, una figlia; dall’altra, è un oggetto e
c’è una domanda che permette di guarire il re e la terra. Nel
mito del ratto di Kore la presenza femminile è preponderante e il
fatto si spiega facilmente perché il mito di Kore è più antico
e risale alle prime civiltà stanziali, e quindi agricole. In
epoca antica si pensava che fosse la donna la dispensatrice di
vita e non veniva riconosciuto all’uomo il suo ruolo nell’atto
della procreazione. Questo imponeva un ampio riconoscimento del
ruolo della donna nella società. Dopo la scoperta del ruolo
dell’uomo, si ha avuto un capovolgimento di tale prospettiva: è
l’uomo che porta il principio vitale col proprio seme, la donna
è più passiva. Nel poema del Perceval non a caso l’eroe è un
uomo: è lui che feconda e fa rinascere la terra. Anche in ciò il
riferimento all’attività agricola è evidente: l’uomo col suo
lavoro rende feconda la terra, che da sola non produrrebbe niente;
allo stesso modo è necessario l’intervento maschile affinché
la donna possa procreare. Il Graal rappresenta il principio
femminile che, unito al principio maschile rappresentato da
Perceval, genera la vita.
Trattando di generazione, il
ricordo di antichi culti legati alla Grande Madre è evidente. La
simbologia femminile del Graal è piuttosto forte a scapito di
quella maschile, nonostante il tempo trascorso e l’avvento del
cristianesimo e del Dio Padre. Nel corso del tempo sono stati
fatti vari tentativi di riportare le leggende graaliane
all’ortodossia cristiana: un esempio è dato dal poema
Perlesvaus, di autore anonimo ma che si suppone legato ai
cistercensi. Il Graal continua a conservare legami con un passato
non cristiano.
|