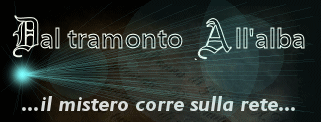|
|
 |
| |
|
Piero della
Francesca a San Salvador e oltre |
|
a cura di
Gaetano Barbella |
|
 |
|
Illustrazione 1:
Ritratto di Piero della Francesca, incisione tratta dalle “Vite”
del Vasari. Nacque a Borgo San Sepolcro attorno al 1416 da una
famiglia di mercanti. Coltivò un vivo interesse per le scienze
matematiche per tutta la sua vita, ma che dovette conciliare con
l'incisiva vocazione artistica. Negli anni della vecchiaia
divenne cieco. La sua morte coincide con la scoperta
dell'America, avvenuta il 12 ottobre 1492.
|
|
|
|
12 ottobre che va... 11
settembre che viene |
|
Non ci si
aspetta per una critica d'arte l'esposizione di una questione
tradotta in versi, come si vedrà di seguito, ne convengo, ma si
tratta, appunto, dell'«Arte» e mi è venuto in mente di fare così
per Piero della Francesca, un artista speciale che deve aver
amato l'«Arte» come non mai, al punto da indurmi a come
anzidetto. Non si può non intravedere la poesia nell'immagine
della sua Madonna del Parto, e il patos che vi trapela adombra
un altro grande amore che Piero ha voluto porre in risalto come
un pari valore. È la Matematica tradotta all' essenzialità che è
un fatto assolutamente epidermico nella sua pittura.
La domanda che si pone, allora, è che cosa implica profondamente
il concetto dell' essenzialità riconosciuto in Piero della
Francesca se non un' adombrata struttura geometrica che, per
altro, ogni artista rinascimentale non si ritraeva dal concepire
in anteprima all' insegna della Divina Proporzione, per dar
luogo alla sua opera? Da notare però che nel caso di Piero è
ancora più marcata questa necessità, al punto da “obbligarlo”,
quasi, ad evidenziarne il segno, ma con estremo rispetto e
armonia delle forme.
Ed è questo segno che intendo ricercare, iniziando con il
resoconto critico in versi (per quel che ha potuto un «omo sanza
lettere» in me) come annunciato, un mio modo per entrare nel
cuore delle cose di Piero Della Francesca che si sono presentate
ai miei occhi. Insomma questo mio scritto parla di Piero e non
tanto dei perchè epidermici della sua opera artistica.
Sorprenderà a dismisura questa prassi fuori dai canoni per
parlare d'arte, ma ciò che intendo mostrare è diverso dalle
tante esposizioni fatte da critici accreditati che hanno
spiegato compiutamente l'opera di Piero in stretta aderenza con
la realtà storica.
Per esempio, cito la seducente tesi, sulla Flagellazione di
Piero (illustrazione 2), edotta da Silvia Rochey, docente di
Civiltà bizantina all'Università di Siena, col suo saggio «L'enigma
di Piero». Qui entrano in ballo personaggi storici del tempo
dell'autore a far da protagonisti per dare un senso al quadro
suddetto. È un tutto che si concentra su una tragedia epocale,
quella del fosco 11 settembre 1453, la fine dell'impero di
Bisanzio con la caduta di Costantinopoli nelle mani dei turchi. |
|
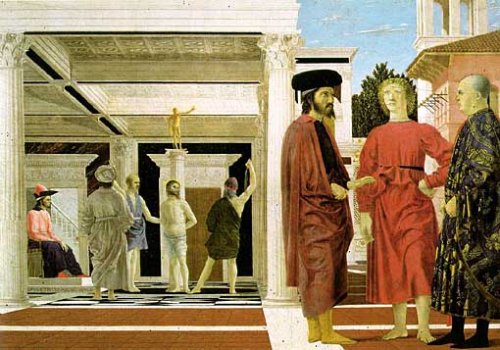 |
|
Illustrazione 2:
Piero della Francesca: Flagellazione. Appare evidente che la
struttura pittorica si ispira alla concezione della Sezione
Aurea. Infatti se si indicano con A e B, le mezzerie delle basi
delle due colonne di primo piano del riquadro della
flagellazione di Gesù, e C, l'asse della colonna cui egli è
legato, nel punto della congiungente A con B, la distanza AC è
proporzionata secondo il valore della Sezione Aurea in rapporto
alla distanza AB. Nella la figura seguente si potrà vedere come
si ottiene il valore della Sezione Aurea secondo il procedimento
grafico1. |
|
|
Il quadro della Flagellazione, così
come è posto dalla Rochey, doveva costituire una sorta di
stendardo di una crociata per salvare Bisanzio ancor prima della
sua burrascosa caduta, secondo le intenzioni politiche del
momento, ma che poi abortì, come risulta dai fatti che poi
sopraggiunsero.
La Flagellazione, attraverso tutti personaggi storici “radunati”
nel suo saggio dalla Rochey, si intona coerentemente con una
scritta che sembra risultasse posta su di essa dall'autore, ma
che malaugaratamente fu cancellata in fase di restauro. Si
tratta di un' espressione della liturgia del Venerdì Santo, «Convenerunt
un unum», che vuol dire «Insieme si sono radunati i principi
contro il Signore e l'unto del Signore».
Non è a caso questa parentesi critica della professoressa Rockey,
poiché lo scritto che seguirà è come se fosse un ideale
compasso, nelle mani di Piero, e di altri due dei quali si
capirà chi sono, tutti presi secondo le personali inclinazioni
con uno dei due puntali fra le mani e l'altro proteso in una
data, 12 ottobre 1492, quasi che indicasse qualcosa di più
profondo che da essa è derivata. |
|
 |
|
Illustrazione 3:
«Una delle prime carte geografiche che comprende i territori del
nuovo mondo. È raffigurata una parte dell'America meridionale.
La scoperta dell'America dilata l'orizzonte non solo geografico,
ma anche fisico e psicologico dell'uomo. Che la morte di Piero
coincida con il tramonto delle antiche certezze ha un valore
simbolico preciso: l'artista si colloca non solo idealmente, ma
anche storicamente a conclusione di un'epoca, quella medievale,
che accettava i limiti imposti da un mondo chiuso entro un
cerchio perfettamente definito e cercava di sondarne i segreti
studiando le leggi che lo governavano» (Tratto dal libretto
della serie Art Book, «Piero della Francesco», edizione Leonardo
Arte).
|
|
|
|
Non si può negare
che questa data è più che storica per le cose del pianeta terra
e riflettendo sull'altra data, quella dell'11 settembre della
caduta dell'impero bizantino, stigmatizzato dalla Flagellazione
di Piero della Francesca, viene da pensare ad un serio proposito
da parte degli organizzatori dell'attentato, quelli di Al Qaeda,
del 2001 alle Torri Gemelle di New York ed al Pentagono di
Washington, di voler emulare l'antica caduta del mondo cristiano
d'Oriente, ed ora rivolto a scardinare quello d'Occidente
colpendolo nelle sue roccaforti, proprio nello stesso 11
settembre di antica memoria. Di qui lo spunto da parte mia di
legare queste cose ad una matematica sconosciuta dei “numeri
gemelli” e del “pentagramma”, di cui parlo nel capitolo
conclusivo di questo scritto. |
|
|
|
A San Salvador |
A San Salvador
Dov'è la gemma dei “due”
del matematico e artista
di Pietro da Borgo?
Forse in quel rombicubottaedro
dell' amico fra' Pacioli? (illustrazione 4)
Lo corrucciò una luce “fuor di via”
2
che fiducioso inseguì con amore.
Labbra carnose, ma greve d' intorno,
quelle del Profeta in lui. (illustrazione 5)
Occhi che non videro,
se non per dipinger l' amor sacrificale,
e un Sepolcro Santo per suggello.
E quello matematico?
Fu un pari amore da conciliare,
una seconda croce di un sol compasso.
Egli l'immaginò, per “imitare le cose vere”:
"dimostrazione di superfici e di corpi".
3a
Ma, ahimè! non ne vide il “vero”, legato al tempo.
E dove l'enigma che tutti cercano di Pietro?
Il suo tempo venne e fu un istante immemore:
un “DVX”4
anche lui per due
destini all'unisono.
“Numeri”, anch'essi, che l' artista in lui cercava:
raggi delle tenebre di uno scenario per una “proiezione”.
3b
E qual'era il numero fatidico?
Una data, un attimo nel tempo,
12 ottobre 1492.5
Qui si chiude il sipario di Pietro da Borgo,
per aprirsene un altro a lui ignoto:
altra scena di un mondo nuovo (illustrazione 3)
per il suo evangelo e tante altre croci.
Resta ancora da sapere, di Pietro, sulla “sezione”,3c
il modo suo di rappresentare il piano architettonico.
Ma il “senso delle cose” del moderno Feynman,
il Nobel dell'“abbrivio”, or s'appanna.6
Domanda lui bramoso: dov' è l' “idea diversa” che vale?
Certo, non giova agli artisti, anche matematici,
trascurar la Sezion d'Oro, tutti lo sanno.
Forse è qui l'“idea diversa” che conduce alla gemma,
quella dei “due” di Pietro da Borgo?
Oggi nasce un'altra storia,
forse il seguito sui “due”, ora allo scoperto.
Ma i lor vestiti non sono fulgidi,
oggi son “d'omo sanza lettere”, ma
anche “sanza vera scienza”.
Se quel dì era il tempo che parlava di morte,
oggi è quella Sezione Aurea a dir la sua,
ma di vita che, però, tutti travisano.
E quì, or sale sul palcoscenico
un isolito “geometra” ad esibir conti strani. (illustrazione 6)
Per lui la Sezione Aurea è solo un manto
che adorna una coppia ancor più regale:
due numeri irrazionali assolutamente “gemelli”.
Ma non può esistere nell'irrazionalità
una simile combinazione che,
per vie diverse, per giunta,
procedono di pari passo, affermano gli accademici.
Eppure è così!
Grazie alla Trigonometria, la Sezione Aurea,
ora, è anche una funzione:
è il seno di un “angolo”, anch' esso aureo,
lo stesso che servì per la Grande Piramide.
Di quest'“angolo”, allora,
quale il coseno e la tangente?
Ma i due numeri “gemelli” di prima!
Si scopre così che i nostri due campioni,
non senza la Sezione aurea, l'anziano seno a suggello,
sono ovunque si intersecano geometriche curve
che a lor s'addice.
Ma tutto ciò, per l'arte e la scienza,
oggi, è come se non fosse.
Una cecità e un destino:
dunque un voluto inutile “astratto”?
Ma non come quello di Pietro da Borgo!
Eppure, per conoscer l'“astratto”,4b
di cui s'argomenta fra gli eruditi d'oggi,
come lo potè Piero della Francesca,
se non col misterioso “Rebis” in lui,7
quei due “regal numeri” per far la “trinità”?
Or mi sovviene sul quel “seno” aureo,
guarda caso,
anche eccelso da far miracoli.
Che sia lo stesso dell'«Ave Maria»?
«Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù»!
Un Gesù figlio di due “padri”!
Dove potrà averlo adagiato
il geometra da Borgo?
Forse al riparo in una comoda
ed ospitale “insenatura”?
«A San Salvador»? |
|
|
|
 |
|
|
|
Illustrazione 4:
Ritratto di Luca Pacioli di autore incerto. A sinistra si vede
sospeso il discusso rombicubottaedro. |
|
|
|
 |
|
|
|
Illustrazione 5:
Piero della Francesca: Profeta (particolare) 1459-64c, Arezzo,
San Francesco. |
|
|
|
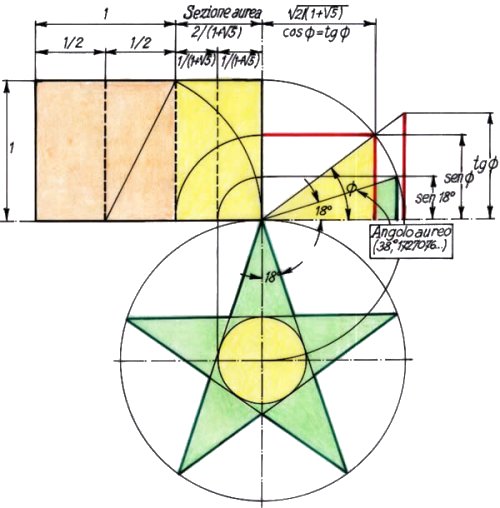 |
|
|
|
Illustrazione 6:
Sviluppo grafico della concezione dell'Angolo Aureo partendo
dalla grafica della tradizionale Sezione Aurea. Di qui
l'identificazione trigonometrica delle tre funzioni, seno,
coseno e tangente. Il coseno e la tangente risultano
perfettamente uguali fra loro. Dal seno si perviene poi allo
sviluppo del pentagramma. Vedasi il mio studio «L'Angolo
Aureo». |
|
|
|
Torri Gemelle e
Pentagono che vanno... “numeri gemelli” e “pentagramma” che
vengono |
|
|
Con la Flagellazione di Piero
(illustrazione 2) comandano i tre pilastri della struttura ove
Gesù viene torturato, come voler legare la santità preparata dal
maestro per i suoi apostoli e di quelli dopo di loro, attraverso
la sofferenza e al limite il martirio. Perciò la Sezione Aurea
(geometricamente la distanza fra il pilastro della flagellazione
e l'altro a destra), è il segno di questa santità che è poi
tradotto nell'iconografia con il caratteristico circolo o
ellisse dell' aureola. È chiaro come il sole che la simbologia
usata da Piero è di un' efficacia estrema per accostare la croce
alla Sezione Aurea con gli imprenscindibili noti rapporti
geometrici: “dimostrazione di superfici e di corpi”.3d
Fin qui nulla che possa far trapelare attraverso la pittura, se
non in modo adombrato (vedi il volto della Madonna del Parto,
illustrazione 7, «percorso da sottili asimmetrie e da una
vibrazione inquieta che si condensa nello sguardo sfuggente
sotto le palpebre socchiuse: pur nel suo isolamento divino, la
futura madre di Gesù appare conscia del suo stato e dolcemente
assorta nel mistero dell' incarnazione»). |
|
|
|
 |
|
|
|
Illustrazione 7:
Piero della Francesca: Madonna del Parto. Il volto della Madonna
«è percorso da sottili asimmetrie e da una vibrazione inquieta
che si condensa nello sguardo sfuggente sotto le palpebre
socchiuse: pur nel suo isolamento divino, la futura madre di
Gesù appare conscia del suo stato e dolcemente assorta nel
mistero dell'incarnazione» (Tratto dal libretto della serie Art
Book, «Piero della Francesco», edizione Leonardo Arte). |
|
|
Ma non si può evitare di rivisitare
tutte le opere di Piero della Francesca e la sua stessa vita
alla luce delle mie nuove concezione del sorpasso della Sezione
Aurea che ho esemplificato con nell'illustrazione 6.
Però sentite questa mia breve storiella che sintetizza il
suddetto sorpasso della Sezione Aurea giusto in stretta
relazione dell'Arte di cui l'uomo stesso è protagonista.
Ricordate il «pertugio» infero dantesco, uno per ogni attimo
della vita che fugge via? Ecco l' artista che qui si fa strada:
è il matematico del Dna dei numeri di Fibonacci, con la corona
della Sezione Aurea.
Ma si viene a scoprire che il problema della Sezione Aurea non
si esaurisce a ciò che tutti sanno attraverso la nota formuletta
phi = 2/(1+√5), se non fosse per la Trigonometria!
Phi (0.61803...), in trigonometria, corrisponde al seno di un
angolo e insieme a lui ci sono il coseno, la tangente (e
cotangente) che, con nostra meraviglia, risultano uguali fra
loro (gli eterni mascolino e femminino). Però questi “due”, sono
come fissati in una sorta di Nirvana e la vita cesserebbe se non
fosse per il lucifero della perfetta circolarità, pi greco, che
trigonometricamente tradotto in seno (0,61766...) è quasi
accanto a loro.
Succede che nel passaggio fatale la coscienza va in frantumi
che, però, si salva, anche se disunita, celandosi nei “due
estatici” liberi di varcare la soglia. Ecco com'è che la vita
progredisce (ricordate il racconto omerico di Ulisse e i suoi
compagni che riuscirono a salvarsi abbarbicati alle pecore di
Polifemo!).
Resta un'ultima cosa da approfondire, quel “seno” aureo posto in
relazione all'Ave Maria dello scritto in versi sopra trattato.
Vedo Piero accingersi a dipingere la Madonna del Parto preso dal
farlo “poeticamente” con la sua solita mano di grande artista e
far diventare i suoi tratteggi strumenti melodiosi al punto da
farli udire a chi si dispone ad ammirare il volto della Vergine,
decisamente il polo di convergenza della visione. Ma è in lui
quella sofferenza che trapela come una tempesta da quel volto a
causa della sua matematica che egli vorrebbe che fosse presente.
La croce di questo stato è pesante, ed è tale da disporlo ad
implorare la stessa Vergine in lui di partecipare al sacrificio
da compiersi, così come è disposto nella flagellazione con lo
schema della Sezione Aurea.
È possibile una cosa del genere con la Madonna del Parto? Sì lo
è, e forse Piero della Francesca lo ha posto in atto
magistralmente servendosi del perfetto ovale del volto della
Vergine. Si guardi l'illustrazione 8 ove è rappresentato l'ovale
conforme al volto in questione. Se nella Flagellazione l'unità
corrispondeva alla distanza delle due colonne principali, qui
l'unità corrisponde al tratto AC di congiunzione delle
intersezione degli assi, nell' ordine, minore e maggiore con
l'ovale, l'ellisse per la precisione. |
|
|
|
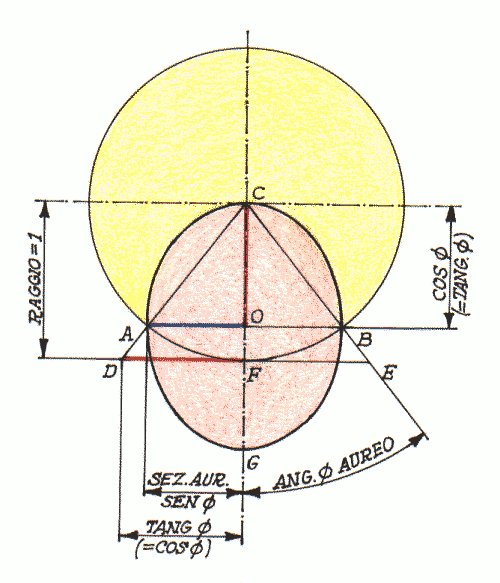 |
|
|
|
Illustrazione 8: Si
tratta dell'analoga geometria dell'angolo aureo riportata nella
figura sopra. Qui si evidenzia la rappresentazione di una
superficie piramidale che è la stessa come modello della
Piramide di Cheope d'Egitto. |
|
|
Il valore della Sezione Aurea non è
altro che il semiasse minore. Il resto della geometria, non era
d' interesse per Piero giacchè nemmeno oggi questo lo è, se non
attraverso le mie concezioni che si rifanno alla trigonometria.
Ora si deve convenire che può essere verosimile quel che ho
detto con gli ultimi rabberciati versi suddetti sul “seno”
dell'“Ave Maria”. Se così è, dove il riparo segreto del “frutto
suo” se non in un radioso ed amabile “cielo”, «presso Dio»?8
Guarda caso - ma quanti! -, anche qui due luoghi che sembrano
diversi ed assai lontani: un adorabile “mento” (con la solita
“fossetta” comune col suo autore) ed un nuovo mondo oltre il
mare delle due colonne d'Ercole, «San Salvador ove approdò il 12
ottobre 1942 con la caravella Santa Maria insieme alle altre sue
“ancelle” di viaggio e con il loro capitano, “Cristoforo
Colombo”. Un gioco di parole per beffare il “drago rosso”
dell'Apocalisse e con lui i saccenti dottori increduli delle
Arti e delle Scienze di tutti i tempi?
Il “cielo” del supposto “riparo” non ha armigeri ma immaginari
“putti” alati che si dilettano col “gioco”,
ma per i riottosi fanno sì che diventi un “giogo”.
(8, illustrazione 9) |
|
|
|
 |
|
|
|
Illustrazione 9: Alessandro Bonvicino
detto il Moretto (1498-1554): particolare «Incoronazione della
Vergine con i Santi Giuseppe, Francesco, Nicola e l'Arcangelo
Michele» del 1534. Un volto trasognato di “donna” fra i “putti”
celesti al riparo del “dragone rosso” dell'Apocalisse? Vedasi il
mio studio «L'Arcangelo
Michele del Moretto». |
|
|
Dunque per finire, dove
rintracciare i “putti” del “DUX” di Piero, se non col magico
“gioco” della sua particolare geometria. E dove gli altri
“putti”, quelli del “DVX” del sommo Poeta Dante col “gioco” dei
“numeri” da lui indicati? Giammai con la ragione degli adulti ma
degli infanti! Si scoprirà che essi son versi che parlano di
certi altri “due” da onorare. (4c)
Leonardo che si definiva «omo sanza lettere» criticava i «trombetti»
della cultura, coloro che a sostegno delle proprie tesi invocano
l'“autorità” del pensiero “consolidato”, esercitando “la memoria
e non l'intelletto”. Le cose “narrano” ed è questo il vero
“Senso delle cose”. Un poliedro complesso, un volto, la grafica
di nuove lettere sono frasi di un discorso che assume un
significato. Come va inteso? “A ciascuno il suo”: non in senso
retributivo e di equità del dare, ma di ricezione.
Il mio scritto è una iniziativa di diffusione della questione
attributiva, ma anche una verifica che trascende lo stato
dell'arte valicandone il termine. Qui si parla dell'Arte con la
quale ogni concezione dell'universo è stata posta in essere.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE |
|
1:
Tratto da:
www.exibart.com.
Luigi Maria Ricciardi, matematico, pone l'accento sulla Divina
Proporzione di Luca Pacioli, la cosiddetta Sezione Aurea «quale
canone di perfezione e grazia sia in architettura, scultura e
pittura, sia nella stessa Natura. Il modo più semplice di
costruirla è dividere un segmento in due parti tali che il
quadrato che ha per lato la parte maggiore abbia area uguale a
quella del rettangolo i cui lati sono rispettivamente l'intero
segmento e la parte minore». Oltre che essere applicata da Piero
nella costruzione della Flagellazione, la sezione aurea è
presente in numerose opere della storia dell'arte a partire
dalle sculture del Partenone, opera di Fidia, passando
attraverso «Lo Sposalizio della Vergine» di Raffaello. Proprio
sui frontoni del Partenone si sofferma anche il regista Pappi
Corsicato che ne traccia l'analogia con la Flagellazione sotto
la comune cifra dell'impersonalità: «Piero fu addirittura
impassibile, come se aspirasse all'impersonalità dell'idea,
piuttosto che all'emozione della rappresentazione».
2:
Omero: Odissea XIII,42.
3a,3b,3c,3d:
Da «Piero della Francesca gran matematico. Meglio di Leonardo»,
www.24sette.it
4,4b,4c:
Il DVX dantesco, «Cinquecento, diece e
cinque» (Pur XXXIII,43). Vedasi il mio studio «Cinquecento,
diece e cinque».
5: Il
giorno della morte di Piero della Francesca e della scoperta
dell'America.
6: Lo
scienziato Richard P. Feynman, Nobel della Fisica, morto nel
1988. Questi nel suo libro «Il senso delle cose», intravede la
natura dello scienziato moderno con le seguenti parole: «Molti
si stupiscono che nel mondo scientifico si dia così poca
importanza al prestigio o alle motivazioni di chi illustra una
certa idea. La si ascolta, e sembra qualcosa che valga la pena
di verificare – nel senso che è un'idea diversa, e non
banalmente in contrasto con qualche risultato precedente –
allora si che diventa divertente. Che importa quanto ha studiato
quel tizio, o perché vuole essere ascoltato. Il questo senso non
ha nessuna differenza da dove vengano le idee. La loro origine
vera è sconosciuta. La chiamano “immaginazione”, “creatività”
(in realtà non sconosciuta, è solo un'altra cosa come
l'“abbrivio”). Stranamente molti non credono che nella scienza
ci sia posto per la fantasia. È una fantasia di un tipo
speciale, diversa da quella dell'artista. Il difficile è cercare
di immaginare qualcosa che a nessuno è mai venuto in mente, che
sia in accordo in ogni dettaglio con quanto già si conosce, ma
sia diverso; e sia inoltre ben definito, e non una vaga
affermazione. Non è niente facile.».
7:
“Rebis” in alchimia è composto salino, cosa doppia, carattere
ermafrodito, maschio e femmina insieme. Unico essere durante la
congiunzione carnale (in senso figurato). Escremento. (dal
«Dizionario di Alchimia e di Chimica Antiquaria» di Gino Testi -
Ediz. Mediterranea Roma).
8:
Apocalisse 12,5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|