|
LA
SURREALTA' DELLA
TOPOGRAFIA TERRESTE
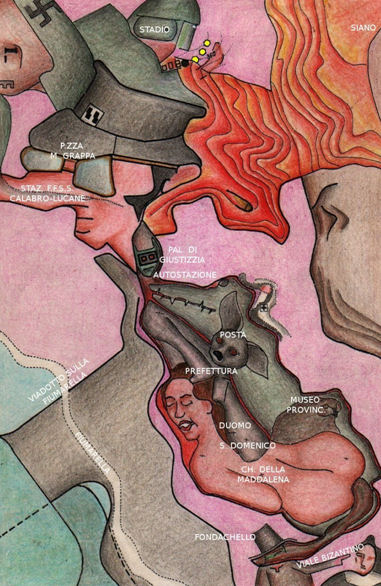 Sembrerà
incredibile e nuovo da
sentirsi ma la terra non
la si conosce
abbastanza, se non
attraverso tutto ciò che
la scienza ha sondato e
studiato a menadito. Ma
non è stato abbastanza
da scoprire di lei, con
sorpresa, miriade di
configurazioni
attraverso la sua
topografia.
Immaginazioni
suggestive, come quelle
dei racconti e delle
favole si potrà dire, ma
non tanto da far sorgere
in alcuni reali
possibilismi di concreti
fondamenti per tenerne
da conto. Altri diranno
sorridendo che è magia,
come quella dei
chiromanti che, al posto
di leggere la mano della
gente, legge la terra
con le tante sue linee
di morte vita e
miracoli. Tuttavia,
scherzi a parte, la
terra vista così
effettivamente dimostra
di essere come viva e,
da mirabile ed
impareggiabile artista,
dipinge immagini di sé
come meglio crede: a
volte allegoricamente,
altre in modo che sembra
reale. E non occorrono
doti magiche per
togliere il velo di Gea,
la terra, per mettere in
mostra la sua
immaginaria surrealtà
imprevedibile. Basta
solo la docile mano di
un giovane studente, una
matita ed una gomma ed
ecco che da una cartina
di un paese – per
esempio – come quelle
inserite nel suddetto
scritto, si presentano
alla vista
rappresentazioni
coerenti, che fanno
pensare. Un matematico
direbbe che è topologia
bella e buona, la
scienza esatta come lui
la definisce. La
topologia
intuitivamente, in
matematica, è lo studio
di quelle proprietà
degli enti geometrici,
le quali non variano
quando questi vengono
sottoposti a una
deformazione continua
cioè, ad una
trasformazione della
figura tale che punti
distinti rimangono
distinti, e punti vicini
cambino in punti vicini.
Ma il termine di
topologia è usato anche
in altri modi: per lo
studio del paesaggio dal
punto di vista
morfologico; in
linguistica per lo
studio relativo alla
collocazione delle
parole nella frase; ed
ancora. Sembra complesso
e astruso ragionare in
topologia, eppure nel
caso delle
configurazioni in
discussione è come un
semplice gioco, simile a
quello per bambini della
Settimana Enigmistica,
“Che cosa apparira?”, o
l’altro, “La pista
cifrata”, solo che qui
occorre immaginare i
puzzle da annerire e le
cifre da seguire. Ecco,
ora immaginate che la
terra veramente presenta
di sé configurazioni che
non si contano – non si
potrà spiegare come –
per dimostrare che essa
vive interagendo a tutte
le attività di
superficie, soprattutto
per opera dell’uomo. Non
è poi tanto fantastica
l’idea che gli uomini
rivestano, in seno alle
configurazioni i
discussione, la funzione
più importante della
terra vista in questo
modo, quella del
cervello. Ragionando in
questa prospettiva si
imparerà così a vedere
che le costruzioni
umane, i fabbricati, le
strade, le grandi vie di
comunicazione e ogni
altra cosa sono forze
che nascono, crescono e
muoiono. E poi, quando
tutto manca per credere
in ciò che ho postulato
sulla presunta surrealtà
terrestre, ebbene non
dispiacerà sentire e
vedere un insolito modo
di fare arte, fuori
dalle numerose
concezioni note. Ed ecco
una spiegazione che si
può accettare sul conto
di un certo paradigma
che vi può attenere e
così impostare un
discorso in merito ed
affermare di conseguenza
se cambia il paradigma
cambia la società.
Giusto anche lo scopo di
tutti i lavori degli
antichi alchimisti che
operano nel mistero. Sembrerà
incredibile e nuovo da
sentirsi ma la terra non
la si conosce
abbastanza, se non
attraverso tutto ciò che
la scienza ha sondato e
studiato a menadito. Ma
non è stato abbastanza
da scoprire di lei, con
sorpresa, miriade di
configurazioni
attraverso la sua
topografia.
Immaginazioni
suggestive, come quelle
dei racconti e delle
favole si potrà dire, ma
non tanto da far sorgere
in alcuni reali
possibilismi di concreti
fondamenti per tenerne
da conto. Altri diranno
sorridendo che è magia,
come quella dei
chiromanti che, al posto
di leggere la mano della
gente, legge la terra
con le tante sue linee
di morte vita e
miracoli. Tuttavia,
scherzi a parte, la
terra vista così
effettivamente dimostra
di essere come viva e,
da mirabile ed
impareggiabile artista,
dipinge immagini di sé
come meglio crede: a
volte allegoricamente,
altre in modo che sembra
reale. E non occorrono
doti magiche per
togliere il velo di Gea,
la terra, per mettere in
mostra la sua
immaginaria surrealtà
imprevedibile. Basta
solo la docile mano di
un giovane studente, una
matita ed una gomma ed
ecco che da una cartina
di un paese – per
esempio – come quelle
inserite nel suddetto
scritto, si presentano
alla vista
rappresentazioni
coerenti, che fanno
pensare. Un matematico
direbbe che è topologia
bella e buona, la
scienza esatta come lui
la definisce. La
topologia
intuitivamente, in
matematica, è lo studio
di quelle proprietà
degli enti geometrici,
le quali non variano
quando questi vengono
sottoposti a una
deformazione continua
cioè, ad una
trasformazione della
figura tale che punti
distinti rimangono
distinti, e punti vicini
cambino in punti vicini.
Ma il termine di
topologia è usato anche
in altri modi: per lo
studio del paesaggio dal
punto di vista
morfologico; in
linguistica per lo
studio relativo alla
collocazione delle
parole nella frase; ed
ancora. Sembra complesso
e astruso ragionare in
topologia, eppure nel
caso delle
configurazioni in
discussione è come un
semplice gioco, simile a
quello per bambini della
Settimana Enigmistica,
“Che cosa apparira?”, o
l’altro, “La pista
cifrata”, solo che qui
occorre immaginare i
puzzle da annerire e le
cifre da seguire. Ecco,
ora immaginate che la
terra veramente presenta
di sé configurazioni che
non si contano – non si
potrà spiegare come –
per dimostrare che essa
vive interagendo a tutte
le attività di
superficie, soprattutto
per opera dell’uomo. Non
è poi tanto fantastica
l’idea che gli uomini
rivestano, in seno alle
configurazioni i
discussione, la funzione
più importante della
terra vista in questo
modo, quella del
cervello. Ragionando in
questa prospettiva si
imparerà così a vedere
che le costruzioni
umane, i fabbricati, le
strade, le grandi vie di
comunicazione e ogni
altra cosa sono forze
che nascono, crescono e
muoiono. E poi, quando
tutto manca per credere
in ciò che ho postulato
sulla presunta surrealtà
terrestre, ebbene non
dispiacerà sentire e
vedere un insolito modo
di fare arte, fuori
dalle numerose
concezioni note. Ed ecco
una spiegazione che si
può accettare sul conto
di un certo paradigma
che vi può attenere e
così impostare un
discorso in merito ed
affermare di conseguenza
se cambia il paradigma
cambia la società.
Giusto anche lo scopo di
tutti i lavori degli
antichi alchimisti che
operano nel mistero.
C’è un filo sottile,
praticamente invisibile,
che lega ogni forma di
cambiamento. Si produce
un vero cambiamento
quando si riesce a
modificare il paradigma
di base che influenza,
controlla e domina lo
sviluppo del pensiero
logico-razionale
finalizzato ad
affrontare i problemi
della vita e
dell’esistenza1.
«Il paradigma svolge un
ruolo allo stesso tempo
sotterraneo e sovrano in
ogni teoria, dottrina o
ideologia. Il paradigma
è inconscio, ma irriga
il pensiero cosciente,
lo controlla e, in
questo senso, è anche
sovracosciente. Il
paradigma istituisce le
relazioni primordiali
che si costituiscono in
azioni, determina i
concetti, domina i
discorsi e le
teorie...». (E. Morin)
GIANGURGOLO NELLA
SURREALTA' MAPPALE DI
CATANZARO
Ho fatto capire come ho
potuto eseguire tanti
disegni traendoli dalle
mappe di centri urbani,
ma anche di aree
geografiche, come stati
e continenti, e che ho
chiamate
surrealtà mappali.
Il disegno che presento
in questo saggio
attraverso l’illustr.
1, è una delle tante
surrealtà mappali,
quella di Catanzaro che
sono stato portato ad
eseguire secondo una mia
immaginazione. In
seguito casualmente mi
sono trovato di fronte
alla maschera della
Calabria,
Giangurgolo
ed ho trasalito nel
trovarvi un’assoluta
aderenza al mio disegno
di Catanzaro in esame.
Naturalmente vi ho
intravisto un
Giangurgolo
dei nostri tempi. A
questo punto mi è
piaciuto approfondire le
riflessioni in questa
ottica e mi è sorto un
dilemma ponendomi queste
due domande:
Giangurgolo, da vecchia
maschera della Calabria,
oggi cosa è, un “porco”
che sfugge alla
giustizia? Ma non può
rappresentare anche un
certo “santo”, che
appena si vede camuffato
da “porco” che migra,
come fu per San
Vitaliano, patrono di
Catanzaro, il quale come
si sa scappò dalla sua
Capua di cui fu
proclamato Vescovo
contro la sua volontà2.
Quei due in alto a
destra, del “fuoco” e
della “Pietra”, della
surrealtà mappale
in esame, forse se lo
chiedono. Ironia della
sorte però, si vede
appena un religioso o
religiosa con l’aureola,
col segno di una croce
di soccorso (la manna di
San Vitaliano, appunto),
che è sotto il loro naso
e non lo vedono. Ma la
spiegazione proviene
proprio dalla sua
storia. A differenza di
quando fu costretto a
indossare abiti
femminili a Capua dove
era vescovo, per essere
svergognato, ora gli
stessi abiti gli servono
per passare inosservato.
Infatti sembra
incertamente anche una
suora.
Qualcosa del genere
avvenne per un altro
santo, san Marco le cui
reliquie, che si
trovavano in terra
islamica ad Alessandria
d’Egitto, furono
avventurosamente
traslate a Venezia
nell’anno 828 da due
leggendari mercanti
veneziani: Buono da
Malamocco e Rustico da
Torcello.
Si tramanda che per
trafugare ai Musulmani
il prezioso corpo
(l’Islam riconosce e
venera a sua volta
Cristo e i Santi), i due
astuti mercanti lo
abbiano nascosto sotto
una partita di carne di
maiale, che passò senza
ispezione la dogana a
causa del noto disgusto
per questa derrata
imposto ai seguaci del
Profeta.
Va ricordato che in quei
tempi (e in parte ancor
oggi) le reliquie erano
un potente aggregatore
sociale; inoltre
attiravano pellegrini e
contribuivano a
innalzare il numero
della popolazione nelle
città, effetto molto
importante per un
urbanesimo agli albori
che stentava ad
affermarsi sulle
popolazioni
prevalentemente rurali.
Ogni reliquia era quindi
bene accetta assieme a
chi la recava e quella
di San Marco lo fu
particolarmente a
Venezia, in quanto
proprio quel Santo,
mentre era in vita,
avrebbe evangelizzato le
genti venete divenendone
Patrono ed emblema sotto
forma di leone alato.
GIANGURGOLO E LA
VISIONE PROFETICA DI
NOSTADAMUS
Può sorprendere capire
che
Giangurgolo,
emblematico personaggio,
che a prima vista
impersona chiaramente il
male, anzi tutti i mali,
sia stato oggetto della
visione profetica, la
più terribile, del
famoso profeta del
Cinquecento, M.
Nostradamus, eppure
sembra di sì. Non si può
negare che la Quartina
X, 10 centra in pieno la
sua descrizione e
conseguenze nefaste.
Eccola:
«Macchia di Merda,
enorme adultera
Grande nemico di tutto
il genere umano
Che sarà malvagio,
d’antenati, zii, né
padri
In ferro, fuoco, acqua,
sanguinario e inumano».
La donna completamente
nuda e l’ambiguo
serpente sono la visione
scandalosa espressa con
il primo verso, e così
il resto della quartina
in questione inquadra il
potere mortale legato al
serpente della
perdizione, a Satana.
Ma se è concepibile
questo scenario
terrificante ai danni
degli abitanti della
Terra, resta il
possibile soccorso di
San Vitaliano sul quale
è stata posta la croce
del male di Satana
allorché era a Capua.
Questa città recava il
segno di enormi “gravi”,
una di queste a causa
degli antichi “Ozi” di
Annibale acerrimo nemico
di Roma3.
Non meraviglia la
pesante predizione
nostradamica se si
riflette sull’analoga
annunciata da San
Giovanni, l’apostolo di
Gesù nell’Apocalisse.
Viene detto che «il
dragone, il serpente
antico – cioè il
diavolo, satana»
– venne incatenato
nell’abisso fino al
compimento dei mille
anni. «Dopo
questi dovrà essere
sciolto per un po’ di
tempo.» (Ap
20, 3).
Dunque non resta che
descrivere la maschera
della Calabria,
Giangurgolo,
tema di questo saggio,
vista come espressione
delle debolezze umane,
delle tentazioni cui è
stata soggetta, cui
molti uomini non furono
capaci di resistere
mortificando il genere
umano, ma anche delle
forze benefiche che
diversi altri uomini
riuscirono a porre come
baluardo al male.
Infatti dalla
descrizione della storia
della maschera
Giangurgolo
che segue vedremo che ci
sono due versioni a
riguardo.
GIANGURGOLO MASCHERA
DELLA CALABRIA
Giangurgolo4
è una maschera calabrese
della Commedia
dell’Arte. Secondo
alcuni studiosi il suo
nome deriverebbe da
Gianni Boccalarga o
Gianni Golapiena,
caratterizzandone così
subito le peculiarità:
persona di molte
chiacchiere, di grande
ingordigia e fame.
L’origine di qu esta
maschera è incerta, ma
le fonti letterarie
sulle rappresentazioni
di Giangurgolo dicono
che essa sarebbe nata a
Napoli. Risale al 1618
la notizia di un attore,
Natale Consalvo, che, a
Napoli, lavorava nelle
vesti di Capitan
Giangurgolo.
Successivamente la
maschera di
Giangurgolo
fu importata a Reggio ed
in Calabria per mettere
in ridicolo le persone
che imitavano i
cavalieri siciliani
“spagnoleggianti”,
infatti intorno alla
metà del XVII secolo
quando la Sicilia fu
data ai Savoia vi fu una
massiccia migrazione di
nobili spagnoli
siciliani verso la città
di Reggio dall’altra
parte dello Stretto, e
la maschera sarebbe
stata dunque adattata a
questi nobili siciliani
decaduti, diventando la
maschera tradizionale
della regione. Godette
subito di grande
considerazione
nell’ambito della
commedia dell’Arte tanto
da essere rappresentata
nei più grandi teatri
italiani al pari delle
maschere oggi
considerate maggiori:
Pulcinella, Arlecchino
ecc. Ha un naso enorme e
una spada altrettanto
smisurata che pende su
un fianco, indossa un
alto cappello a cono, un
corpetto stretto e
soprattutto i pantaloni
a sbuffo a strisce
gialle e rosse,
particolare
significativo che
riproduce i colori
d’Aragona. La maschera
dunque rappresenta uno
scherzo della città
verso i dominatori
aragonesi e spagnoli. Il
nome Giangurgolo
deriverebbe dalle
parole: esta
maschera è incerta, ma
le fonti letterarie
sulle rappresentazioni
di Giangurgolo dicono
che essa sarebbe nata a
Napoli. Risale al 1618
la notizia di un attore,
Natale Consalvo, che, a
Napoli, lavorava nelle
vesti di Capitan
Giangurgolo.
Successivamente la
maschera di
Giangurgolo
fu importata a Reggio ed
in Calabria per mettere
in ridicolo le persone
che imitavano i
cavalieri siciliani
“spagnoleggianti”,
infatti intorno alla
metà del XVII secolo
quando la Sicilia fu
data ai Savoia vi fu una
massiccia migrazione di
nobili spagnoli
siciliani verso la città
di Reggio dall’altra
parte dello Stretto, e
la maschera sarebbe
stata dunque adattata a
questi nobili siciliani
decaduti, diventando la
maschera tradizionale
della regione. Godette
subito di grande
considerazione
nell’ambito della
commedia dell’Arte tanto
da essere rappresentata
nei più grandi teatri
italiani al pari delle
maschere oggi
considerate maggiori:
Pulcinella, Arlecchino
ecc. Ha un naso enorme e
una spada altrettanto
smisurata che pende su
un fianco, indossa un
alto cappello a cono, un
corpetto stretto e
soprattutto i pantaloni
a sbuffo a strisce
gialle e rosse,
particolare
significativo che
riproduce i colori
d’Aragona. La maschera
dunque rappresenta uno
scherzo della città
verso i dominatori
aragonesi e spagnoli. Il
nome Giangurgolo
deriverebbe dalle
parole:
* Gian = Zanni,
un tipico personaggio
della commedia dell’Arte
che presenta diverse
varianti in Italia, una
tra tutte Giangurgolo
appunto. Della parola
Zanni rimane infatti
ancora oggi traccia nel
dialetto calabrese,
nell'uso di espressioni
come “fari u Zannu” o
“fari i Zanni”, che vuol
dire “fare uno scherzo”,
“fare degli scherzi”, o
ancora l’espressione
“Zanniare” che vuol dire
“scherzare” appunto.
Troviamo un altro
riferimento reggino allo
Zanni nella tipica
espressione
“Facc’i’Maccu” (Faccia
di Macco) ancora in uso
in città, che deriva dal
personaggio Maccus, il
servo sciocco della
commedia Plautina, molto
simile al servo sciocco
interpretato da molti
Zanni della Commedia
dell’Arte.
* Gurgolo,
che vuol dire “bocca
larga” o “grande bocca”,
un personaggio ingordo
dotato di appetito
insaziabile, ma
soprattutto inteso in
senso di spacconeria, un
personaggio di molte
parole e di pochi fatti.
Giangurgolo
nacque, secondo la
maggior parte degli
studiosi, per soddisfare
l’esigenza di mettere in
ridicolo, caricaturando,
i dominatori,
considerati “inutili
eroi” bravi soltanto con
le chiacchiere, quei
boriosi dediti alla
gola, arroganti,
millantatori e codardi
che imitavano gli
atteggiamenti di
superiorità e tracotanti
degli ufficiali
spagnoli, irriverenti ed
insolenti, presenti a
quel tempo nel nostro
Meridione.
Giangurgolo
era protagonista sui
palcoscenici dei teatri
sei e settecenteschi
tanto quanto lo era in
strada. Infatti in una
incisione dell'abate
Jean-Claude Richard de
Saint-Non che descrive
“i dintorni di Reggio” è
chiaramente visibile una
scena di commedia, un
pezzo di teatro fatto
per strada dove è
protagonista
Giangurgolo,
uno Zanni con il lungo
cappello e la spada.
Secondo un’altra ipotesi
la maschera sarebbe nata
da una persona realmente
esistita a Catanzaro.
Secondo tale opinione,
dal punto di vista
etimologico
Giangùrgolo
significherebbe “Gianni
l’ingordo”, per la sua
caratteristica
distintiva:
l’ingordigia. La sua
storia inizia nel
convento delle Suore di
Santa Maria della
Stella, dove nacque il
24 giugno 1596. Il nome
deriverebbe da Giovanni,
in onore del Santo del
giorno del suo
ritrovamento. La
leggenda narra che nei
boschi egli cerca di
salvare uno spagnolo
aggredito da briganti,
che non ostante tutto
muore. In segno di
riconoscenza però in
punto di morte nomina
Giovanni suo erede,
consegnandogli, oltre
alle sue ricchezze, una
lettera che contiene il
modo per salvare la
città. Allora Giovanni
tramuta il suo nome in
Alonso Pedro Juan
Gurgolos, in onore dello
spagnolo, ed inizia la
sua personale lotta
contro l’occupazione
spagnola. Giovanni si
organizza con un
carrozzone da teatro col
quale, insieme ad alcuni
suoi amici, propone
spettacoli satirici
incitando il popolo alla
rivolta. Una condanna a
morte lo costringerà a
trasferirsi in Spagna,
ma successivamente,
tornato a Catanzaro,
ritrova l’amico di
teatro Marco, malato di
peste, e per un
abbraccio tra i due la
malattia viene trasmessa
anche a
Giangurgolo
che muore.
IL CARATTERE
- Dai suoi
atteggiamenti, dal suo
modo di parlare,
Giangurgolo
appare come il tipico
signorotto ricco,
gradasso, spaccone,
spavaldo, come colui che
esige rispetto senza
darne in cambio, dalle
persone più umili e
assumendo, di contro,
davanti a chi può
rappresentare un
pericolo, una minaccia,
atteggiamenti di
riverenza e umiltà
rasenti alla
sottomissione ma sempre
ruffiani ed adulatori.
Nell’approccio con le
donne riesce a mettere
da parte i suoi lati
grotteschi facendo
sfoggio di una
erudizione barocca,
artificiosa, finendo
però sempre deriso e
sbeffeggiato soprattutto
a causa del suo aspetto
fisico.
LA FIGURA
-
Giangurgolo,
convenzionalmente, porta
sul volto una maschera
rossa arricchita da una
naso di cartone, sul
capo un cappello a forma
di cono. Indossa un
colletto alla spagnola
arricciato, un corpetto
a righe rosse e gialle,
calzoni sempre rossi e
gialli fin sotto il
ginocchio, calze bianche
o, ancora, rosse e
gialle ed un cinturone
al quale è appesa una
lunga spada che usa
reiteratamente con chi è
più debole ma che resta
puntualmente penzoloni
di fronte a chi potrebbe
suonargliele.
GIANGURGOLO EPOCALE E LA
"BELLE DE JOURE"
“Bella di giorno”, il
famoso film francese di
Luis Buñuel del 1967,
interpretato dalla nota
attrice Caterine
Deneuve, è quanto di più
vicino al tema
Giangurgolo che mi
appresto a descrivere
così come viene
presentato su internet. Secondo me è centrato
l’accostamento di questo
film con la
rappresentazione scenica
relativa all’illustr.
1, la configurazione
che ho immaginato di
Catanzaro. Giusto
l’epilogo del film che
non trova altra
soluzione per
Giangurgoli del genere
descritto dal famoso
Nostradamus attraverso
la terribile quartina X,
10 suddetta. Séverine è
la giovane, bellissima
moglie del medico Pierre
Serizy (Jean Sorel), ma
è affetta da seri
problemi di relazione
che la portano a vivere
una vita affettiva
distorta , popolata di
sogni masochistici ad
occhi aperti. Essa ama
il marito ma è incapace
di avere rapporti intimi
con lui. Per questa
ragione si reca tutti i
pomeriggi presso una
casa d’appuntamenti in
una splendida Parigi
degli anni sessanta,
dove cerca, attraverso
la prostituzione, una
sorta di psicanalisi che
la porti ad uscire dalle
sue fobie e dalla sua
frigidezza. Qui Severine
si lega ad un giovane
gangster (Pierre
Clementi) che le offre
il brivido e
l’eccitazione di cui
sono piene le sue
fantasie. La situazione
diviene complicata e
pericolosa quando lei
decide di lasciare il
bordello. Il giovane
geloso attende il marito
di Séverine e gli spara
tre volte prima di
fuggire ed essere
catturato dalla polizia.
Il marito sopravvive ma
rimane in stato
comatoso. Il film
termina con Séverine che
fugge nuovamente dentro
le sue fantasie; ma
questa volta non sono
sogni erotici. Nella sua
mente il marito è di
nuovo in salute e lei lo
bacia con amore.
Secondo me è centrato
l’accostamento di questo
film con la
rappresentazione scenica
relativa all’illustr.
1, la configurazione
che ho immaginato di
Catanzaro. Giusto
l’epilogo del film che
non trova altra
soluzione per
Giangurgoli del genere
descritto dal famoso
Nostradamus attraverso
la terribile quartina X,
10 suddetta. Séverine è
la giovane, bellissima
moglie del medico Pierre
Serizy (Jean Sorel), ma
è affetta da seri
problemi di relazione
che la portano a vivere
una vita affettiva
distorta , popolata di
sogni masochistici ad
occhi aperti. Essa ama
il marito ma è incapace
di avere rapporti intimi
con lui. Per questa
ragione si reca tutti i
pomeriggi presso una
casa d’appuntamenti in
una splendida Parigi
degli anni sessanta,
dove cerca, attraverso
la prostituzione, una
sorta di psicanalisi che
la porti ad uscire dalle
sue fobie e dalla sua
frigidezza. Qui Severine
si lega ad un giovane
gangster (Pierre
Clementi) che le offre
il brivido e
l’eccitazione di cui
sono piene le sue
fantasie. La situazione
diviene complicata e
pericolosa quando lei
decide di lasciare il
bordello. Il giovane
geloso attende il marito
di Séverine e gli spara
tre volte prima di
fuggire ed essere
catturato dalla polizia.
Il marito sopravvive ma
rimane in stato
comatoso. Il film
termina con Séverine che
fugge nuovamente dentro
le sue fantasie; ma
questa volta non sono
sogni erotici. Nella sua
mente il marito è di
nuovo in salute e lei lo
bacia con amore.
IL
"SOCCORSO" DI SAN
VITALIANO
Ricordate il mio dilemma
al cospetto della
configurazione della
surrealtà mappale
di Catanzaro, e le due
domande che seguirono:
Giangurgolo,
da vecchia maschera
della Calabria, oggi
cosa è? Un “porco” che
sfugge alla giustizia?
Ma non può rappresentare
anche un certo “santo”,
camuffato da “porco” che
migra, in certo qual
modo come fu per San
Vitaliano, patrono di
Catanzaro, il quale come
si sa scappò dalla sua
Capua di cui fu
proclamato Vescovo
contro la sua volontà?
La fuga del santo finì
male perché venne
catturato, legato dentro
un sacco e gettato nel
fiume Garigliano.
Ma su di lui vi era la
presenza di Dio che lo
fece giungere incolume
fino ad Ostia dove venne
salvato da alcuni
pescatori, mentre Capua,
dimostratasi ingrata e
violenta, venne punita
da Dio con siccità,
peste e carestia.
In sintesi i fatti
occorsi a san Vitaliano,
“nelle mani di Dio”
appunto, possono
immaginarsi come il
decorso della sua
volontà per porre sulle
spalle del santo un
“grave”, che si può
immaginare come una
croce. Solo lui, ad
esempio di Gesù che
prese su di sé i peccati
del mondo, poteva essere
il “Cristoforo”
congeniale. Ecco che i
“gravi” in questione,
che inizialmente sono
quelli di Capua passano
in altre mani, in quelle
degli abitanti di
Catanzaro accesi dalla
fede nel cristianesimo
grazie all’opera di san
Vitaliano.
Per spiegare come può
essere compreso il male
racchiuso nel “grave” (o
croce) messo sulle
spalle di San Vitaliano
“camuffato” in sembianze
vergognose, riferendoci
ai fatti di Capua?
Il male di cui si parla
può essere paragonato a
quelli degli indemoniati
di Gadareni miracolati
da Gesù di cui si parla
nei tre Vangeli, di
Matteo, Marco e Luca.
Cito di seguito il passo
evangelico 8,28-34 di
Matteo che è il più
sintetico:
«In quel tempo, essendo
Gesù giunto all’altra
riva del mare di
Tiberiade, nel paese dei
Gadareni, due
indemoniati, uscendo dai
sepolcri, gli vennero
incontro; erano tanto
furiosi che nessuno
poteva più passare per
quella strada.
Cominciarono a gridare:
“Che cosa abbiamo noi in
comune con te, Figlio di
Dio? Sei venuto qui
prima del tempo a
tormentarci?”.
A qualche distanza da
loro c’era una numerosa
mandria di porci a
pascolare; e i demoni
presero a scongiurarlo
dicendo: “Se ci scacci,
mandaci in quella
mandria”.
Egli disse loro:
“Andate!”. Ed essi,
usciti dai corpi degli
uomini, entrarono in
quelli dei porci: ed
ecco tutta la mandria si
precipitò dal dirupo nel
mare e perì nei flutti.
I mandriani allora
fuggirono ed entrati in
città raccontarono ogni
cosa e il fatto degli
indemoniati. Tutta la
città allora uscì
incontro a Gesù e,
vistolo, lo pregarono
che si allontanasse dal
loro territorio.».
A questo punto occorre
fare buona attenzione
per traslare il detto
evangelico appena citato
e servircene per capire
la questione di San
Vitaliano in causa.
La cosa fondamentale che
occorre capire è come
smuovere e dove
riversare il “grave”, il
male, che nei Vangeli
vengono definiti demoni,
anzi negli altri due non
menzionati, quelli di
Marco e Luca, sono
Legioni (di demoni). Ma
questa definizione,
probabilmente, venne
introdotta per
identificarli nelle
Legioni romane, che
erano considerate
nemiche del popolo
israelita.
La mandria dei porci in
cui Gesù riversa i
demoni allegorizza il
“fatto” occulto che sta
dietro all’analogo
occorso a San Vitaliano,
che invece ha comportato
essere obbligato a
indossare abiti
femminili per essere
svergognato davanti a
tutta Capua. Occorre
immaginare l’azione di
Dio padre che manda i
suoi figli in sacrificio
per la redenzione umana:
il primo fu Gesù Cristo.
Naturalmente in San
Vitaliano non c’è questa
consapevolezza ma solo
la coscienza di dovere
andare incontro a gravi
sofferenze a causa del
Cristo in cui crede
fermamente. Il seguito
di questo santo, che
viene legato dentro un
sacco e gettato nel
fiume Garigliano, si
correla alla pazzia
della «mandria dei porci
che si precipitò dal
dirupo nel mare e perì
nei flutti», come sopra
raccontato sul conto dei
fatti evangelici sugli
indemoniati di Gadareni.
Secondo l’opinione della
gente, il porco era
simbolo di impurità che
impediva all’essere
umano di relazionarsi
con Dio e di sentirsi
accolto da Lui. Il mare
era il simbolo del caos
esistente prima della
creazione e che, secondo
la credenza dell’epoca,
continuava a minacciare
la vita.
Ma fin quanto durerà
l’azione salvifica ad
opera di San Vitaliano
per Catanzaro?
La fede in lui dei
catanzaresi, se non è
lontana dalla realtà la
mia visione della
surrealtà mappale
esibita all’inizio, non
è più come quella di un
tempo. E poi le cronache
odierne non mancano di
configurare il Sud
d’Italia intero nelle
panie di organizzazioni
malavitose che lo Stato
stenta a contrastare.
Ma la Calabria non ha
solo la faccia di
Giangurgolo.
La Calabria è l'Italia
arcaica nascente ripiena
di mitologia e che
passa, poco prima
dell'Unità d'Italia fino
alle Alpi, per il
glorioso Regno delle due
Sicilie invidiato dal
resto dei regni
d'Europa.
Anche di questa Calabria
ho scritto un saggio che
è presente sul web5.
Il titolo è “La prima
Italia, capanna del
cristianesimo”.
Ecco che si fa chiarezza
su ciò che è valso al
Sud la mia ipotesi
salvifica, simboleggiata
da S. Vitaliano di
Catanzaro. Occorreva
prima agire sull’anima
perché diventasse forte
abbastanza per tenersi
al riparo da corrosioni
dell’azione del male
rappresentata, appunto
dalla maschera calabrese
Giangurgolo. Ma sappiamo
che dietro questa
facciata c’era, secondo
una certa versione della
sua origine, qualcuno
che si prefiggeva di
combattere le azioni
malavitose che in
quest’epoca imperversano
l’intero Sud d’Italia e
non escluso il Nord.
Dunque, con l’anima al
sicuro, entro certi
limiti, in quest’epoca
conta concentrare ogni
sforzo per educare la
ragione che deve
concepire in sé una
Ecologia della Mente,
capace di mettere ordine
e armonia al pensiero
che deve potersi
integrare con quello di
altri. Solo così è
possibile rinunciare a
fagocitare in modo
fraudolento il frutto
della terra che si è
impoverita, e
soprattutto a non ordire
azioni omicide per
raggiungere un esagerato
bene personale.
Che cosa si intende per
Ecologia della Mente in
modo comprensibile?
Viene spiegato molto
bene nel libro “Ecologia
della mente” di Gregory
Bateson (Grantchester, 9
maggio 1904 – San
Francisco, 4 luglio
1980). Egli è stato un
antropologo, sociologo,
linguista e studioso di
cibernetica britannico,
il cui lavoro ha toccato
anche molti altri campi.
Cito la risposta di
Bateson alla domanda
suddetta che traggo da
internet:
«Beh... .più o meno
sono le cose di vario
tipo che accadono nella
nostra testa e nel
nostro comportamento...
e quando abbiamo a che
fare con altre
persone... e quando
andiamo su e giù per le
montagne.... e quando ci
ammaliamo e poi stiamo
di nuovo bene...
Tutte queste cose si
interconnettono e , di
fatto, costituiscono una
rete che, in un
linguaggio orientale, si
potrebbe chiamare
Mandala.
Io mi sento più a mio
agio con la parola
Ecologia, ma sono idee
che hanno molto in
comune.
Alla radice vi è la
nozione che le idee sono
interdipendenti,
interagiscono, che le
idee vivono e muoiono.
Le idee che muoiono,
muoiono perché non si
armonizzano con le
altre. È una sorta di
intrico complicato,
vivo, che lotta e che
collabora, simile a
quello che si trova
nelle boschi di
montagna, composto dagli
alberi, dalle varie
piante e dagli animali
che vivono lì –
un’ecologia, appunto.
All’interno di questa
ecologia vi sono temi
importanti di ogni
genere che si possono
enucleare e su cui si
può riflettere
separatamente.
Naturalmente si fa
sempre violenza al
sistema nel suo
complesso se si pensa
alle sue parti
separatamente; ma se
vogliamo pensare
dobbiamo fare così,
perché pensare a tutto
contemporaneamente è
troppo difficile... ».6
Ecco che si fa strada
l’azione della Scienza
sul piano umanistico e
tecnologico e non si può
negare che l’uomo deve
oggi a questo
cambiamento, operato
dalla cultura in ogni
senso e direzione, se si
sta incanalando in una
buona direzione. Dal
canto mio, non posso che
rendere testimonianza a
questa visione con delle
concezioni seguendo la
stessa strada, per certi
versi esoterica, seguita
per il presente saggio.
Ed è così che ho avuto
modo di scrivere il
saggio “I segni della
Terra nella visione di
Nostradamus”, ma ne ho
già fatto cenno in
precedenza
nell’introduzione.7
NOTE
1:
Tratto dal saggio
dell’autore “I
segni della Terra nella
visione di Nostradamus”
2:
A Capua subì ogni genere
di insinuazioni e
derisioni da parte dei
suoi nemici che lo
accusarono di avere
tendenze particolari.
Per svergognarlo davanti
ai fedeli, i nemici con
uno stratagemma
riuscirono a farlo
comparire in pubblico
con abiti femminili. Il
santo si difese con
molta abilità; dopo che
scoprì il complotto si
allontanò dalla città.
La sua fuga fu breve:
venne catturato, legato
dentro un sacco e
gettato nel Garigliano.
Su di lui vi era la
presenza di Dio che lo
fece giungere incolume
fino ad Ostia dove venne
salvato da alcuni
pescatori, mentre Capua,
dimostratasi ingrata e
violenta, venne punita
da Dio con siccità,
peste e carestia.
Papa Callisto II lo
avrebbe poi inviato
insieme a quello di
Sant’ Ireneo di Lione e
di San Fortunato di Todi
a Catanzaro. Qui nel
1311 Pietro Ruffo, conte
di Calabria, fece
costruire una cappella
in cattedrale per
deporle e venerarle.
Durante l’ultimo
conflitto mondiale, a
causa dei bombardamenti,
la cattedrale venne
distrutta; nel 1960 fu
ricostruita e con essa
anche la cappella che
contiene il corpo di san
Vitaliano da cui
trasuderebbe, come
avviene per san Nicola
di Bari e san Felice di
Nola, un liquido
miracoloso, detto manna.
Il culto di san
Vitaliano è diffuso in
tutta la Campania ed
ovviamente in Calabria;
Catanzaro lo invoca
contro ogni calamità,
particolarmente contro i
terremoti.
La domenica in albis,
una volta, si celebrava
la festa del patrocinio
per ricordare la
protezione del santo
sulla città durante il
violentissimo terremoto
del 1783. Popolarmente
san Vitaliano ha dato
anche il suo nome a
Catanzaro: infatti il
capoluogo calabrese è
definito come la città
delle tre V: vento,
velluto e san Vitaliano.
3:
Capua, oggi indicata con
Capua antica o Capua
arcaica per evitare
ambiguità, è una città
sorta nel IX secolo a.C.
sul luogo dell’attuale
comune campano di Santa
Maria Capua Vetere. Con
una storia di oltre
diciotto secoli è stata
città osca, etrusca,
sannita e romana,
divenendo, nel periodo
di massimo splendore,
una delle città più
grandi del mondo.
Distrutta e saccheggiata
dai Saraceni nel IX
secolo, la popolazione
si trasferì a Casilinum
fondando la Capua
moderna. Durante la
seconda guerra punica,
divenne uno dei
principali obiettivi di
Annibale: nel 216 a.C.,
dopo la battaglia di
Canne (2 agosto),
l’esercito cartaginese
occupò la città e la
fece diventare
avamposto, militare e
politico, per le
“scorrerie” nell’Italia
meridionale, alla
ricerca anche di alleati
contro Roma, nella
speranza di una
successiva conquista
della capitale. Annibale
ed il suo esercito vi
passarono l’inverno, il
condottiero ne
approfittò per portare
avanti la parte politica
della sua azione: furono
i cosiddetti “ozi di
Capua” che secondo molti
storici, indebolirono i
soldati e sarebbero
stati una delle cause
della futura sconfitta
cartaginese. Classe
dirigente e popolazione
capuana appoggiarono la
campagna di Annibale,
città troppo fiera per
sottostare a Roma, la
storia però volle che a
vincere furono i romani,
così nel 211 a.C. la
città venne umiliata da
Roma, che la ridusse a
semplice prefettura
privandola di
magistratura, senato e
classe dirigente,
divenne un grosso
deposito merci da lì il
termine “il granaio di
Roma”.
http://it.wikipedia.org/wiki/Capua_antica
4:
http://it.wikipedia.org/wiki/Giangurgolo
5:
http://nazionali.org/nicola/collaboraz/gb_prima_italia.html
6:
http://www.ilnarratore.com/visions/collection/bateson/Batesonfirst.PDF
7:
I segni della Terra
nella visione di
Nostradamus
|