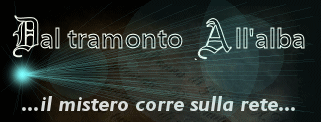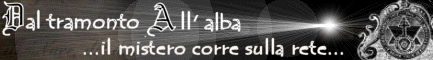|
|
 |
| |
|
Castello dei
Settanta Fantasmi |
|
a cura di Stefano Tansini |
|
|
|
 A
ridosso del vicino territorio cremonese, in prossimità della sponda occidentale
dell’Adda, esiste una località che, posta ai margini delle più trafficate
arterie di comunicazione, protetta da un impenetrabile scudo di alberi e dal
lento incedere del fiume, ha fatto del suo isolamento lo strumento principe con
il quale serbare all’interno delle sue ataviche mura le storie più note ed
suggestive dell’intero Lodigiano. A
ridosso del vicino territorio cremonese, in prossimità della sponda occidentale
dell’Adda, esiste una località che, posta ai margini delle più trafficate
arterie di comunicazione, protetta da un impenetrabile scudo di alberi e dal
lento incedere del fiume, ha fatto del suo isolamento lo strumento principe con
il quale serbare all’interno delle sue ataviche mura le storie più note ed
suggestive dell’intero Lodigiano.
Le origini di Maccastorna1
si perdono nella notte dei tempi, forse ai lontani anni della dominazione
Longobarda, ma è solo dal XIII secolo che si hanno le prime certe notizie del
nucleo abitato e del suo fortilizio2:
passati, dopo varie vicissitudini, alla famiglia dei Vincemala, furono da questi
venduti, nel 1381, prima ai Visconti ed in seguito, nel 1385, ai Bevilacqua i
quali, con alterne fortune, restarono i signori di queste terre fino alla fine
dell’Ottocento3
. Il castello, elemento caratterizzante ed essenza stessa del paese, è
un’imponente struttura dalla forma vagamente trapezoidale che, nonostante i
continui rifacimenti subiti, non sembra aver perso nulla dell’antica austerità.
Originali sono le due balconate, risalenti al 1400, mentre non esiste quasi più
traccia dei torrioni dell’antica rocca, abbassati di livello, e di gran parte
delle originarie mura, demolite dopo il 1860, ormai pericolanti in seguito ad un
devastante incendio4.
“A Maccastorna - per chi ci crede – […] ci sarebbero […] raffinate ombre
evanescenti che fanno le pendolari con l'aldilà, voci e forme improvvise che
emergono dal buio mentre i grilli tacciono e la luna piena rotola bassa sulla
linea scura dell'orizzonte”5.
Soprattutto una ben precisa parte della rocca, carica di fascino e capace di
insinuare macabre suggestioni, alimenta quell’aurea di mistero e reverenziale
timore che ancora aleggia sull’intero castello. Meglio conosciuto come “Pozzo
delle Spade”, questo luogo è in realtà ciò che resta di un’antica cavità, ora
chiusa, nella quale venivano gettati i cadaveri degli sventurati morti per mano
dei signori della rocca o uccisi nel corso dei numerosi assedi che si
succedettero a Maccastorna, affinché spade e lame conficcate nelle pareti del
pozzo ne straziassero orrendamente le carni6.
Curioso rendersi conto di come, tra gli anziani contadini, ancora circolino
memorie di lugubri e lamentose voci provenienti dai bui recessi del castello…7
Nel 1486, signore di Maccastorna era Galeotto Bevilacqua8.
Senza eredi maschi, confidando in un beneplacito ducale rilasciatogli da
Ludovico il Moro, si adoperò fino agli ultimi giorni di vita per far si che i
propri beni feudali, in realtà vincolati da rigide leggi dinastiche, finissero
in eredità alle figlie Bona e Lucia, ma, all’indomani della morte, i suoi
fratelli Gherardo e Bonifacio, riuscirono a diventarne i legittimi proprietari
della rocca. Le figlie di Galeotto mai accettarono la perdita della “loro”
eredità, e, confidando nel prezioso aiuto di Teodoro Trivulzio9,
al tempo marito di Bona, ordirono la loro vendetta: divenuti Riccardo e
Marcantonio Bevilacqua signori della rocca in seguito alla morte tanto di
Gherardo quanto di Bonifacio, Teodoro si presentò da loro come parente e amico,
ma, appena avutane l’occasione, pugnalò a tradimento prima Riccardo e poi, con
l’inganno, il fratello10.
Questo racconto, in realtà piuttosto sconosciuto, è stato forse il pretesto per
alimentare, soprattutto nel passato, le voci in merito all’esistenza di
indefinibili presenze dimoranti nella rocca del Bel Pavone, ma, in realtà, è un
più noto fatto di sangue che, attualmente, si propone come miglior artefice
delle voci e delle dicerie che, soprattutto nelle afose notti estive, circolano
a Maccastorna e nelle campagne vicine.
Nel 1405, Cabrino Fondulo, fedele capitano delle milizie agli ordini della
potente e sovrana famiglia cremonese dei Cavalcabò, ottenne in dono da Carlo
Cavalcabò, al tempo signore di Cremona, il castello ed il contado di Maccastorna.
Cabrino è stato a lungo l’indiscusso padrone del maniero e, mai lesinando quella
crudeltà di governo che lo rese temuto e rispettato, si operò per attuare
radicali rinnovamenti all’intera rocca, perseguendo il dichiarato scopo di
conferire al castello sia l’aspetto di una fastosa corte sia l’immagine di un
imponente e funzionale complesso fortificato11. |
|
Nel 1406, Cabrino giudicò
fossero ormai giunti i tempi per ampliare i confini di un dominio considerato
stretto e soffocante ogni giorno di più e, tradendo la fiducia dei suoi antichi
benefattori, ordì un vile e crudele stratagemma per impossessarsi della città di
Cremona. Si narra che nella la notte del 24 luglio 140612
le stanze nelle quali trovarono riposo Carlo Cavalcabò, i suoi fratelli Giacomo
e Ludovico, nonché il loro fidato compagno Andreasio - dopo un luculliano
banchetto e abbondanti libagioni, se si vuol presta r
fede alla versione più nota della leggenda - furono mute testimoni di un
efferato delitto: i sicari di Cabrino uccisero nel sonno gli ospiti e tutte le
settanta persone che li accompagnarono nella rocca13.
“Quando il vento soffia tra feritoie e merlature […] e quando la luna piena
rotola sull'orizzonte, chissà, fra quelle anime errabonde nel castello di
Maccastorna potrebbe anche esserci quella di Cabrino Fondulo, con un'altra
ostinata ambizione: quella di cancellare un destino scritto con l'orrore.
Qualcuno incominciò, nell'800, anche a trovare giustificazione a quei fantasmi,
scrivendo: «Ferma credenza già da gran tempo era fitta nell'animo di tutti che
la Rocca di Maccastorna fosse abitata dalle anime gemebonde di quei tanti
Ghibellini cremonesi che nell'assedio dell'anno 1270 furono trucidati. E i
fuochi fatui e il fosforico marciume de' salici che sempre in quei grassi campi
abbondano altro non erano, a detta loro, che apparizioni di quelle meschine
anime; e il notturno sibilo di alcuni gorghi sia del Po che dell'Adda ivi
costeggianti, dicevasi il gemer loro, e per ovviarne i funesti auguri nelle
superstiziose pratiche vi avevano voga senza le quali il volgo si sarebbero
creduti esposti ad ogni sorta d'insuperabili sciagure...»”14.
Nel territori lodigiano e nella vicina provincia di Cremona sono pochi coloro
che all’oscuro dell’alone di mistero che aleggia sulla rocca di Maccastorna. Le
leggende che gravitano intorno a queste ataviche mura, invero, sono relegate dai
più in una dimensione favolistica e percepite come fantasiose note di colore.
“Ma, quando il vento soffia forte tra merli e caditoi […] allora sembra proprio
di sentire delle voci, dei suoni umani che rimbombano. […] E poi […] ci sono
porte che sbattono improvvisamente, passaggi murati, pozzi segreti”
15. r
fede alla versione più nota della leggenda - furono mute testimoni di un
efferato delitto: i sicari di Cabrino uccisero nel sonno gli ospiti e tutte le
settanta persone che li accompagnarono nella rocca13.
“Quando il vento soffia tra feritoie e merlature […] e quando la luna piena
rotola sull'orizzonte, chissà, fra quelle anime errabonde nel castello di
Maccastorna potrebbe anche esserci quella di Cabrino Fondulo, con un'altra
ostinata ambizione: quella di cancellare un destino scritto con l'orrore.
Qualcuno incominciò, nell'800, anche a trovare giustificazione a quei fantasmi,
scrivendo: «Ferma credenza già da gran tempo era fitta nell'animo di tutti che
la Rocca di Maccastorna fosse abitata dalle anime gemebonde di quei tanti
Ghibellini cremonesi che nell'assedio dell'anno 1270 furono trucidati. E i
fuochi fatui e il fosforico marciume de' salici che sempre in quei grassi campi
abbondano altro non erano, a detta loro, che apparizioni di quelle meschine
anime; e il notturno sibilo di alcuni gorghi sia del Po che dell'Adda ivi
costeggianti, dicevasi il gemer loro, e per ovviarne i funesti auguri nelle
superstiziose pratiche vi avevano voga senza le quali il volgo si sarebbero
creduti esposti ad ogni sorta d'insuperabili sciagure...»”14.
Nel territori lodigiano e nella vicina provincia di Cremona sono pochi coloro
che all’oscuro dell’alone di mistero che aleggia sulla rocca di Maccastorna. Le
leggende che gravitano intorno a queste ataviche mura, invero, sono relegate dai
più in una dimensione favolistica e percepite come fantasiose note di colore.
“Ma, quando il vento soffia forte tra merli e caditoi […] allora sembra proprio
di sentire delle voci, dei suoni umani che rimbombano. […] E poi […] ci sono
porte che sbattono improvvisamente, passaggi murati, pozzi segreti”
15. |
|
NOTE
|
|
1:
Il nome del paese tradisce antiche
connivenze con le vicine terre cremonesi: il toponimo
deriverebbe infatti dall’antica famiglia ghibellina
originaria di Cremona impossessatasi, nel corso dei convulsi
anni medievali, dell’antica rocca del Belpavone (o Bel
Pavone, conosciuta anche con il nome di Malgrato),
importante luogo strategico in prossimità dell’Adda,
imponendo successivamente al castello di allora ed al vicino
contado il proprio nome gentilizio. Cfr. Giovanni Agnelli,
Lodi e il suo territorio…, pag. 984, cit.
2:
“Si n arra che le prime notizie della presenza di
fortificazioni sul luogo risalgono alla metà del XIII° (sic)
e che, intorno al 1720, banditi dai guelfi vittoriosi, i
ghibellini cremonesi dovessero arroccarsi a Maccastorna,
dove trovarono rifugio nel castello […] che divenne perciò
campo di accaniti assalti e fu dopo breve tempo raso al
suolo”. Maria Luisa Gatti Perer – Licia Carubelli – Licia
Parvis Marino, Maccastorna bene culturale, Codogno, 1980,
pag. 11.
3:
Per una generale conoscenza dei fatti storici inerenti il
paese di Maccastorna ed il suo castello cfr.: Giovanni
Agnelli, Lodi ed il suo territorio…, cit.; Giuseppe Boni, La
Rocca di Maccastorna, Lodi, 1909; Maria Luisa Gatti Perer –
Licia Carubelli – Licia Parvis Marino, Maccastorna…, cit.;
Giovanni Cairo - Francesco Giarelli, Codogno e il suo
territorio…, cit..
4:
Cfr. Maria Luisa Gatti Perer – Licia Carubelli – Licia
Parvis Marino, Maccastorna …, cit.
5:
I settanta fantasmi del Castello, in Ferruccio Pallavera (a
cura di), Il Lodigiano e i suoi percorsi – Enciclopedia
multimediale del Lodigiano, Editing Italia, 1997.
6:
Nella tradizione locale la rocca di Maccastorna è anche
conosciuta come “il Castello dei settanta fantasmi”. Il
relativo isolamento del luogo unito alle suggestioni che
solo edifici antichi e carichi di storia sanno offrire hanno
fatto in modo che le sensazioni generatesi in particolari
circostanze - l’ululato del vento durante i temporali,
l’atmosfera ovattata delle giornate nebbiose, il verso di
qualche animale notturno - venissero facilmente scambiate
per lamenti spettrali ed urla infernali, conseguentemente
alimentando la leggenda della dimora infestata. Ancora oggi,
soprattutto nei racconti folcloristici o nelle storielle per
bambini che si raccontano nelle campagne e nei paesi vicini,
il castello di Maccastorna ed il suo corollario di leggende,
sono i principali protagonisti.
7:
“Una storia antica, che ricordava
benissimo anche Angelo Asti, 92 anni, il più anziano degli
abitanti del paese, ex-bersagliere sui campi della grande
guerra: «Anche quando ero giovane si parlava del pozzo delle
spade. Dentro - raccontava mentre era al lavoro nei campi
della Cascina Canova - ci buttavano i cadaveri degli
assassinati per farli sparire rapidamente». «Nel pozzo -
conferma Antonio Biancardi - le spade erano infisse con
sporgenze». Il pozzo è nel lato sud del castello, non
lontano da quello che originariamente era il ponte levatoio
e a pochi metri da un passaggio segreto (anche questo da
scavare) che dovrebbe portare all'esterno delle mura, in
direzione della chiesa. E' in quel fondo nero - attualmente
coperto da una grata - che si scorge il volto dell'anonimo
che ha tessuto la leggenda delle anime vaganti e si
ascoltano gli echi di urla strazianti che si inabissano”. I
settanta fantasmi…, cit.
8:
Signore di Maccastorna dal 1417, nel 1437 ottenne il titolo
di Conte da Filippo Maria Visconti, il quale, nel 1440, in
segno di gratitudine per i servigi resigli, gli concesse il
privilegio di esenzione dai tributi. .Cfr. Giovanni Agnelli,
Lodi e il suo territorio…, cit.
9:
Appartenente ad una antica ed illustre famiglia milanese, fu
capitano presso gli Aragonesi di Napoli poi combatté per i
re di Francia, ottenendo il marchesato di Pizzighettone, e
per la Repubblica Veneta. Fu tra gli alti ufficiali di
Francesco I alla battaglia di Pavia (1525) e ricondusse
oltralpe i resti delle truppe francesi. Ibid.
10:
Cfr. I Settanta fantasmi…, cit.
11:
Nel 1402, in seguito alla morte di Gian Galeazzo Visconti,
diverse città lombarde tentarono di sottrarsi al dominio
visconteo. Cremona in particolare scelse come proprio
signore Ugolino Cavalcabò. Nonostante alcune importanti
conquiste militari, tra cui la rocca di Maccastorna, Ugolino
cadde in breve tempo prigioniero di Giovanni Maria Visconti,
nuovo Duca di Milano, e, conseguentemente, fu costretto a
cedere il potere al nipote Carlo. Questi, come atto di
liberalità, consegnò poi Maccastorna ed il suo territorio al
fido collaboratore Cabrino Fondulo. È su queste premesse che
si svilupparono poi i fatti sui quali poggia la leggenda che
ancora vive nel piccolo borgo abduano. A titolo di esempio:
Maria Luisa Gatti Perer – Licia Carubelli – Licia Parvis
Marino, Maccastorna …, cit.
12:
Ibid. La data è puramente ipotetica: alcune tradizioni
orali, per esempio, fanno risalire il delitto al 26 luglio,
altre al 14 luglio, altre ancora al 14 agosto. A quest’ultima
data è legato un particolare aneddoto. Ogni anno, alla
vigilia di ferragosto, coloro che risiedono nel castello,
abbandonano la loro dimora per farvi ritorno solamente dopo
la festa dell’Assunta: tradizione vuole che Cabrino Fondulo
e Carlo Cavalcabò si fronteggino l’un l’altro a colpi di
spada, “disturbando” i presenti con fastidiose cacofonie.
13:
Cabrino Fondulo ottenne il massimo vantaggio perseguibile da
questo omicidio: la signoria di Cremona. Mantenne il potere
fino al 1425 quando, ormai screditato agli occhi dei
Visconti, fu da questi giustiziato. Cfr. Giovanni Agnelli,
Lodi e il suo territorio…, cit.
14:
Cfr. I Settanta fantasmi…, cit.
15:
Ibid. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|